Fondation Cartier, un luogo di libertà. Intervista a Isabelle Gaudefroy
Intervista a tutto campo alla direttrice della programmazione e dei progetti artistici della Fondation Cartier pour l’art contemporain di Parigi, curatrice della mostra dedicata all’architetto giapponese Junya Ishigami.

Alla Fondation Cartier pour l’art contemporain di Parigi, Isabelle Gaudefroy si occupa della direzione della programmazione e dei progetti artistici. Coordina le mostre, gli eventi e i preziosi cataloghi prodotti dalla fondazione, e parallelamente s’impegna come curatrice di alcune grandi esposizioni, tra cui quella ancora in corso su Junya Ishigami, Freeing Architecture. A quasi vent’anni dal suo ingresso nella “scatola di vetro” di Jean Nouvel, Gaudefroy costruisce un ritratto entusiasta dell’istituzione parigina, che per lei è innanzitutto un luogo di libertà. La libertà tipica di un ente privato, che può definire la propria programmazione senza vincoli esterni; la libertà di reinventare a ogni allestimento gli spazi del plan libre di un museo senza pareti; la libertà, infine, che la fondazione vuole garantire agli artisti invitati, costituendosi come una piattaforma di supporto (sul piano spaziale, economico, logistico), un contesto e uno sfondo per la realizzazione ottimale dei loro progetti.
L’INTERVISTA
Qual è il suo ruolo all’interno della Fondation Cartier?
La direzione della fondazione è suddivisa in diversi settori di competenza: esiste un direttore generale, Hervé Chandès, ma anche la direzione amministrativa e finanziaria, la direzione della comunicazione e la direzione della collezione. Mi occupo della direzione della programmazione e dei progetti artistici.
Quale percorso di studi ha seguito e come si è sviluppata la sua carriera prima di arrivare alla Fondation Cartier?
Il mio percorso di formazione è decisamente diversificato: ho studiato giurisprudenza, tedesco e storia dell’arte. Poi ho lavorato per quattro anni al Théâtre des Amandiers di Nanterre, dove mi occupavo di produzione nell’ambito del teatro musicale contemporaneo e dell’opera contemporanea. Era un’attività estremamente multidisciplinare, che mi si addiceva molto. Lavoravamo con artisti di campi diversi: soprattutto compositori, ma anche artisti figurativi, scenografi, coreografi.
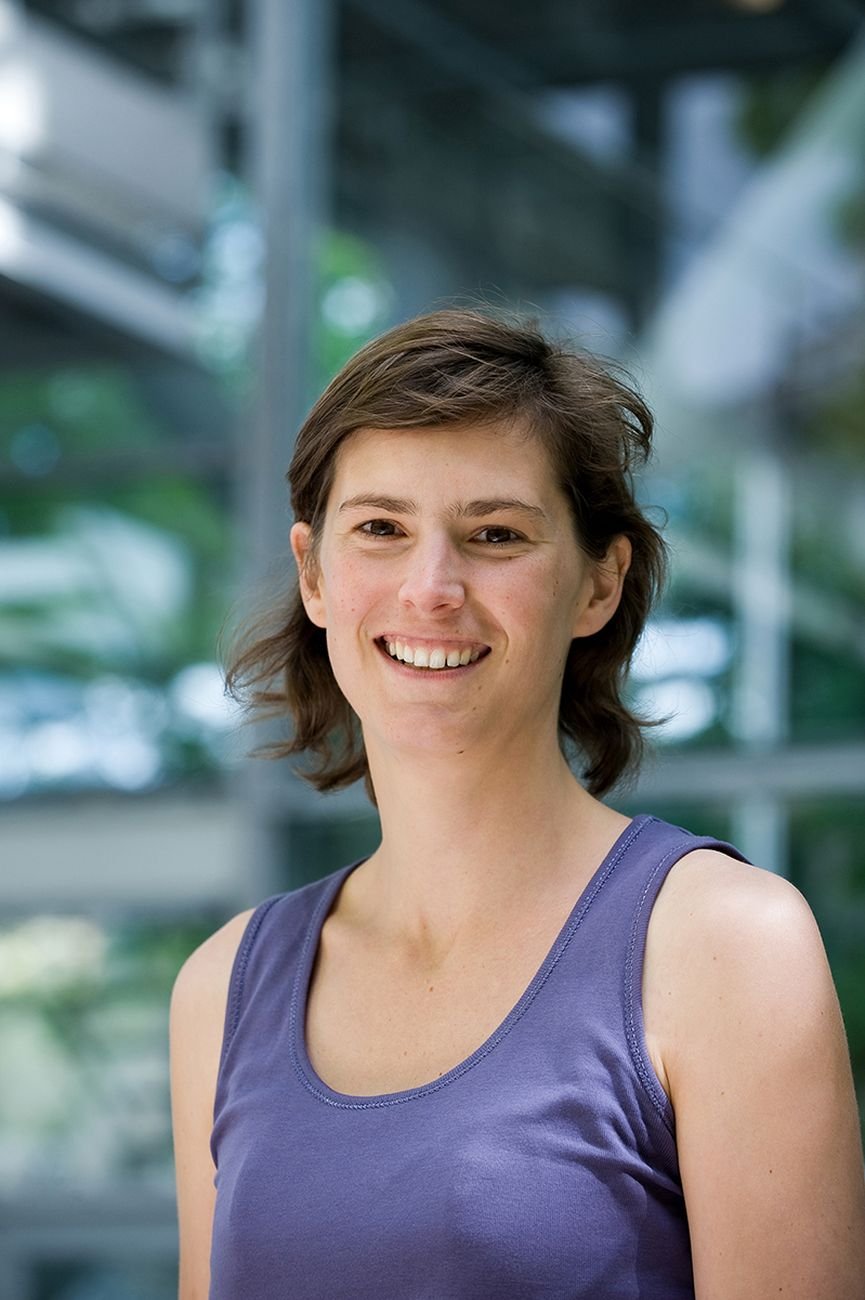
Isabelle Gaudefroy, direttrice della programmazione e dei progetti artistici della Fondation Cartier pour l’art contemporain © Olivier Ouadah
Quando è arrivata alla Fondation Cartier e quali ruoli ha ricoperto all’interno di questa istituzione?
Nel 1999 si è liberato un posto come programmatore degli spettacoli e delle performance delle Soirées Nomades, un’iniziativa lanciata dalla fondazione nel 1994 che invita un artista (un designer, un videomaker, un coreografo, un artista figurativo, ecc..) a reinventare per una sera gli spazi dell’edificio e del giardino. Queste serate sono momenti di grande libertà. La posizione mi interessava moltissimo e corrispondeva al mio profilo multidisciplinare. Ho ricoperto questo ruolo per più di dieci anni, fino al 2011, ma nel frattempo mi sono anche occupata della curatela di molte mostre, sia monografiche che tematiche. Spesso sono stata incaricata di seguire i progetti espositivi legati alle personalità più atipiche, come l’artista francese Pierrick Sorin [261 boulevard Raspail, Paris XIV, 2001, N.d.R.] e lo sceneggiatore e attore giapponese Takeshi Kitano [Gosse de peintre, 2010, N.d.R.], ma anche la grande esposizione tematica sul rock and roll [Rock’n’roll 39-59, 2007, N.d.R.]. In seguito, quando Hervé Chandès ha avviato una ristrutturazione generale della fondazione e ha creato le diverse sezioni della direzione che esistono oggi, mi ha proposto di diventare direttrice della programmazione e dei progetti artistici. Mi occupo di coordinare le mostre, le Soirées Nomades e le pubblicazioni. In parallelo, continuo anche a curare in prima persona alcune esposizioni, perché credo sia molto importante restare vicino ai contenuti.
Ha curato, ad esempio, la mostra ancora in corso su Junya Ishigami, Freeing Architecture [fino al 9 settembre, N.d.R.]. Perché avete scelto di dedicare la prima grande monografica di architettura mai organizzata dalla Fondation Cartier proprio a Ishigami?
Anche quando lavoriamo con personalità che non provengono dal campo delle arti figurative, abbiamo cura di selezionare qualcuno che sappia sfruttare appieno le potenzialità dell’edificio di Jean Nouvel, che è essenzialmente concepito come una pagina bianca, uno spazio libero a disposizione dell’iniziativa dell’artista. Abbiamo scelto Junya Ishigami perché, avendo seguito gli sviluppi della sua carriera negli ultimi dieci anni, ci eravamo convinti che sapesse cogliere le opportunità offerte da questa architettura, per creare al suo interno un proprio universo. Come ci auguravamo, Ishigami ha concepito un progetto di architettura a sé, un’esposizione su misura, che utilizza l’edificio di Jean Nouvel come il proprio contesto.
Parlando del progetto di Jean Nouvel, la Fondation Cartier è a tutti gli effetti un museo senza pareti. Dopo molti anni di lavoro con questo spazio atipico, crede che questa soluzione architettonica radicale abbia pagato?
Senza dubbio. Quando l’edificio aprì le porte, più di vent’anni fa, in molti si stupirono del fatto che la fondazione accettasse di lavorare in un museo senza muri. Ma la scommessa di Jean Nouvel era ben chiara tanto all’architetto quanto al committente: se i muri ci sono è difficile toglierli, mentre in uno spazio libero è sempre possibile creare partizioni temporanee. A ogni mostra reinventiamo il nostro piano terra, mentre se avessimo delle piccole sale circondate di muri non potremmo fare altro che attaccarci dei quadri.

América Latina 1960 2013, exhibition view at Fondation Cartier pour l’art contemporain, Parigi novembre 2013 aprile 2014 © Luc Boegly
Come descriverebbe il ruolo della Fondation Cartier nel contesto parigino?
A differenza del 1994, quando la fondazione aprì la sede di Boulevard Raspail, oggi a Parigi esistono molte altre istituzioni private dello stesso tipo, tra cui la Fondation Louis Vuitton e la Fondation Lafayette, ciascuna con il suo grande architetto di riferimento. A mio parere l’architettura delle tre fondazioni riflette molto fedelmente la diversità del loro approccio. L’edificio che Frank Gehry ha costruito per Vuitton è realmente un monumento che emerge dal suo contesto, e al suo interno contiene delle bellissime sale d’esposizione, d’impostazione molto classica, dove ogni dettaglio è studiato con la massima cura per garantire le migliori condizioni di conservazione e visibilità delle opere esposte. La Fondation Lafayette di OMA, invece, è uno spazio altamente sperimentale, innovativo. Da parte nostra, come ho già accennato, l’edificio di Jean Nouvel è soprattutto un’ode alla libertà: rende tutto possibile, è molto presente senza essere ingombrante. È anch’esso un monumento, ma in maniera diversa e più discreta rispetto alla Fondation Louis Vuitton.
Quali sono le sue specificità rispetto agli altri luoghi d’esposizione privati e pubblici della città, anche a partire dalle qualità dell’edificio?
La programmazione e il modus operandi della nostra istituzione derivano direttamente dall’architettura che la ospita: mettiamo il nostro edificio a disposizione degli artisti, e li accompagniamo nella realizzazione di un progetto che è veramente loro. Noi conosciamo a fondo le potenzialità, le criticità, i limiti logistici dei nostri spazi, e sulla base di queste competenze supportiamo e indirizziamo gli artisti, ma cercando di interferire il meno possibile. Nel caso di Ishigami, ad esempio, pur essendo io ufficialmente la curatrice della mostra, ogni singolo elemento in esposizione è stato selezionato direttamente dall’architetto. Da questo punto di vista, il nostro approccio è anche radicalmente diverso da quello di un qualsiasi museo pubblico. Spesso un museo è tenuto a essere esaustivo, a presentare l’opera completa di un artista, a sviluppare un meta-discorso attorno a essa, talvolta a svolgere una funzione quasi pedagogica. In breve, l’approccio principale di un museo è quello di mostrare un’opera a un pubblico; per noi, la cosa più importante è fornire a ogni artista uno spazio per la sua libera creazione, da accompagnare attraverso l’intermediario della nostra curatela scientifica.
Chi finanzia la Fondation Cartier?
Tutte le attività sono finanziate interamente da Cartier. Non facciamo fundraising, non abbiamo partnership commerciali, non riceviamo sovvenzioni pubbliche, né ci appoggiamo su altri mecenati.

Beauté Congo 1926 2015 Congo Kitoko, exhibition view at Fondation Cartier pour l’art contemporain, Parigi luglio novembre 2015 © Luc Boegly
La partnership con la Power Station of Art di Shanghai segna lo “sbarco” della Fondation Cartier in Asia. Quali sono gli obiettivi di questo scambio?
Alla Power Station of Art abbiamo messo in mostra una buona parte della collezione permanente della fondazione, che si è costruita negli anni a partire dalla sua programmazione. Abbiamo acquisito alcune delle opere esposte (spesso commissionate specificamente per le nostre mostre) e altre degli stessi artisti che abbiamo ospitato. Mi preme sottolineare che le nostre mostre non nascono per esporre la collezione; piuttosto, succede l’inverso, le mostre sono l’occasione per arricchire e completare la collezione stessa. La mostra di Shanghai nasce nell’ambito di un progetto più ampio finalizzato alla valorizzazione della collezione, per la quale non abbiamo spazi d’esposizione permanenti qui a Parigi, che ha portato anche alla creazione di un settore specifico della direzione dedicato a essa.
Quali eventi sono in preparazione per l’autunno 2018?
Innanzitutto una grande mostra sulla geometria nell’America Latina [Géométries du Sud. Du Méxique à la Terre de Feu, che aprirà il 12 ottobre 2018, N.d.R.] al cui interno mostreremo anche il lavoro di due architetti: il paraguayano Solano Benítez e il boliviano Freddy Mamani. L’obiettivo della mostra è mettere in luce la filiazione tra l’arte precolombiana e le opere degli artisti sudamericani contemporanei, molto meno esplorata del loro legame con il modernismo di ispirazione europea. Sarà una mostra coloratissima, del tutto diversa da quella in corso sull’architetto giapponese: di fatto, proprio come Ishigami, qui alla fondazione non siamo interessati a costruire uno stile, un’immagine riconoscibile, ma reinventiamo il nostro metodo e le nostre estetiche a ogni progetto.
‒ Alessandro Benetti
 1 / 12
1 / 12
 2 / 12
2 / 12
 3 / 12
3 / 12
 4 / 12
4 / 12
 5 / 12
5 / 12
 6 / 12
6 / 12
 7 / 12
7 / 12
 8 / 12
8 / 12
 9 / 12
9 / 12
 10 / 12
10 / 12
 11 / 12
11 / 12
 12 / 12
12 / 12
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

















