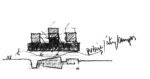Verso la Biennale di Architettura. Intervista alle direttrici
Yvonne Farrell e Shelley McNamara, fondatrici dello studio Grafton Architects, raccontano come sarà la prossima Biennale di Architettura di Venezia. A pochi giorni dall’opening.

“Come un corpo unico, nel quale ogni progetto si lega a un altro”. Così le architette Yvonne Farrell e Shelley McNamara definiscono il lavoro svolto insieme nel loro studio – Grafton Architects, fondato nel 1978 a Dublino – in quattro decenni di attività. Un traguardo suggellato quest’anno dall’incarico di curatrici della 16. Mostra Internazionale di Architettura, organizzata dalla Biennale di Venezia e presieduta da Paolo Baratta. Formatesi alla Scuola di Architettura della University College, nella capitale irlandese, attraverso il loro sodalizio professionale hanno raggiunto risultati di prestigio; tra questi, la medaglia d’oro del Royal Institute of the Architects of Ireland RIAI per il progetto dell’Università Bocconi – “È molto interessante vedere quanta luce sia in grado di attrarre e raccogliere questo edificio quando a Milano c’è il sole”, ci ha raccontato Farrell – e il Leone d’Argento alla Biennale Architettura 2012. Proprio da tale riconoscimento prende avvio la nostra conversazione.
Alla Biennale curata da David Chipperfield avete presentato il vostro progetto del Campus UTEC dell’Università di Lima, in Perù, insieme all’opera dell’architetto Paulo Mendes da Rocha. Esiste una “linea di contatto” tra quella partecipazione e il tema della vostra mostra, Freespace?
Shelley McNamara: È interessante notare come un’idea conduca verso un’altra. Freespace ha alcune delle sue radici nel nostro lavoro per Common Ground. In particolare la prima delle due sezioni speciali – Close Encounter, meetings with remarkable projects – ha sedici partecipanti che mostrano lavori frutto di ricerche su architetti del passato. In un certo senso, è la continuazione di una delle volontà espresse da Chipperfield e definisce una connessione fra l’architettura e i suoi modelli storici: riferimenti con i quali misurarsi in un’ottica di rinnovamento.
Yvonne Farrell: Abbiamo apprezzato il tema Common Ground e abbiamo pensato fosse possibile definire una continuità. Partecipare alla Biennale è sempre un grande onore [2002, 2012, 2016: queste le edizioni alle quali hanno preso parte, N.d.R.] ma è anche l’occasione per imparare qualcosa di nuovo: l’invito è infatti presentare il tuo lavoro a un ampio pubblico. Dunque si esce dall’architettura – e dai suoi confini – e la si osserva da altre prospettive.

Grafton Architects, Freespace undercroft, Università Luigi Bocconi, Milano 2008
Avete fissato nel Manifesto Freespace le coordinate teoriche della mostra. Cosa avete chiesto ai partecipanti?
S.McN.: La stesura del Manifesto, nel quale sono espressi i valori che intendiamo veicolare, ha contribuito alla scelta degli architetti selezionati. A ciascuno abbiamo chiesto di definire un messaggio chiaro sia per i loro colleghi, sia per il pubblico generico. Tutti hanno impiegato grande passione per raggiungere un obiettivo che, prima di tutto, è di tipo comunicativo. Immaginare l’atmosfera della mostra ha comportato poi una decisione cruciale. Prima di tutto, abbiamo ritenuto fosse fondamentale valutare le diverse qualità spaziali dei due edifici. Per noi, le Corderie e il Padiglione Centrale sembrano quasi un “duo di partecipanti” alla mostra! Quando un visitatore si recherà alla Biennale Architettura 2018, a colpirlo sarà il modo in cui verranno presentate le Corderie: si tratta di un edificio industriale, con quell’aria misteriosa, quasi malinconica. Intendiamo celebrarne la spazialità. La grande sfida in termini di design è stata consolidare questa atmosfera con l’aspetto del Padiglione Centrale – inondato di luce e progettato per esporre – e capire come queste differenze avrebbero potuto influire sui contenuti del nostro progetto espositivo.
Y.F.: L’architettura è sempre un’esperienza totalmente corporea e la grande sfida di una mostra di architettura, a differenza di una di arte, è presentare qualcosa che, per sua natura, si trova altrove. Come si può trasmettere una disciplina così complessa in modo preciso, per di più volendo raggiungere tanto gli architetti internazionali quanto i non specialisti? Tuttavia è proprio questo l’aspetto che ci interessa, perché implica la possibilità di rendere veramente totale – e analizzabile da tutti – un’esperienza come l’architettura. La nostra mostra intende celebrare l’importanza dell’architettura nelle nostre vite: solo se toccheremo davvero il cuore di quanti la vedranno fisicamente, o di chi leggerà a riguardo, avremo raggiunto gli obiettivi di comunicazione che ci siamo poste.
Proprio a partire da queste premesse, come commentereste l’intervento nel quale Francesco Dal Co, in qualità di curatore di Vatican Chapels, ha affermato di aver “provato una difficoltà rispetto alle mostre dove si presenta soltanto una parte di ciò che l’architettura è: dei bei disegni, dei bei modelli, dei bei rendering… Se l’architettura non è costruita è qualcosa che ancora non ha trovato la sua pienezza”.
Y.F.: Capisco cosa intende. Tuttavia credo che il valore di una mostra sia enorme: offre la possibilità di condividere la cultura architettonica. Faccio un esempio. Non so suonare alcuno strumento musicale, ma quando mi spiegano lo spartito di un componimento, posso davvero entrare nella musica. Oltre a poterla ascoltare, avrò infatti acquisito uno strumento per capire come è stata composta, i suoi valori e messaggi. La Biennale Architettura permette a chiunque di vedere come nasce un edificio, come prende forma un’idea, come poi si sviluppa nello spazio, quanta distanza intercorre quando un progetto è realizzato: l’analisi teorica che genera questo fenomeno è importante quanto il risultato finale.
S.McN.: L’architettura è entrare in uno spazio: la tua pelle riflette una luce che penetra all’interno; il tuo sguardo percepisce la materialità. Eppure, l’aspetto assolutamente straordinario di un’esperienza come la Biennale è poter lavorare con un team che ti consente di essere ovunque nel mondo, anche laddove non si è fisicamente. Per Freespace architetti internazionali si sono messi alla ricerca dell’essenza dei progetti, come uno scienziato quando analizza il DNA. Una mostra di architettura somiglia a una ricerca scientifica nella quale specifici aspetti di edifici o progetti vengono esaminati al microscopio. E, l’atto stesso di osservarli sotto un’altra luce, può permettere persino di rivalutarli o di fare nuove scoperte.

Jorn Utzon, Entrance seat at Can Lis Can Lis, Mallorca, 1973 photo Beatrice Pedrotti
Spostando l’ottica dalla Biennale allo stato della professione, come commentereste i dati sul gender gap rilevati negli studi di architettura del Regno Unito? Qual è la situazione in Irlanda a riguardo?
S.McN.: Da quanto ne sappiamo, non abbiamo questo gap nel nostro Paese o forse è limitato solo ad alcuni settori. Il panorama irlandese è diverso, credo anche a causa della nostra storia e del diverso ruolo rivestito dalle donne.
Y.F.: Quando due persone fanno lo stesso lavoro e vengono pagate in modo differente solo perché di due diversi sessi siamo di fronte a una disgrazia per la società. Per me questo gap è qualcosa di ridicolo: l’immaginazione non è una questione di genere! È importante che la voce delle donne venga ascoltata in ogni ambito. La sensibilità di ciascuno di noi deve essere ascoltata. Non importa se a parlare sia un uomo o una donna: dobbiamo porci in ascolto di quello che la gente ha da dire.
Lo studio Grafton Architects ha raggiunto i quarant’anni di attività professionale. Qual è il progetto rimasto su carta che vorreste realizzare? Quale intervento considerate il più significativo della vostra carriera?
S.McN.: Abbiamo un progetto non ancora realizzato che speriamo possa essere davvero preso in considerazione: è la nuova biblioteca pubblica di Dublino. Sarebbe una grandiosa occasione per la nostra città poter avere un edificio di questo tipo. Pensiamo alla biblioteca come all’unica vera istituzione democratica della nostra società. La sua realizzazione – dipende tutto dal trovare risorse economiche – fornirebbe un esempio concreto di generosità, di apertura, di condivisione della conoscenza: sarebbe un vero “freespace”. Dovrebbe sorgere in un’area urbana importante, densamente popolata, ma fin qui poco considerata in termini di sviluppo nonostante il suo potenziale. Siamo certe che potrebbe fare la differenza per l’intera Dublino. Pensando al nostro operato nel suo complesso, ci siamo misurate con progetti dipendenti da fattori come il budget o il tipo di committente; in altri casi abbiamo avuto la possibilità di esprimerci come desideravamo. Tra gli edifici che ci hanno concesso maggiore libertà c’è l’University Campus for UTEC a Lima, in Perù, dove abbiamo potuto realizzare una struttura aperta: è stato liberatorio! Ma ciascuno dei nostri progetti è importante. Ci piace pensare che nel tempo abbiamo sempre dato a ognuno lo stesso valore, indipendentemente dal budget disponibile e dall’esito. Anche quando si perde un concorso, ad esempio, c’è molto da imparare. Naturalmente ci dispiace, perché siamo emotivamente coinvolte, ma non è mai una perdita di tempo: è una risorsa.
Y.F.: Credo che ogni progetto sia l’occasione per un architetto di mettere in pratica una teoria. Avevamo già realizzato molto in Irlanda quando abbiamo partecipato alla gara per la Bocconi, in Italia; avevamo anche lavorato con ingegneri strutturali in alcune infrastrutture. Ciò che è stato interessante verificare nell’intervento di Milano è stata la possibilità di operare al di sotto della città, scavando in profondità. Quando ti trovi di fronte a uno spazio così credo che chiunque possa percepire la gravità, il peso dell’impianto… e, osservando il risultato, è stato un piacere vedere che tutto questo lo avevamo creato noi. È vero, siamo in attività da quarant’anni ormai. Eppure le scoperte sono costanti, perché l’architettura concede infinite possibilità. Quarant’anni sono tanti da un certo punto di vista, ma da un altro sono solo un piccolo frangente: chissà quante vite occorrerebbero per migliorare! Abbiamo un team fantastico che lavora con noi; è stato così anche per questa Biennale: ogni cosa nella vita è frutto dell’impegno di tante persone che spingono nella stessa direzione. Ci chiedevi dei nostri progetti non realizzati; Shelley ha fatto riferimento alla biblioteca di Dublino. Personalmente credo di non avere alcun rimpianto; ogni nuovo progetto sarà l’occasione per mettere in pratica quanto abbiamo imparato. Come una rinascita.
‒ Valentina Silvestrini
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #43
Abbonati ad Artribune Magazine
Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune
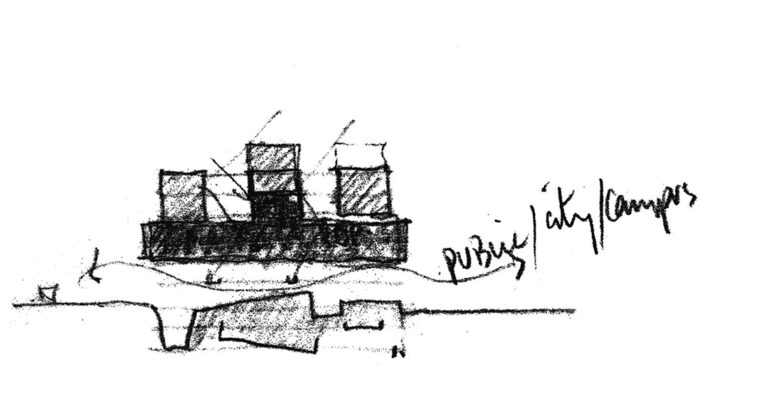 1 / 4
1 / 4
 2 / 4
2 / 4
 3 / 4
3 / 4
 4 / 4
4 / 4
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati