Dialoghi di Estetica. Parola a Stefano Velotti
Secondo appuntamento con i “Dialoghi di Estetica” che Artribune pubblica in collaborazione con il LabOnt dell’Università di Torino. Questa volta il protagonista è il filosofo Stefano Velotti, che ha da poco pubblicato per Laterza il libro “La filosofia e le arti”. Si parla delle nuove ricerche nel campo dell’estetica, con puntate su Marzia Migliora e Louise Bourgeois.

Inizierei con una riflessione sullo stato attuale dell’estetica: credo che gli sviluppi della disciplina siano oggi affidati a una possibile convergenza tra prospettive analitiche e continentali.
Mi pare che la tua impressione sia corretta, vale a dire che il divario tra analitici e continentali, anche in estetica, sia destinato a ridursi sempre più. Salvo che negli esercizi di pensiero più scolastici e prevedibili, attaccati difensivamente ai propri strumenti concettuali tradizionali, gli estetici continentali impareranno dagli analitici a essere più precisi e circostanziati nelle loro riflessioni, facendo tesoro del patrimonio che viene da autori come Goodman, Wollheim, Danto, Walton, Currie, Lamarque ecc. E, a loro volta, gli analitici – per non sfinirsi nell’insignificanza di questioni apparentemente sofisticate, ma in realtà spesso solo scolastiche e autoreferenziali – dovranno aprirsi sempre più alle grandi questioni dell’arte, della filosofia, dell’esperienza: non più, quindi, andare alla ricerca di “definizioni dell’arte”, magari formalmente ineccepibili ma conoscitivamente vuote, ma indagare il ruolo effettivo che ciò che ancora chiamiamo ‘arte’ ha nella nostra esperienza, in relazione al corpo, alla sensibilità, alla sensatezza e insensatezza delle nostre forme di vita, e quindi anche in relazione alla politica in senso ampio.
Pensi dunque che si possa giungere a un’estetica analitica pienamente concepibile come dottrina della sensibilità e erede delle due aree di ricerca?
A proposito del tuo rimandare a un’estetica come “dottrina della sensibilità” – di cui l’estetica analitica potrebbe diventare l’erede – vorrei fare un paio di precisazioni, perché altrimenti si rischia che si crei un nuovo divario, magari trasversale rispetto alla tradizione analitica e a quella continentale. Il nuovo divario potrebbe essere quello tra una cosiddetta “filosofia dell’arte”, che dà per scontato qualcosa che scontato proprio non è, e cioè che esista una classe di oggetti o di eventi che sono “arte”, così qualificati prima di ogni riflessione; e, dall’altro, una ripresa del senso baumgarteniano dell’estetica come dottrina della “conoscenza sensibile”, oggi declinata come “percettologia”, “atmosferologia” ecc. Credo che entrambe le prospettive siano parziali e di respiro corto.

Immanuel Kant
Quale potrebbe essere allora la via percorribile?
Bisognerebbe sforzarsi di tenere uniti i due lati della parola ‘senso’, che come già Hegel notava, è una parola dotata di una “meravigliosa ambiguità”: da un lato, rimanda alla sensibilità umana, carnale, sensoriale, sensuale in tutta la sua ricchezza e complessità, ma dall’altro al “senso” come orientamento, sensatezza, riconfigurazione immaginativa dell’esperienza, che può trovare in alcuni artefatti o eventi una concentrazione esemplare, e che – se e quando ciò accade – talvolta chiamiamo ‘arte’.
Questo emerge con chiarezza dalle tue ricerche. Nel tuo ultimo libro, cito, hai scritto che “nell’arte si esibiscono esemplarmente diversi modi in cui ci orientiamo nel mondo, in cui tentiamo di dare senso alla nostra esperienza in esso”. Tuttavia mi chiedo se l’evoluzione dell’arte nel Novecento, soprattutto dopo quella che potremmo definire come la sua “svolta concettuale”, possa confermare in termini pratici e progettuali questo forte legame con l’estetica.
La cosiddetta “arte concettuale” (ma quale arte, poi, non è in qualche modo anche “concettuale”?) è la croce che viene solitamente buttata addosso all’estetica, almeno da quando Duchamp ha ripudiato un’arte “retinica” (e poi Adorno un’arte “culinaria”) schierandosi per una sorta di anti-arte “anestetica”. Ormai, però, dovremmo tutti sapere che queste contrapposizioni sono abbastanza oziose: non è forse vero (come avevano capito a modo loro già nel passato Vico, Spinoza, Kant, tanto per fare qualche nome) che anche l’attività concettuale più astratta e apparentemente anestetica girerebbe a vuoto se non fosse sostenuta da un sentire? Oggi sono le neuroscienze che ribadiscono continuamente che un pensiero senza “sentimento” è un pensiero inefficiente e non adattivo, che ci porterebbe rapidamente all’estinzione. Mi piace ricordare – contro i noiosi ripetitori della tiritera secondo cui l’estetica kantiana, per esempio, verrebbe messa in scacco dall’arte concettuale – che per Kant – come dice esplicitamente fin dal primo paragrafo della sua Critica della facoltà di giudizio – il giudizio estetico può essere esercitato in relazione a qualsiasi cosa, anche un concetto e un’idea. La questione dirimente – in linea di principio, non di fatto – non è la natura di quel che ci troviamo davanti (un quadro o una scultura cinquecenteschi, un concetto o una performance ecc.), ma il modo in cui ci poniamo, l’uso che facciamo delle nostre capacità sensoriali, immaginative, intellettuali. In linea di fatto, poi, sarà decisivo se quella “cosa” (quadro o performance, ‘evento’ o installazione ecc.) sarà abbastanza ricca da sostenere, impegnare, rilanciare, sfidare, riconfigurare la nostra esperienza (in tal caso la consideriamo solitamente un’opera d’arte “riuscita”), o se invece – magari dopo un prima impatto “sensazionalmente scioccante” – resterà inerte e verrà dimenticata.
Hai in mente un caso in particolare?
Faccio brevemente un esempio che avrebbe bisogno di un’analisi più complessa: a Kassel, all’ultima Documenta, a molti è piaciuta un’opera (installazione-performance) di Tino Sehgal. Nella Casa degli Ugonotti sulla Friedrichsstrasse si entrava titubanti in una stanza buissima, non capendo bene che cosa bisognasse fare (vedere, sentire, ascoltare, toccare, sentire ecc.). Piano piano, alla cieca, uno veniva attratto da un canto a cappella, proveniente da persone invisibili, e che si muovevano imprevedibilmente all’interno della stanza, forse danzando. Queste voci, questa musica, che ci attraevano, diventavano via via più insistenti e invadenti, in una sorta di assedio sempre più stretto, affollato, opprimente. Finché il visitatore non veniva letteralmente spinto fuori, respinto da dove era venuto, da mani, spalle, corpi, aliti invisibili e ostili. L’impatto era forte, e la breve esperienza poteva essere ripetuta con più o meno disagio, a distanza di qualche tempo. Ma al di là dell’impatto, riconosciuto da quasi tutti i visitatori, che cosa restava? In che modo questo “esperimento-evento-performance” si è fatto strada nella mia vita, lasciando una traccia significativa? Me lo sono chiesto più volte e ho pensato – a titolo di ipotesi, forse azzardata – che in quella stanza, rimasta legata nella memoria della città al tragico destino degli Ugonotti, il visitatore veniva attratto da voci sireniche, sedotto dalla promessa di qualcosa di ignoto o di immaginato. E poi gradualmente quelle stesse voci seducenti e misteriose lo respingevano fuori da dove era venuto, senza tanti complimenti, lasciandolo interdetto e quasi deluso. Per me è stato inevitabile pensare a una metafora, a una messa-in-opera di quello che i Paesi occidentali fanno sistematicamente con i migranti: li attraggono con le loro voci sireniche e armoniose (democrazia, libertà, sicurezza, diritto, benessere…), poi li sfruttano, li respingono, e li cacciano via come corpi estranei. Certo, tutto questo, per noi, nella distanza di sicurezza di una manifestazione artistica, dove sappiamo che non ci accadrà nulla. Ma l’arte non può fare molto di più, non è “azione politica”, né può pretendere di esserlo. Può esercitare “il diritto di visita” (di cui parlava Kant, ripreso da H. Arendt) solo nell’immaginazione, invitandoci a metterci nella posizione di un altro. Solo in quella distanza abbiamo infatti la possibilità di sperimentare il senso dell’insensatezza della seduzione che esercitiamo, e della violenza e crudeltà con cui respingiamo chi abbiamo sedotto. Se fossimo noi stessi sui barconi che naufragano, penseremmo solo, e giustamente, a salvarci la vita. Ma forse quell’esperienza “artistica” non è stata inutile e può prefigurare (anticipare, orientare) azioni e atteggiamenti che potremmo intraprendere in ambiti più diretti ed efficaci rispetto ai nostri obiettivi concreti (giuridici, politici, sociali, economici ecc.).
Colgo un certo interesse per il rapporto tra estetica e critica…
Credo sia importante ricordare che il Settecento è stato chiamato il “secolo della critica”. Critica d’arte, critica filosofica, critica politica, “l’atteggiamento critico” – sempre invocato anche oggi come un mantra – nascono insieme. E nascono insieme almeno per due ragioni fondamentali: è “critica” ogni posizione che tiene conto di se stessa (la sua legittimità, la sua stessa “condizione di possibilità”) nel momento in cui enuncia qualcosa. Non è critico, per esempio, dire che oggi “niente ha più senso”, o che “tutto è relativo”, perché evidentemente si eccettua se stessi dall’affermazione che si fa: niente ha senso e tutto è relativo eccetto quello che dico io. Questo è un atteggiamento dogmatico o metafisico, che purtroppo affascina molti, perché sembra offrire certezze e punti fermi, opinioni ingiustificate che diventano dogmi carismatici (fesserie spacciate per verità dagli “unti del Signore” di turno, politici o “maestri dell’opinione” filosofico-giornalistica). La seconda ragione, altrettanto importante, è che il pensiero critico si esercita quando non ci sono criteri evidenti e “immutabili” di giudizio: non ho bisogno del pensiero critico se posso dimostrare qualcosa con sufficiente cogenza (2+2=4, “fuori piove”, la “Rivoluzione francese scoppiò nel 1789” ecc.), né ho bisogno del pensiero critico se esprimo le mie sensazioni più idiosincratiche e ingiustificabili (“ho caldo”, “il caffè mi fa schifo”, “forza Roma!”, “forza Italia!”, “gli ebrei – o gli arabi – sono tutti inaffidabili” ecc.). Invece, ho bisogno di riflettere, di esercitare il mio pensiero critico (di esaminare, pensare, immaginare, sentire, soppesare le mie affermazioni e argomentazioni, tornando riflessivamente su di esse) quando né posso dimostrare qualcosa, né do sfogo semplicemente alle mie idiosincrasie e pregiudizi beceri.

Arabella Natalini
Reputi possibile un consolidamento della critica, sulla base del rapporto tra l’estetica, intesa come dottrina della sensibilità, e l’arte?
Il caso tipico, esemplare ma non esclusivo, è proprio la critica d’arte. Di fronte a un’opera, nella sua singolarità (anche nella sua singolarità replicata, come accade oggi), io non dispongo di criteri già belli e pronti, che devo solo applicare, né basta dire “mi piace, non mi piace”, con il pollice verso o all’in su, come su Facebook. Io devo discutere, con me stesso e con gli altri, che siano fisicamente presenti o meno. La stessa cosa avviene nella valutazione di eventi storici che mi coinvolgono, che sono sempre singolari e spesso tragicamente inediti: il caso ovvio è il nazismo. E questa è la sfera pubblica, essenzialmente pubblica, e dunque estetica e politica. Qui, come diceva Hanna Arendt, devo pensare “senza corrimano”, e devo mettere alla prova non tanto quel che so, ma quel che sono e che sarò, e quindi ci vuole “coraggio” (una parola, questa, che non a caso compare sia in Arendt – quando parla del giudizio politico – sia in un grande critico d’arte come Leo Steinberg, quando parla del giudizio estetico su un’opera, “in assenza di standard disponibili”). Detto questo, spero di aver risposto almeno implicitamente alla tua domanda: penso che la filosofia (e dunque l’estetica, che come diceva il mio maestro Emilio Garroni, non è una “filosofia speciale”) e la critica d’arte non siano scindibili, anche se naturalmente non sono la stessa cosa, e ciascuna richiede competenze specifiche (non esclusive, però) che si possono formare solo nel tempo.
Nel tuo ultimo libro hai dedicato interesse alle opere di una giovane e brillante artista italiana, Marzia Migliora. Cosa ne pensi dell’arte contemporanea?
La cosiddetta arte contemporanea offre un panorama smisurato ed eterogeneo. Per muoversi al suo interno, e fare scelte e selezioni motivate che permettano approfondimenti sensati, bisogna padroneggiare, per quanto è umanamente possibile, un quadro di insieme vastissimo, senza al tempo stesso perdere “i dettagli”, cioè la singolarità delle opere, che è essenziale! Non solo è necessario viaggiare continuamente, ma bisogna avere una grande cultura storico-artistica e, soprattutto – cosa davvero rara – a questi requisiti bisogna aggiungere qualcosa che si acquisisce solo nel tempo e che richiede anche, credo, qualcosa come delle disposizioni naturali. Io possiedo questi requisiti in maniera minima, ma ho la fortuna di potermi appoggiare a una curatrice, Arabella Natalini, che questi requisiti li possiede tutti, e che soprattutto ha un “occhio” sicuro e sensibilissimo.

Marzia Migliora – Quelli che trascurano di rileggere si condannano a leggere sempre la stessa storia – Museo del Novecento, Milano
Com’è nato questo tuo interesse filosofico per le opere di Marzia Migliora?
Arabella Natalini ha lavorato spesso con Marzia Migliora, da ultimo per una installazione straordinaria – Rada – nel Centro di arte contemporanea Ex3 di Firenze, un centro vivissimo che, purtroppo, ha dovuto chiudere proprio lo scorso giugno per mancanza di fondi. È stato grazie a lei che ho incontrato Marzia Migliora. Con i suoi lavori è successo quel che di solito mi succede con quei pochi artisti che poi riesco a ricordare, a identificare, a seguire, e di cui mi appassiono: c’è innanzitutto un impatto immediato, dovuto alle qualità più “estetiche”, per intenderci, del loro lavoro. A volte le opere non tengono, si esauriscono, non mantengono la promessa di far sentire, pensare, immaginare. Non così con altre opere, come la maggior parte di quelle di Marzia: più le osservo e più ci ragiono, più mi sembra di scorgere ricchezze e implicazioni coinvolgenti e da elaborare ulteriormente.
Quanto contano, secondo te, nelle sue opere la partecipazione e la sensibilità soggettiva di chi ne potrà fare esperienza?
Nel 2010, Marzia mi ha chiamato, insieme ad altre persone molto diverse tra loro (un bambino, un astronauta, una rifugiata, un giornalista, uno psicoanalista ecc.) a partecipare alla costruzione di un suo lavoro, di cui – come gli altri – sapevo ben poco: Quelli che trascurano di rileggere si condannano a leggere sempre la stessa storia, che costituisce l’unica opera contemporanea permanente all’interno del Museo del Novecento di Milano. È un lavoro molto complesso – il cui risultato tangibile è una sorta di audioguida d’artista disponibile all’entrata del museo – di cui analizzo alcuni aspetti per me molto interessanti nel mio libro La filosofia e le arti. Sentire, pensare, immaginare, e sulla cui descrizione e analisi non posso tornare qui. Se non per rispondere alla tua domanda: oggi si parla sempre di “partecipazione”, di “arte relazionale”, di “coinvolgimento dello spettatore” ecc. Ma sotto questi slogan generici c’è di tutto, spesso cose velleitarie, furbesche, estemporanee. Questo lavoro di Marzia Migliora (e altri realizzati prima e dopo) è invece esemplare: anche al di là della consapevolezza esplicita dell’artista, di cui non so molto, è un lavoro che insieme tematizza e mette in opera la possibilità di fare un’esperienza estetica delle opere d’arte, un’esperienza che ovviamente deve essere partecipata. Le opere d’arte, senza una loro “attivazione” da parte dei fruitori, non sono opere d’arte: sono “cose”, artefatti, documenti, indagabili storicamente o psicologicamente, dotate magari di un valore economico o ideologico, ma, in quanto opere d’arte, restano morte o in stato di latenza. Questa opera di Marzia Migliora non solo le riattiva, ma espone il complesso lavoro immaginativo, sensoriale e concettuale che è racchiuso nell’esperienza di un’opera. Tutto questo “lavoro” è strettamente legato non solo alla nostra storia, alla nostra memoria individuale e collettiva, ma addirittura al nostro costituirci come la specie che siamo: permette infatti di toccare con mano che ci siamo evoluti come homo sapiens solo in quanto abbiamo sviluppato la capacità di farci “rappresentazioni di rappresentazioni”. Non solo, dunque, di avere rappresentazioni, come molti altri animali, ma di saperle usare in modi diversi, e di poter immaginare – grazie a un’opera, guidati da essa, restandole fedeli – ciò che è assente o indeterminato, e insieme anche punti di vista assenti e non materialmente disponibili (e qui torniamo al “diritto di visita” che menzionavo prima).
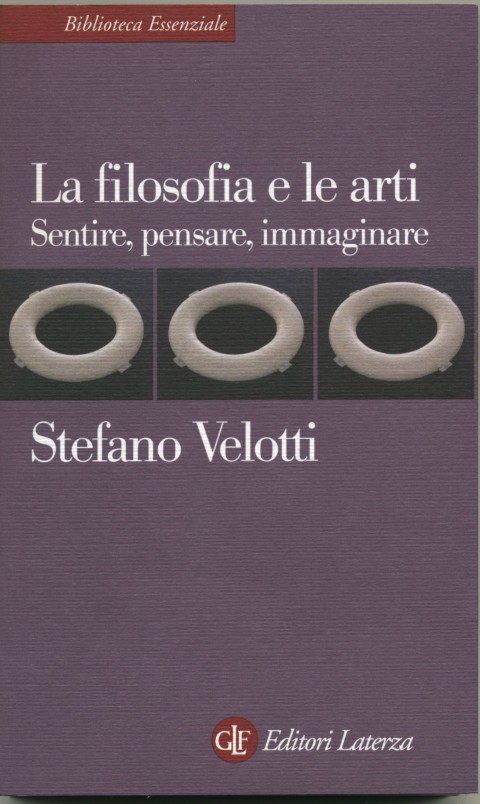
Stefano Velotti – La filosofia e le arti. Sentire, pensare, immaginare
Quale potrebbe essere la peculiarità di questa sua opera dal tuo punto di vista?
In quest’opera si realizza l’esperienza di un immaginare plurale, collaborativo, partecipato, e insieme una sua messa a nudo. Partecipando a quest’opera, e ragionandoci, è come se avessi potuto toccare con mano un circolo virtuoso tra la storia dell’arte moderna (che occupa una porzione ridicolmente piccola della nostra storia di specie) e le smisurate profondità temporali che ci legano al sorgere dell’“arte” e del linguaggio nel paleolitico superiore. Non a caso, mi è sembrato inevitabile – nell’analizzare quest’opera – tentare di far scoccare una scintilla tra le schede ben fatte e informate, nei loro limiti di schede, del catalogo del Museo del Novecento e gli studi di psicologia cognitiva ed evolutiva di Michael Tomasello…
Seguo queste tue riflessioni e ti chiedo ora qualche nota di approfondimento sull’analisi delle opere dell’artista francese Louise Bourgeois. In particolare riguardo a un concetto: quello di “fioritura”.
L’idea di “fioritura umana” raccoglie tutto ciò che è auspicabile per un essere umano e per una società. Chi è che non vorrebbe “fiorire” e “veder fiorire”, cioè dispiegare e veder dispiegare tutte le potenzialità naturali-culturali di un essere umano, di un animale e persino di una pianta? È un’idea altamente indeterminata, e che è molto rischioso tentare di determinare o “normare” (giuridicamente, politicamente, socialmente, psicologicamente).
Pensi che il concetto di “fioritura” sia applicabile anche ad altri casi di produzione artistica contemporanea?
Tutte le opere d’arte “riuscite” realizzano sensibilmente, in una singolarità determinata ed empirica (una “cosa”, un evento, un testo), un’idea o una pluralità di idee che eccedono qualunque lista determinata di significati, concetti, “messaggi” chiaramente riformulabili e comunicabili, e che tuttavia siamo invitati o “costretti” a produrre dall’opera stessa. Come diceva Kant, “danno da pensare, senza che nessun concetto determinato sia loro adeguato”. La scultura in bronzo di Louise Bourgeois, Janus Fleuri, mi sembra che racchiuda proprio un percorso di fioritura personalissimo, singolare, e insieme esemplare, universalizzabile, emulabile. È una fioritura che sembra coinvolgere tutti gli “strati” di una persona, da quello sessuale-orgasmatico a quello che permette una riconciliazione, o quasi, con le ferite della vita, fino a un equilibrio tra il nostro essere passivi e dipendenti e il nostro essere autonomi e attivi – nel corpo e nella mente – anche come soggetti creativi. Come, per altri versi, l’opera di Marzia Migliora di cui parlavamo prima, anche quest’opera realizza e insieme tematizza il rapporto di “attivazione partecipativa” che abbiamo sempre con le opere d’arte (se e quando, appunto, accade che le esperiamo come opere d’arte), anche nel caso di questa scultura della Bourgeois mi sembra di poter dire che assistiamo a una “messa in opera” di una fioritura umana (sottesa indirettamente e in qualche misura a ogni opera) che ha anche come proprio soggetto questa stessa fioritura.

Louise Bourgeois – Janus fleuri – 1968
E se intendessimo il concetto di “fioritura” come un utile criterio (pensando anche alle riflessioni intorno alla metodologia critica di Leo Steinberg), rapportabile alla sensibilità, all’immaginazione e al giudizio?
Ho detto che ogni opera sottende “indirettamente e in qualche misura” una fioritura umana, e questo richiede qualche precisazione. In che senso l’opera di Marzia Migliora, oppure quella a cui abbiamo accennato prima di Tino Sehgal – per non parlare di un’opera di Beckett o di una poesia di Zanzotto, o ai dipinti di Jasper Johns di cui parla Leo Steinberg nelle pagine che ho ripreso nel mio libro – sottenderebbero una fioritura umana? Non certo come loro soggetto, ma semmai come attestazione della facoltà umana di esemplificare in qualcosa di sensibilmente determinato, empirico e singolare la totalità indeterminata dell’esperienza umana. In questo senso, le opere d’arte possono essere un termine di paragone e di confronto – e anche un correttivo a cui tornare sempre di nuovo – per il nostro lavoro concettuale. È come se offrissero l’occasione al nostro lavoro concettuale (giuridico, politico, etico ecc.) di mettere alla prova la sua adeguatezza di fronte a qualcosa che è sempre più ricco e complesso di ogni sistematizzazione discorsiva. Per esempio: se mi interrogo sulla vita sociale e politica delle donne, riflettere sul lavoro della Bourgeois potrà aiutarmi a tenere conto di un complesso di esigenze, esperienze, bisogni, aspirazioni di cui magari non sarei altrettanto consapevole. E ciò vale, direi, per tutte le opere d’arte, se adeguatamente esperite e interpretate: la solitudine degli oggetti di cui parla Steinberg in relazione a Johns può aprire una comprensione della solitudine altrimenti inaccessibile o che rimarrebbe confusa e implicita, per non parlare di opere molto più esplicite nei loro referenti, come per esempio La morte di Ivan Ilic di Tolstoj. In un certo senso – per rispondere più direttamente alla tua domanda -, la “fioritura umana” può essere una sorta di “criterio” (necessariamente indeterminato e indiretto) della valutazione, del giudizio sulle opere, ma non certo una regola facilitante che può essere applicata nello stesso modo a ogni opera.
Davide Dal Sasso
Stefano Velotti – La filosofia e le arti. Sentire, pensare, immaginare
Laterza, Roma-Bari 2012
Pagg. 204, € 12
ISBN 9788842092193
www.laterza.it
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





