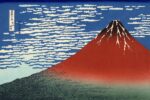Un futuro c’è stato. La Biennale secondo Laura Iamurri
Si è scritto molto sulla Biennale inaugurata qualche settimana fa, molte espressioni di plauso e consenso, e poche manifestazioni di segno contrario. Soprattutto, riflessioni e note a margine condotte con serietà e senza polemica, come da tempo non si vedeva. Fin qui tutto bene…

Il progetto di Massimiliano Gioni si presentava come seducente, ambizioso, serrato: un progetto forte che, nonostante il poco tempo a disposizione, si è tradotto in una mostra coerente, destinata – a giudicare da molti commenti letti e ascoltati – a lasciare un segno. Finalmente, verrebbe da dire, un’edizione della Biennale che suscita un interesse diffuso, e persino un sentimento di ammirazione, in Italia e all’estero.
In effetti, l’allestimento è impeccabile nel ritmo e nella leggibilità da ordinamento museale. Vagando nell’Arsenale mi chiedo se era proprio necessario cancellare l’unicità e il respiro delle Corderie con pannelli di cartongesso per dare forma al “museo temporaneo” evocato nella presentazione della mostra; ma riconosco che l’isolamento spaziale contribuisce alla chiarezza del percorso: tutto in ordine, pareti immacolate e non “sporcate” da didascalie verbose (confinate nei punti di passaggio, con inevitabile ressa nei giorni di affollamento), le tavole, gli oggetti, i lavori in mostra messi adeguatamente in risalto dalla loro stessa rarefazione sullo spazio bianco.
Ma appunto quali oggetti, opere, lavori? Una combinazione, secondo quanto era stato annunciato da Gioni, di “opere d’arte contemporanea, reperti storici, oggetti trovati e artefatti”, prodotti da “professionisti e dilettanti, outsider e insider”, verso i quali adottare – ça va sans dire – “un approccio antropologico allo studio delle immagini”. Il risultato è una Wunderkammer dilatata ed espansa, che trova un suo momento di concentrazione altissima nella sala allestita da Cindy Sherman, e che poi riprende il ritmo disteso e piacevole nella successione delle sale. Dove trovano posto estasi, visioni sciamaniche, tormenti vari provenienti da luoghi di internamento immaginari e reali (carceri, ospedali psichiatrici) secondo un disegno di esplorazione della conoscenza, di progressiva evanescenza dei margini, di espansione di quanto una volta si sarebbe definito il campo dell’arte contemporanea, con tutte le implicazioni del caso.
Dopo due mezze giornate tra Padiglione Centrale e Arsenale, esco frastornata da questo inventario di ossessioni private, di utopie maniacali, di isolamenti più o meno forzati; di conflitti interiori anche laceranti che lasciano accuratamente fuori gli attriti e gli antagonismi urticanti del mondo contemporaneo.

When Attitudes Become Form, Bern 1969-Venice 2013, Fondazione Prada, Ca’ Corner della Regina, Venezia
La metafora del Palazzo Enciclopedico, questo “sogno di una conoscenza universale e totalizzante [sic]”, continua a suscitarmi domande. Un’opera enciclopedica raccoglie e ordina una sintesi delle conoscenze umane; in generale, il suo fine è trasmettere i dati e le riflessioni più significative accumulate su un certo ambito del pensiero e dell’agire umano; per quanto utopisticamente aperta all’infinito procedere del sapere, deve presentarsi come completa (salvo “supplementi”: ma sono per l’appunto appendici, integrazioni, corpi aggiuntivi; o, nell’epoca delle enciclopedie digitali, che non è quella del Palazzo Enciclopedico di Auriti, di revisioni periodiche). È dunque, costitutivamente, un resoconto chiuso di ciò che è già stato, compiuto, repertoriato. Un’operazione interamente rivolta al passato, e in questo caso a un passato che rimonta all’inizio del XX secolo scartando i più ovvi beaten paths e addentrandosi in sentieri laterali, di direzione incerta. È la necessità di risalire il XX secolo per mettere in scena una storia alternativa, ovviamente non lineare e tutta da scrivere, che mi lascia perplessa; e la questione mi pare cruciale perché, se è ovvio che alla Biennale – almeno da quando si è abbandonata la consuetudine delle retrospettive – non si scrive di storia dell’arte, è indubbio che la contemporaneità agisce sempre sul nostro sguardo e sulla nostra scrittura della storia, aprendo nuove strade e ridefinendo margini e discorsi. Sarà interessante, nei prossimi tempi, vedere gli effetti di un percorso enciclopedico così definito sulla storia dell’arte.
Per il momento, lontano dai Giardini, la storia scritta da Harald Szeemann con le sue mostre continua a esercitare un richiamo potente. E ci si sottopone alle interminabili file fuori da Ca’ Corner della Regina e agli obblighi degli itinerari di visita per ritrovarsi travolti da un’energia che nemmeno l’artificio della copia in scala 1:1 riesce a contenere: rifatte, rimontate, evocate con il gesso per terra come cadaveri dopo un omicidio in strada, le opere e le installazioni messe in scena nel 1969 a Berna restituiscono un’atmosfera di quieta effervescenza, di scoperta e di invenzione, di sperimentazione continua, e saldamente ancorata nel presente quando non proiettata in avanti, in qualche futuro tutto da immaginare. Come diceva Lucio Fontana, “Un futuro c’è stato…”.
Laura Iamurri
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati