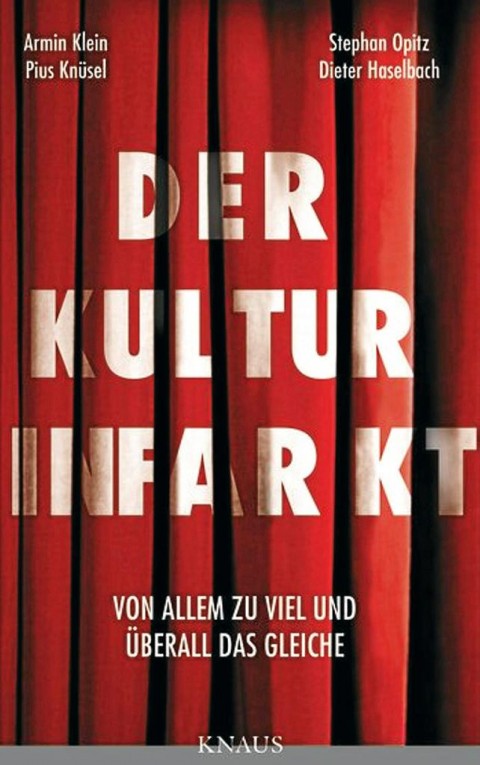Arte italiana? Non è più questione di patriottismo
La questione nazionale torna ancora una volta. Ad esempio in occasione della nomina del curatore del Padiglione Italia, Vincenzo Trione. Ma il problema è il patriottismo? O piuttosto un ripensamento del cosmopolitismo? L’editoriale di Michele Dantini, che anticipa il suo nuovo libro.

Progenitori di pietra, Figli che a ritroso trapassano nei Padri, interni abitati dai Fantasmi della Memoria e dell’Oblio. E ancora: enigmatiche sculture-monili, antichità redivive e acrobatici “pensatori di buchi” da cui, quantomeno così si suppone, si riversa via da noi la Tradizione.
Il dilemma “che fare?” è divenuto ricorrente nell’arte italiana contemporanea. Per quanto implicito, costituisce il tema cruciale. Per dargli forza occorrerebbe tuttavia trarlo fuori dai regni del Non Detto e del Preterintenzionale e discuterlo in tutta la vastità delle sue implicazioni.
Come “abitare” un contesto nazionale o postnazionale e creare immagini-simbolo di un compito e un destino condiviso? È significativo che nell’arte italiana degli ultimi due decenni, direi dalla Nona ora di Cattelan (1999), non troviamo credibili messe a nudo di propositi di riscatto o esperienze di vulnerabilità collettiva. Dietro opere ben fatte non percepiamo città, classi sociali, generazioni, comunità ideologiche o affettive. L’atteggiamento di risoluto solipsismo non aiuta.
QUALE COSMOPOLITISMO?
Dalla biografia di un’artista milanese di ampia notorietà internazionale apprendiamo che questa stessa artista risiede tra Anchorage, Londra e Alicudi, senza dimenticare i soggiorni a Shangai. Dietro alla spacconeria di chi modella il proprio avatar a imitazione di aziende multinazionali, assimilandosi di buon grado a un “prodotto” industriale o finanziario, non c’è forse il rifiuto subalterno della propria identità infantile e vernacolare? Un’automutilazione volontaria del Sé in ossequio alle estetiche (o alle biopolitiche) del capitale? Prendo spunto dalla circostanza per considerazioni di più ampia portata.
La riproposizione di fantasie di onnipotenza infantile predestina all’irrilevanza culturale e sociale. Questa, in sintesi, la sorte di buona parte dell’arte italiana contemporanea. Il rifiuto dell’appartenenza è irreale: toglie all’immaginazione la sua più salda risorsa.
Il mio punto di vista è terapeutico, non patriottico. Mi propongo di riflettere sul costo delle finzioni di irrelatezza. Emozioni come ira, vergogna o indignazione, se disattese, possono imprigionare l’immaginazione costringendola a oscillare tra gli estremi dell’esterofilia e della recriminazione; e separarla artificiosamente dal mondo della vita, delle fantasie potenti, delle azioni reali e condivise.
Precarietà ed espatrio sono le esperienze che distinguono storicamente l’attuale generazione dei trenta-quarantenni. Ne cercheremmo però invano tracce figurative. Perché? Procurare fantasiosi intrattenimenti all’1% non esaurisce i compiti dell’arte. Gli artisti tedeschi del periodo di Weimar scelsero di commentare la disuguaglianza nelle loro opere. Un eccesso di levigatezza in tempi difficili equivale invece a una censura introiettata.
Una parte del problema è riconducibile ai modi di reclutamento e all’attuale processo di costruzione delle carriere: la mia tesi è che essi producano un pernicioso distacco dall’esperienza individuale, specie se subalterna. Istituzioni pubbliche e private incoraggiano percorsi formativi chiusi e curricula bloccati. Sul modello di un qualsiasi corpo burocratico, l’avanzamento professionale di un giovane artista oggi in Italia è severamente regolamentato e promuove riconoscibilità e “coerenza”.
Talenti in formazione sono avviati a una professionalità intesa in senso formalistico e deconflittuale, definita in base a standard generici, pronta a collocarsi sul mercato internazionale. L’esordio può essere precoce e così una remunerativa reputazione. La cooptazione curatoriale premia artisti sempre più giovani, in analogia a quanto accade sul mercato corporate del lavoro: la giovinezza assicura maggiore plasticità e pronta sottomissione. Difficile tuttavia immaginare che da coorti di nerd meticolosi e prudenti possa scaturire innovazione.
NUOVE AGENDE PER NUOVI COMPITI
Il deficit di autorevolezza di ciò che chiamiamo “arte contemporanea” è accentuato, non solo in Italia: occorre rappresentarsi plasticamente la circostanza e farsene una ragione. Al tempo stesso dovremmo evitare l’autodenigrazione e smettere di considerarci “periferici”: lo saremo davvero, in senso diminutivo, sinché non saremo stati capaci di elaborare in modo nuovo gli elementi congiunturali “nativi”.
Si tratta verosimilmente di dichiarare concluso un ciclo e immaginare orizzonti di senso più adeguati per ciò che (forse impropriamente) ci ostiniamo a chiamare “arte contemporanea”. Proviamo a porre bene in evidenza, in alto nell’agenda, la questione dell’utilità pubblica: muovendosi su piani simbolici, l’arte può contribuirvi in maniera potente e non derivata.
Passata attraverso innumerevoli stagioni di dislocazione ironica e autoriflessione specifica, l’arte contemporanea non è più in grado di ritrovare dimensioni di crescita individuale, conforto o restituzione. Le richieste di condivisione e “cura” potranno in futuro giocare un ruolo importante. Dettare nuovi modelli di professionalità e suggerire punti di vista innovativi. “La soluzione dei grandi problemi della nostra società non si trova nell’arte”, affermano gli autori di Kulturinfarkt (2012), documentato pamphlet sullo “Stato culturale” nel mondo di lingua tedesca. “L’umanità ha bisogno di ricercatori, scienziati e ingegneri: persone che con passione affrontano compiti che richiedono tenacia, senza riconoscimento pubblico, mossi dall’entusiasmo e non dall’idea di diventare icone glamour”.
La teoria femminista contemporanea suggerisce modi persuasivi di abitare luoghi, comunità e istituzioni; modi che possono essere conflittuali ma non privi di riconoscimento dell’importanza dei legami storici e affettivi. Così Susan Hansen e Geraldine Pratt suggeriscono di contrastare criticamente le retoriche della mobilità qualora siano poste al servizio di ideologie individualiste e elitarie. Doreen Massey oppone invece il compito di nuove “geografie della cura” a “euforiche narrazioni di nomadismo, mobilità e fuga”. Salde relazioni di dominio, aggiunge, possono essere mantenute proprio attraverso la celebrazione dell’instabilità.
Tra Sei e Settecento, prima nei Paesi Bassi e poi in Francia, l’arte moderna ha stabilito specifiche solidarietà storiche e sociali. Si è rivolta non all’aristocrazia ereditaria né all’alto clero ma a persone distanti dagli apici del potere e della ricchezza, memori dell’indigenza e della vulnerabilità: i membri di una “classe generale”. Oggi non sappiamo bene cosa accadrà, né se la creatività “professionale” manterrà i connotati linguistici, sociali e istituzionali consueti. E’ tuttavia verosimile che potremo restituire vigore all’immaginazione se avremo progettato in modo nuovo istituzioni e processi di lungo periodo, musei e formazione in primis. Ma questo è un compito politico.
Michele Dantini
Questo testo è un’anticipazione dell’e-book “Arte, ricerca e sfera pubblica. Saggi sull’innovazione culturale” di prossima pubblicazione per doppiozero (Milano 2014).
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati