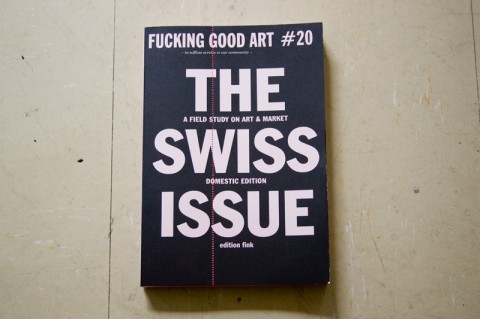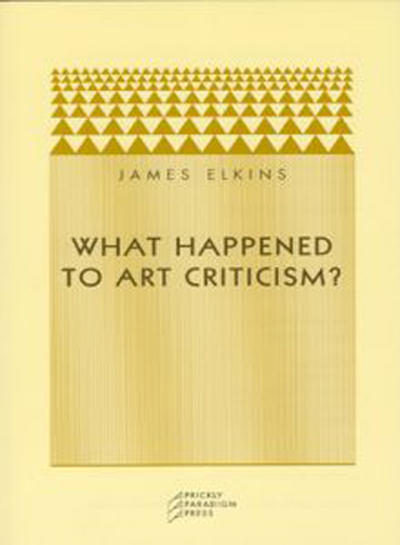Per cominciare, ci raccontate del progetto FGA, di com’è nato, delle modalità che utilizzate per trasmettere le vostre ricerche?
‘Fucking’ prima di ‘Good Art’ è un’esclamazione, come a dire che il magazine è insistentemente alla ricerca di arte valida. Certo, è un po’ ruvido come nome, ma l’intenzione è positiva, e la gente lo ricorda facilmente.
Tutto è iniziato nel 2003, quando volevamo sentirci più coinvolti attivamente sulla scena artistica di Rotterdam. Volevamo dire la nostra, dare risalto a tutte quelle mostre di spazi indipendenti che non trovavano riscontro nei media nazionali, nei quotidiani o nelle riviste d’arte. FGA iniziò come una zine per una critica d’arte condotta da artisti, da coloro che fanno le cose, piuttosto che da accademici. Invitavamo artisti e curatori a collaborare sul nostro cartaceo: un A3 rosa come la Gazzetta dello Sport piegato in A5, successivamente disponibile anche online.
Stampavamo 750 copie e le distribuivamo a livello locale e nazionale, in termini molto informali, soprattutto a chi collaborava. Cercavamo di confezionare un numero ogni due mesi. La ricezione era molto buona. Poi Fucking Good Art è gradualmente mutato in un progetto di editoria artistica itinerante, prendendo forma in diverse realtà locali.
Dal 2004 avete focalizzato la vostra attenzione e collezionato numeri specifici su un sacco di città: Monaco, Berlino, Dresda, Copenhagen, Riga, Basilea, Zurigo, San Paolo, Tblisi. Poi, all’inizio del 2011, siete approdati in Italia. Ma torniamo un attimo indietro: la critica d’arte. Secondo voi, quale può essere il ruolo di una critica d’arte non accademica nel panorama attuale? La vostra operazione può anche essere considerata una sorta di meta-critica. Cosa ne pensate?
Se non ci sbagliamo, c’è stata una crisi della critica d’arte, e probabilmente tuttora persiste. Oggi i critici, per guadagnare soldi a sufficienza, devono scrivere per artisti e gallerie testi per cataloghi. In passato il critico era probabilmente più vicino allo storico o al filosofo.
Siamo ispirati da una scrittura non accademica, e ci piace il punto di vista di chi le cose le fa. Forse scrivere di arte – non usiamo a questo punto il termine ‘critica’ – significa semplicemente trovare uno spazio in cui il fare e il pensare si incontrano. Quindi sì, la nostra posizione è una meta-posizione, perché cerchiamo di dire qualcosa sulla scrittura di per sé.
Sebbene in Italia a volte sembri esserci una carenza di ricerche e analisi di un certo spessore, ci sono comunque molte valide riviste d’arte, specialmente tra Roma e Milano. Qual è stata la vostra impressione, anche a confronto con altre situazioni?
È davvero significativo che in Italia, in un arco temporale di circa sette anni, siano nate così tante riviste d’arte valide. Abbiamo capito che la ragione per cui molti magazine sono stati fondati è che è davvero difficile, per un curatore, trovare lavoro, iniziare a fare mostre, perciò questi giornali funzionano a mo’ di spazio per loro, più che per gli artisti.
Quello che troviamo sconcertante di queste riviste è che stampano 20, 40 o 60.000 copie, distribuite gratuitamente lungo tutta la penisola, e in alcuni casi anche in altre parti d’Europa. L’intera distribuzione assomiglia più a una diffusione di pubblicità. È la logica del mercato, per cui solo una produzione consistente ti consente di essere economicamente in circolo; dev’essere costosissimo stampare 20mila copie, ma evidentemente se ne stampassero 2.000 non potrebbero vendere la pubblicità. Ogni magazine, poi, si confronta con queste dinamiche in maniera differente. Ma chi è il Cavallo di Troia, e chi si nasconde dentro?
Spazi non profit, indipendenti o artist-run: durante il vostro Grand Tour italiano avete incontrato realtà interessanti in questo senso?
Non abbiamo rintracciato modelli artistici nuovi o rivoluzionari rispetto a quelli che già conoscevamo. Ma abbiamo incontrato molte persone che trovano spazi o nicchie per produrre cose interessanti, o contribuire attivamente laddove si percepisce una mancanza. Un esempio su cui tutti quanti concordano è Careof, a Milano, che da vent’anni alimenta quello che è l’unico archivio di arte contemporanea italiana in Italia.
Da una città all’altra, comunque, la situazione varia molto. Se nel Nord l’arte trova rifugio in ex spazi industriali, nel Sud si adatta a una logica stagionale: il turismo concede molti spazi liberi, ma solo dieci mesi all’anno. In Sicilia ci sono iniziative che cercano di riconnettere il discorso intellettuale alla realtà di tutti i giorni. A Torino, dato che questa vuole porsi come capitale italiana dell’arte contemporanea, ci sono più spazi e progetti. Roma è in un momento di fermento e accoglie molte iniziative per provare soluzioni nuove. Poi ci sono le accademie private, che sono interessanti ma allo stesso tempo problematiche.
Le accademie e le scuole d’arte italiane, per varie ragioni, appaiono spesso antiquate e inadeguate alla formazione dei futuri artisti. Avete avuto modo di formulare un punto di vista a riguardo?
Sfortunatamente non ci siamo fatti un’idea precisa. Volevamo, ma forse è sintomatico proprio il fatto che nessuno ci ha spinti più di tanto in questa direzione. La scena artistica contemporanea e le accademie sono universi separati. Ma ci sono delle eccezioni: la Nomas Foundation ha valide collaborazioni tra visiting artists e l’accademia, ad esempio; abbiamo incontrato Alberto Garutti, che abbiamo capito essere molto importante per gli studenti di Brera. Poi Venezia, Bergamo, la Naba (per i più facoltosi), i corsi estivi della Fondazione Ratti e della Spinola Banna, che propongono attività interessanti. Anche a proposito delle accademie siciliane abbiamo sentito parlare bene.
C’è da sottolineare un’altra cosa, però: Jonathan Meese una volta ha detto che tutte le accademie dovrebbero chiudere. È un’idea folle, certo, ma contiene un nocciolo di verità. Il mondo dell’arte è saturo di artisti e curatori. Cosa faranno tutte queste persone che escono dalle accademie, se sappiamo che solo il 5% beneficerà del sistema? Non è per fare i cinici, ma questa è la realtà.
Qual è l’atmosfera generale che avete respirato durante il vostro soggiorno in Italia? Quali erano le aspettative che nutrivate, e quali sono le conclusioni cui siete arrivati?
Speravamo di incontrare, nell’ambito dell’arte, più persone con un atteggiamento meno compiacente, capaci di osare e pensare fuori dagli schemi del mercato e della competizione darwiniana. Crediamo nelle reti alternative. Perché l’attuale sistema dell’arte è valido per pochi e distruttivo per molti. Ci siamo resi anche conto che molte persone hanno lasciato l’Italia per migrare a Berlino, Rotterdam o New York, esattamente come fecero gli artisti della Transavanguardia. Ma fortunatamente abbiamo anche incontrato chi è tornato perché crede sia importante contribuire alla crescita artistica del proprio Paese.
Gabriele Naia
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati