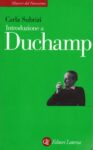Dialoghi di Estetica. Parola a Carla Subrizi
Carla Subrizi insegna Storia dell’arte contemporanea alla Sapienza ed è presidente della Fondazione Baruchello. I temi affrontati in questo dialogo sono la poetica di Duchamp e la sua influenza sulle ricerche artistiche odierne, le pratiche delle artiste contemporanee, la dematerializzazione dell’arte, la centralità dell’azione nella produzione artistica.

Nel libro dedicato alla ricerca artistica di Marcel Duchamp, lei scrive che al principio del suo approccio creativo non vi era un rifiuto verso l’arte, piuttosto una particolare attenzione per le nuove possibilità che essa può avere, e dunque offrire. In che misura questo interesse per i nuovi orizzonti di senso dell’arte è stato decisivo per le evoluzioni della poetica di Duchamp?
C’è un anno che può costituire in parte una risposta: il 1913. In questo stesso anno Duchamp poneva la ruota di bicicletta su uno sgabello da cucina (lo chiamerà ready-made qualche anno dopo, negli Stati Uniti), vede esposto il suo Nudo che scende le scale all’Armory Show ovvero la stessa opera che l’anno precedente era stata rifiutata al Salon des Indépendents a Parigi, diventa bibliotecario nella Biblioteca di Sainte-Geneviève a Parigi (lui non era presente all’Armory Show), realizza gli Stoppages étalon e Erratum Musical, scrive in un appunto celebre della Scatola bianca (“Si possono fare opere che non siano arte?”), continua a disegnare e a fare appunti per quello che sarebbe diventato Il Grande Vetro. Tutto nello stesso anno.
In questa molteplicità e nel differente uso delle possibilità dell’arte continuo a vedere non un rifiuto ma invece una prospettiva più ampia. Duchamp è stato l’artista dell’interazione dei linguaggi e del mettere in interazione le differenti possibilità dell’arte. Ha abbandonato l’arte più volte ma in realtà non ha smesso mai. Andare dal ready-made al Grande Vetro, a Tu m’, alla Société Anonyme era possibile. C’è un piccolo appunto sul Possibile che dice che deve bruciare ogni estetica. Questo era quello che sentiva fortemente Duchamp e che ha trasmesso (a chi ha voluto capirlo) alle generazioni successive: non soltanto una linea continua dal ready-made all’arte concettuale, ma una intelligente capacità di fare e pensare sempre al di là di quello che sembrava acquisito, contro ogni “ismo”. È più facile sostenere che Duchamp è stato il padre di, o che con lui avviene la rottura più radicale nell’arte del Novecento. Io penso che è nella trasversalità che bisogna cogliere la lezione di Duchamp.
Duchamp ha fatto tutto: disegno, pittura, scultura, oggetto, scrittura, cinema, happening e performance, installazione, allestimenti, è stato organizzatore di mostre e fondatore di società, per non parlare delle sue anche se brevi occupazioni come bibliotecario, tintore, piccolo ingegnere. Questa trasversalità è la più complessa e sfuggente eredità che ha lasciato.
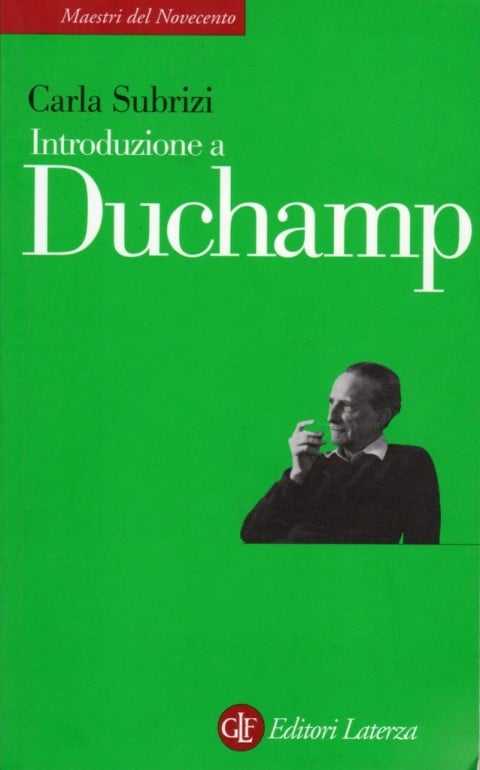
Carla Subrizi, Introduzione a Duchamp, 2008
In che modo ha influito, invece, l’orientamento riduzionista di Duchamp sugli sviluppi del suo lavoro?
La riduzione è stata fondamentale: “Ridurre, ridurre, ridurre era la mia ossessione”, diceva nel 1947 a James Johnson Sweeney. Ha “ridotto” tutto: le opere che ha realizzato in una vita, gli argomenti che ha trattato, il suo comportamento. Ma soprattutto la riduzione ha interessato quella che chiamava apparenza, in ogni senso possa essere intesa. Ridurre ha voluto dire de-monumentalizzare la figura dell’autore “che si crede un dio” (diceva Duchamp), rifiutare i giochi dell’estetica lontani dalla vita ordinaria e dal banale, sottrarre alla bellezza ogni metafisica e soprattutto all’opera d’arte l’idea che rappresenti qualcosa.
Questo aspetto coincide con la critica all’apparenza. L’apparizione indicava, al contrario, il processo attraverso il quale l’immagine o la parola, che ha anche usato moltissimo, si danno a vedere, lentamente. Niente spettacolo e niente formalismi: piuttosto la formazione come divenire di un pensiero, sempre a distanza da quanto invece si risolve nella pura visione che Duchamp definiva l’aspetto retinico dell’arte, ovvero quello che si rivolge ai soli occhi. L’arte doveva diventare una cosa mentale (o ridiventarlo). Questi pochi ma saldi pensieri sull’arte hanno interessato tutta la sua produzione: proprio perché il mentale non era soltanto riferito all’opera in sé ma all’essere artista in relazione al sistema musei, gallerie, mercato e alla storia.
Gran parte della lezione duchampiana, compreso l’approccio segnatamente riduzionista, è stata ereditata soprattutto dalle pratiche artistiche diffusesi negli Anni Sessanta. Tuttavia, se consideriamo la sua evoluzione da allora a oggi, ci accorgiamo che non tutta l’arte è designabile come concettuale o post-duchampiana, anche perché numerosi artisti si esprimono ancora in modi molto convenzionali. Qual è dunque l’effettiva portata dell’intuizione duchampiana rispetto all’evoluzione dell’arte fino ai giorni nostri?
Precisiamo questa distinzione ovvero tra arte concettuale e arte convenzionale. Sappiamo che Duchamp non aveva affatto simpatia per il termine “concettuale”, al quale preferiva “mentale”. Certamente l’arte concettuale è erede di Duchamp ma lo sono anche John Cage, Fluxus, la Pop Art, lo happening, certe pratiche performative e tanti artisti o ricerche che sono fuori da ogni tendenza. Insomma come spesso si è detto, vogliamo ribadire che tutta l’arte dopo Duchamp sia stata concettuale? Io credo che questa importante tendenza del secondo Novecento vada ripensata e ridefinita: la riscrittura dell’arte concettuale è iniziata negli Anni Novanta e la mostra Global Conceptualism è stata in questo senso molto importante poiché rintracciava molteplici “punti di origine” dell’arte concettuale, tra il 1950 e il 1980, in tutto il mondo, dall’America Latina, all’Africa, all’Europa dell’Est, alla Russia oltre che in Europa e nell’America del Nord naturalmente. Si toglieva un’esclusività nell’origine a questo movimento.

Marcel Duchamp, Rotoreliefs, 1959
È stato detto più volte che Duchamp è stato un antiartista, che la sua fosse una antiestetica (la bellezza d’indifferenza). Ma un altro dei suoi argomenti ricorrenti è stato quello di criticare gli “ismi” della storia dell’arte, dall’Impressionismo al Surrealismo, ai formalismi per non parlare poi di quando gli “ismi” diventavano “neo” o “post”. Direi che fuori dall’intuizione duchampiana, come lei la chiama, sia l’artista che cerca di adeguarsi o rientrare in una tendenza. L’arte è rischio e coraggio (anche se talvolta con ironia). Se pensiamo che Duchamp ha avuto la sua prima grande mostra in Francia, a Parigi, nel 1977, capiamo che non è stato l’artista riconosciuto e celebrato dal sistema dell’arte e del mercato. Molti rifiuti e presenze assai limitate nelle mostre e nei musei. Fece lui stesso il proprio museo “in valigia” ma ancora prima aveva fondato, nel 1920, con Katherine Dreier la Société Anonyme: una società che promosse mostre internazionali e collezionò opere di artisti che avevano avuto poche (o talvolta alcuna) mostra o riconoscimento istituzionale. La sua è stata quindi una posizione sempre critica, spesso provocatoria, dentro o fuori il sistema dell’arte per sfuggire alle classificazioni. La convenzionalità si produce nell’aderire appiattendosi sui linguaggi di moda; non è, e questo vale per me ancora oggi, nei mezzi usati ma nel modo in cui questi sono usati e nel senso di cui sono gli indici.
Le ricerche di diverse artiste contemporanee – tra le quali Gina Pane, Joan Jonas, Hanne Darboven, Nancy Spero – sono l’oggetto del suo ultimo libro Azioni che cambiano il mondo. Quanta importanza ha avuto, ai fini di tali ricerche, la teorizzazione di Lucy Lippard circa la dematerializzazione dell’oggetto artistico?
Parlo anche, seppur non abbastanza, di Lucy Lippard nel mio libro. Nel 2000 avevo parlato in un altro libro di corpo disperso dell’opera d’arte: lì la dematerializzazione era al centro di un’indagine, tra arte e filosofia (Cézanne, Merleau-Ponty, Bacon, Deleuze, Gina Pane, Barthes ecc.), su artisti e teorie che avevano affrontato il nulla, l’invisibile e l’irrappresentabile, l’assenza, il vuoto o l’opera come azione. Lucy Lippard è sicuramente un punto di riferimento storico soprattutto per la sua convinzione che la critica sia un atto politico che per lei voleva anche dire essere femminista e scegliere l’impegno in prima persona, coinvolgendo se stessa, senza riserve, nel suo lavoro. Nello stesso anno, il 1966, da cui inizia il suo libro (una sorta di calendario o diario) della “dematerialization of the art object”, curava tuttavia la mostra Eccentric Abstraction, una mostra che riportava l’attenzione sul corpo, la fisicità, la materialità. Artisti presenti alla mostra tra i quali Eva Hesse e Louise Bourgeois dimostravano che la geometria fredda e astratta del Minimalismo poteva essere integrata dal corpo fisico dei materiali. Quindi dematerializzazione e rimaterializzazione coincidevano: da questa apparente contraddizione si avvia il grande contributo critico di Lippard, dal quale non si può sfuggire. Per me è proprio l’intreccio tra critica, politica (il femminismo, anche, come movimento e prospettiva politici), dematerializzazione come sfida alla rappresentazione e al formalismo, rimaterializzazione come ricerca di un incontro tra corpo e linguaggio, che costituisce il nodo complesso su cui continuare a interrogarci.

Carla Subrizi, Azioni che cambiano il mondo, 2012
Tanto le pratiche delle artiste quanto la vasta gamma di opere contemporanee che popolano il nostro mondo, ci invitano tuttavia a considerare che gli oggetti, i corpi umani, i materiali e le registrazioni (siano esse video o fotografiche) non sono state completamente messe fuori circuito. Dal suo punto di vista, l’obiettivo della dematerializzazione è stato davvero raggiunto? E se così, quali sono i principali modi in cui le artiste e gli artisti l’hanno conseguito?
Torno ancora sul concetto di dematerializzazione per rispondere a questa domanda. La dematerializzazione non è stata una tendenza o un movimento artistico. Per Lippard era prima di tutto una questione estetico-filosofica, critica e teorica: un punto di vista sull’arte e non la definizione di alcune tendenze in essa presenti. La dematerializzazione non si risolveva nell’individuazione di una serie di opere “dematerializzate” ma nel riconoscere come pratiche, opere e poetiche degli artisti contribuissero a “smaterializzare” i tradizionali paradigmi estetico-critici dell’arte allora ancora molto forti e presenti: l’estetica di Greenberg, le politiche dei musei americani di quegli anni, il dominio quasi esclusivo di alcune tendenze artistiche (l’Espressionismo astratto ad esempio) dovevano essere contrastati.
Le pratiche delle artiste, l’utilizzo del corpo umano e di media quali la fotografia e il video, l’affermazione di attività incentrate sul riscatto dell’identità femminile nell’arte contemporanea, sono da lei studiate assumendo la distinzione tra azione e performance. Che differenza c’è tra le due e perché ha ritenuto opportuno condurre le sue ricerche in virtù del primo termine anziché del secondo?
La distinzione che ho fatto nel libro è stata un pretesto per fare alcune riflessioni sul lavoro di artiste che sono state un esempio dell’intreccio di ricerca (nell’arte), impegno politico, sfida ad alcuni canoni culturali della storia. Quindi usare il termine ‘performance’ avrebbe costituito una restrizione: mi sarei dovuta limitare più alla performance come genere artistico, diciamo. Ho usato invece ‘azione’ nel senso più ampio di arte come agency come pratica di attivazione di comportamenti, partecipazione, appartenenza comune, impegno politico. Alcune artiste (quindi non necessariamente tutte le artiste), come dico all’inizio del libro, hanno fatto dell’arte uno strumento di conoscenza di sé, di crescita e azione politica: l’individuale (o il personale come si diceva negli Anni Settanta) è divenuto politico.
La performatività è altra cosa: anche la performance è una pratica performativa. Performativo può essere il linguaggio come già diceva Austin alla fine degli Anni Cinquanta: “Fare cose con le parole”, ovvero si può agire per costruire e realizzare attraverso il linguaggio. È più facile dire performing language, history, text, body in inglese invece che dire “performare” qualcosa in italiano: non è una bella parola. Ma in questo senso ho usato azione: fare dell’arte una pratica per agire se stessi, le relazioni, lo sguardo e l’impegno politico (partecipativo, attivo) nella storia. Un divenire attraverso l’arte costruendo sia se stessi come soggetti sia la propria azione culturale.

Joan Jonas, Reading Dante, 2009 (frame dal video). Courtesy Galleria Raffaella Cortese, Milano
Consideriamo dunque l’evoluzione dell’arte fino ad oggi. Secondo lei, l’arte è essenzialmente ideazione o azione?
La parola ideazione rispetto ad azione contiene la parola idea: insieme, nel cortocircuito dei significati (idea e azione) il primo indebolisce il secondo termine. Quindi preferisco senza dubbio azione. Le idee sono importanti come frutto di immaginazione: quindi torna il termine azione insieme, però, a immagine. Ma se usiamo questi due termini per osservare l’arte, come lei dice, fino ad oggi, avverto una specie di vertigine.
L’arte, e forse questa è la sua forza, non è mai completamente una cosa o un’altra. Le contraddizioni spingono spesso sui lati meno interessanti del suo fare (mercato, istituzioni, strategie del successo), quando questi sono un po’ fine a se stessi. Ma c’è sempre la storia che ci ricorda che altre cose sono state fatte, che l’arte è stata anche denuncia di questi meccanismi, che l’industria dello spettacolo ha mostrato più volte la sua debolezza dalla quale risorge tuttavia sempre per molte ragioni che non posso qui neanche accennare. L’arte vive quindi proprio in questa molteplicità, si nutre del diverso, sceglie l’errore (perché non è una scienza esatta, né una filosofia, non risponde a nulla perché non ha leggi che regolino quello che si può o non si può pensare), azzarda l’imprevedibile, combatte o anche, sceglie altre volte il conformismo. Ma questo non vuol dire che accettiamo il mondo così come è.
L’arte ci serve a immaginare il diverso e il possibile, serve per vivere: Louise Bourgeois diceva “arte come salute mentale”. L’arte serve per sfidare e cambiare quello che sembra irremovibile. L’arte anticipa e a volte non lo vediamo perché credo sia più difficile da leggere e capire di un libro anche complesso. Non so dunque se l’arte sia stata più azione o ideazione, se sia più dalla parte del cinismo o dell’impegno politico. Tuttavia, non voglio giudicare o scegliere quello che è bene o che è male. Finché nel mondo ci saranno l’orrore, la guerra, le economie delle forme di capitalismo più diverso, la violenza sull’altro, il sopruso, le logiche di potere finalizzate al rafforzamento dei poteri, il colonialismo culturale, l’incapacità di pensare il lavoro per tutti, quello che cerco e che mi interessa sostenere, all’interno di una società dello spettacolo sempre più seducente, è l’arte che produca azioni nei confronti di tutto questo. Anche un piccolo disegno o un video possono farlo.
Davide Dal Sasso
 1 / 6
1 / 6
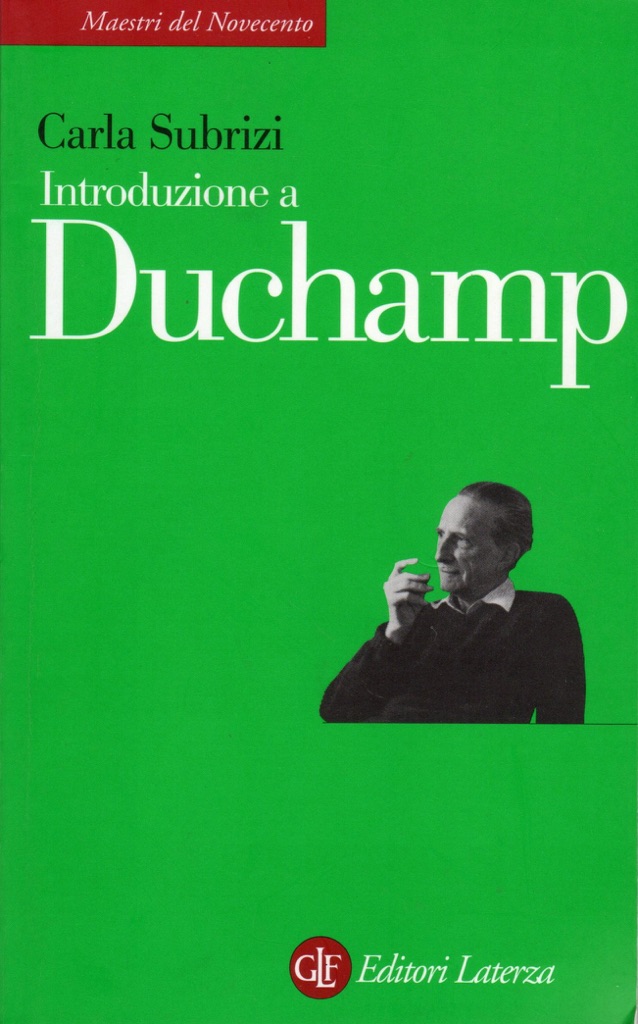 2 / 6
2 / 6
 3 / 6
3 / 6
 4 / 6
4 / 6
 5 / 6
5 / 6
 6 / 6
6 / 6
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati