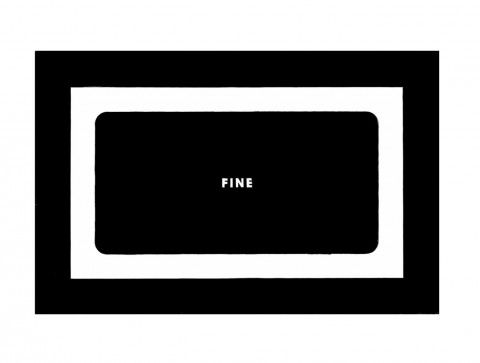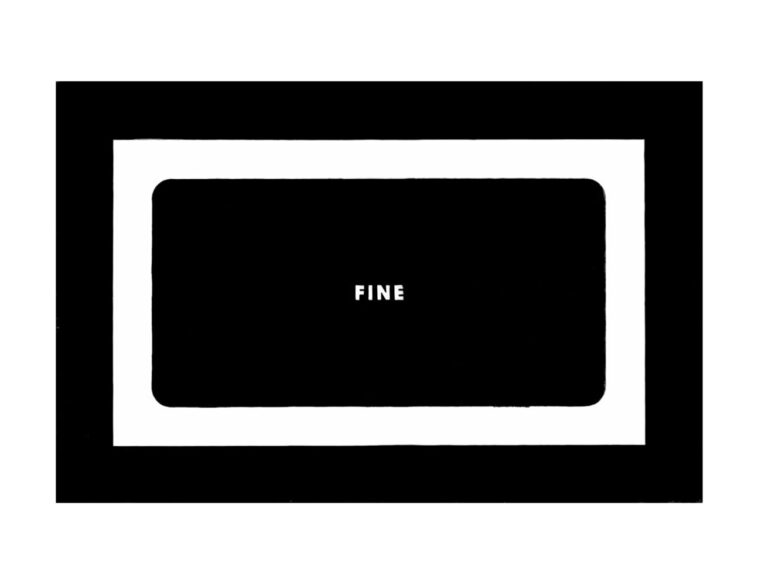Biennale di Venezia 2015. L’opinione di Gian Maria Tosatti
La Biennale di Venezia, diretta quest’anno da Okwui Enwezor, ha appena aperto al pubblico. Ve l’abbiamo raccontata in diretta durante le giornate di preview, sul sito, su Facebook, su Twitter, su Instagram, su Periscope… Ora diamo spazio alle riflessioni a mente più fredda. Con una serie di interventi corali, com’è nel nostro Dna.

LA GUERRA DEGLI STATEMENT: GIONI ED ENWEZOR
Due anni fa, mentre il mondo mostrava le lacerazioni più forti dovute alla crisi del capitalismo e prima che il maquillage di Wall Street riuscisse a farci dimenticare di trovarci ancora sul bilico di un baratro che si allarga, Massimiliano Gioni sceglieva di esporci una specie di tesi di laurea sul tema dell’enciclopedismo. Una scelta politica precisa che giustificava coloro che – sempre “politicamente” – sceglievano di non volerla visitare. Niente contro il curatore, contro la sua carriera o le sue idee, ma è pur giusto che all’esposizione di una tesi o di uno statement si risponda in modo dialettico e non sempre e solo subendo. Così la pensavo allora e così l’ho pensata anche più recentemente, quando, di contro, mi sono trovato a condividere ideologicamente lo statement di Okwui Enwezor presentato in conferenza stampa per questa 56. Mostra Internazionale d’Arte. Poi ho preso un treno per poter approfondire i contenuti esposti attraverso l’esperienza visiva in Laguna.
L’ASSENZA DI DIDASCALIE E LO SNOBISMO
Col senno di poi, potrei dire che forse avrei trovato meno deludente la mostra di Gioni, anche sul piano politico. È vero, infatti, che non esiste niente di più autoreferenziale, antipopolare e snob di una grande mostra priva di apparato didattico e di spiegazione delle opere (che invece il direttore del New Museum aveva scrupolosamente compilato). Il curatore attuale sceglie di comunicare al pubblico solo nome dell’autore, titolo dell’opera e anno di realizzazione. Scelta che funziona al massimo per una manciata di lavori che, essendo vere e proprie “opere”, hanno una forza propria, ma che risulta deleteria per la quasi totalità del resto che, sempre per volontà di Enwezor, appartiene al dilagante e noiosissimo universo della cosiddetta “documentazione”. Ma, appunto, una documentazione non spiegata né introdotta, è, ça va sans dire, un ammasso di carte mute, e, passata l’inaugurazione – in cui gli addetti ai lavori stessi hanno avuto una notevole difficoltà di orientamento –, con l’arrivo dei visitatori comuni, l’effetto Alberto Sordi sembra inevitabile. Ma d’altra parte non può esserci niente di più coerente con un mondo dell’arte che da decenni è convinto di bastare a se stesso e che si sottrae, invece di darsi, offrirsi in soccorso, al popolo (la scelta di questa parola, in luogo di “pubblico”, non è casuale). Una voluta vasectomia comunicativa, quella di Enwezor, che fa il paio con la Biennale di Bice Curiger, se non fosse che, almeno sulla carta, la nativa Svizzera di quest’ultima e la Nigeria che figura, quasi ostentatamente, nel passaporto personale e professionale dell’attuale curatore non siano (o per lo meno non dovrebbero essere) sulla stessa latitudine. Ma così non pare in questa biennale gentrificata dove Basilea e Lagos finiscono disinvoltamente per assomigliarsi. Tanto valeva allora che le letture del Capitale fossero in swiss german, perché mi pare che capire o far capire non fosse una priorità.
LE CAMPANE MUTE
Ecco dunque il primo, evidente, prodotto inverso dello statement di Okwui. Ci si intrappola da solo e a quel punto dà il via alle opere stesse di rivoltarglisi contro fino a completare quel rovesciamento evidente delle intenzioni che si palesa fin dal titolo che non torna. “Tutti i futuri del mondo” è la frase chiave che dovrebbe disciplinare la lettura di questa Biennale, rivolta, sulla carta alle possibili prospettive. Entrando, già dall’Arsenale, invece il ricorrere di elementi smaccatamente legati alla ritualità funeraria sembra proporre una narrativa opposta all’idea di futuro. Campane ovunque, ma campane mute, staccate, deposte, talvolta esse stesse maceria in mezzo a macerie, oggetti in vetrina che paiono urne simili a quelle delle sepolture antiche e poi veri e propri riti funebri nelle opere forse più belle della mostra, come il video di Steve McQueen Ashes o la videoinstallazione di Theaster Gates, Gone are the days of shelter and martyr. Le opere brutte o trascurabili non saprei dire se esprimessero altre prospettive, ma per inefficacia propria, esaltata poi dall’approccio turistico indotto da una curatela che nega l’approfondimento, non sono neppure arrivate a essere appunto da raccogliere in un eventuale ragionamento critico. E così si prosegue con le campane, dalla The Bell di Hiwa K, fusa con metallo di armi, a quelle che Christian Boltansky dissemina su un campo che sembra appunto una trappola giapponese per anime trapassate e che, non a caso, si intitola Animitas.
Immagini di una crisi irreparabile e passata sono anche quelle dell’opera forse più forte di questa biennale, fortunatamente dell’unico nome giovane in grado di incidere, Meriç Algün Ringborg, un interno borghese composto fino alla glaciazione della morte, un piatto rotto a terra, apogeo di una crisi irrisolta e un planisfero cancellato, sommerso forse, dall’acqua. Una annunciazione che precede la grande morgue dedicata a Baselitz, che somiglia a una fossa comune dell’umanità.
LA MORTE AI GIARDINI
Non si cambia musica ai Giardini, dove la banalità di Murillo e delle sue bandiere nere (già viste a firma di altri vari ed eventuali in una mezza dozzina di biennali precedenti), serve a introdurre la grande sala dedicata a Fabio Mauri in cui campeggia in dodecafonia la parola FINE / THE END. Un inizio niente male per il secondo capitolo di All the world’s futures. Che vede il suo picco nelle fotografie cancellate di Adrian Piper con la scritta “Everything will be taken away“, capolavoro che con un gesto ci ricorda appunto come tutto ciò che conosciamo, che chiamiamo “casa”, sia già stato superato dalla Storia, spazzato via come le terre emerse nel mappamondo di Ringborg, e che le nostre vite attuali sono niente più che il sogno comatoso e reazionario di una generazione falciata almeno dall’anno della morte del suo profeta, Pier Paolo Pasolini.
E, infatti, parlare di vitalità in una mostra che suona le uniche note udibili per bocca di artisti ultra-sessantenni se non sepolti, con una sola eccezione, è puro controsenso. Qui finisce la Biennale che non ho già dimenticato mentre sono sul treno del ritorno, e che sarebbe stata perfino una bella e tragica Biennale se si fosse davvero limitata a questo pugno (nello stomaco) di opere. La morale sarebbe stata ed è: tutti i futuri del mondo sono finiti, e da un pezzo, se la parola “fine” l’ha scritta un artista morto di vecchiaia sei anni fa. Enwezor sarebbe stato così messo schiena a terra dalla sua stessa mostra, ma in un orizzonte di duello da tragedia greca.
E, invece, le centinaia di opere in più (appese anche nei corridoietti di servizio) senza le quali sembra proprio che questa Biennale non si potesse fare, la riportano dalla dimensione di un rito catartico realmente popolare (quello appunto del teatro nell’età di Pericle) a quella della solita partita di polo, un gioco di cui, a parte il Principe William d’Inghilterra e un manipolo di suoi amici reali (anche africani, perché il continente nero non è fatto di soli poveri), la quasi totalità del mondo ignora le regole. Ma a chi importa? D’altra parte il polo non è mica roba per sudditi…
Gian Maria Tosatti
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati