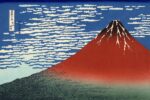MUSEI ACCESSIBILI
Siamo negli Stati Uniti, il Paese che nelle sue maggiori città ha realizzato musei imponenti, giustificando il vanto di collezioni importanti. Staff di lavoro che possono includere fino a centinaia di persone e finanziamenti spesso privati e generosi. Realtà perlopiù non profit, che si pongono frequentemente obiettivi di sviluppo in rete con le organizzazioni più diverse: ospedali, università, centri d’inserimento lavorativo, associazioni di veterani… Qui i musei sono una cosa seria, insomma, punti di riferimento per la crescita culturale e civile del Paese e, soprattutto, delle sue comunità. Per questo motivo, la riflessione sui pubblici è spesso concepita secondo approcci che ne analizzano in profondità la complessità dei bisogni.
Ho compiuto un viaggio, un percorso di quattro mesi negli Stati Uniti finanziato da un bando della Fondazione Banca del Monte di Lombardia per confrontarci con le migliori pratiche per l’accessibilità. Si inizia da Chicago per proseguire con Los Angeles e San Francisco, la costa est (Boston, Philadelphia e Washington) e infine New York.
Quello dell’accessibilità è un tema articolato, sia sul fronte dei contenuti che su quello delle percezioni comuni. Di fatto, riguarda una battaglia per i diritti e un universo di stereotipi spesso associato esclusivamente alle barriere architettoniche. In realtà, il termine ‘accessibile’ non si riferisce solo a spazi che garantiscono l’ingresso fisico, ma anche a proposte finalizzate al coinvolgimento sensoriale, alla comprensione cognitiva, al benessere emotivo, alla tenuta della motivazione. Il riferimento è quindi alla disabilità visibile e invisibile ma, soprattutto, a ciò che può realizzare il contesto per abbatterla: pratiche multisensoriali, narrative, scalabili negli obiettivi di apprendimento, aperte, flessibili. Nello specifico museale, un esempio concreto sono i contenuti e le forme delle didascalie: non per forza, dunque, strumentazioni costose ma soluzioni che, in questo caso, si sviluppano da una riflessione sulle leggibilità del testo in termini visivi, di comprensibilità e capacità di coinvolgimento.
Esistono anche qui realtà brillanti ma senza fondi; musei che vorrebbero essere accessibili ma non lo sono davvero; esperienze pilota senza alcuna garanzia di continuità. Eppure, fra queste si collocano approcci e un sistema di pratiche dai quali abbiamo da apprendere. Del resto, qui l’inclusione arriva da lontano: prende origine dall’attivismo sociale e da una legge forte e strutturata. Nasce in un contesto di strutture relativamente recenti, dalla cura generale dei servizi di “customer service” e dalla spinta, tutta americana, alle finalità museali di tipo educativo.
UN CONVEGNO A CHICAGO
Chicago, Illinois, è la prima città. Qui si svolge la LEAD – Leadership Exchange in Arts and Disability Conference, un convegno, alla sua 15esima edizione, dedicato all’accessibilità dei luoghi della cultura e organizzato dal Kennedy Center di Washington. Si parla di musei, teatri e performing center, con l’idea di poter reciprocamente apprendere da contesti differenti. Diverse questioni, condivise e non necessariamente museali, facilitano il confronto a partire da una consapevolezza comune: 1. La legislazione. Tutto questo non sarebbe possibile senza il supporto offerto da una legge del 1990, l’ADA – Americans with Disabilities Act, che obbliga i servizi aperti al pubblico ad adottare le linea guida indicate per l’accessibilità. La legge è quasi ovunque rispettata e diversi musei hanno nel proprio staff una persona incaricata esclusivamente del suo studio e della sua applicazione. 2. Il linguaggio. La lingua cambia costantemente il proprio lessico col crescere della consapevolezza sociale, rendendo inappropriate parole considerate d’uso comune fino a poco tempo prima. È un discorso sempre attuale, affrontato da più parti anche in Italia, per il quale termini come ‘handicappato’ o ‘diversamente abile’ non sono più ritenuti corretti. La persona ora è riportata al centro (people-first language) e la disabilità definita solo in seconda istanza, quale una fra le sue molteplici caratteristiche. “People with disabilities” rimane quindi anche qui l’espressione più usata. 3. I modelli di percezione. Da un modello della disabilità di tipo medico a uno sociale, la disabilità è interpretata non più alla stregua di una malattia ma come conseguenza di fattori ambientali e sociali. È il contesto, infatti, che genera una difficoltà e la enfatizza. Una scala all’ingresso di un museo, intesa quale unico accesso, impedirà di entrare a una persona su sedia a rotelle. Qualora ci fosse una rampa, la disabilità non rappresenterebbe un problema. 4. L’Universal Design e l’Universal Design for Learning. In questo caso ci si riferisce all’adozione di metodi per la progettazione (di luoghi, oggetti, informazioni e comunicazioni) adatti a tutti. “One size doesn’t fit for all” è il motto di un approccio che fa della flessibilità una strategia in grado di offrire a ogni individuo le stesse opportunità. La condizione di partenza è quindi l’analisi dei fruitori, escludendo qualsiasi concetto di normalità arbitraria. La disabilità è concepita quale condizione che può colpire tutti, manifestarsi con l’età o in via temporanea, e la già citata rampa sarà utile anche a chi conduce un passeggino.
Date per assodate queste questioni (le stesse sulle quali ci si confronta anche in Italia), è qui possibile indagare in profondità altri aspetti più specifici e meno noti. Si parla molto di formazione del personale, di supporto emotivo, dell’inclusione delle persone con disabilità di provenienza straniera, di best practice per la linearità descrittiva, di valutazione, di supporti tecnologici e molto altro ancora. Ci si confronta fra professionisti diversi per competenze, in un mercato delle professioni più strutturato del nostro, soprattutto per opportunità di aggiornamento e crescita. Più in generale, quello dell’educazione museale è un ambito dinamico. Con il supporto di centinaia di volontari (in alcuni musei si calcolano anche due anni di attesa), chi conduce le attività sono principalmente i contractuals, affiancati da personale dedicato all’accessibilità. Con veri e propri dipartimenti finalizzati a promuovere l’inclusione. I maggiori musei hanno un gruppo di lavoro dedicato ai pubblici con disabilità o, più facilmente, la riflessione pragmatica su questi temi si sviluppa nel più ampio ambito di coinvolgimento delle comunità (territoriali, straniere, associative e molto altro ancora). Advocacy, la chiamano qui. È il farsi portavoce di qualcuno e dei suoi interessi, e far sì che l’istituzione di cui si è parte si dimostri rispettosa, accogliendone le istanze a favore della partecipazione.
ADVOCATES E CAREGIVERS
Di advocates, nel corso di questo viaggio, ne ho incontrati moltissimi. Il presupposto implicito del loro lavoro risiede in un principio di collaborazione trasversale. Del resto, i professionisti museali che lavorano nell’ambito dell’accessibilità hanno spesso un background di tipo educativo o artistico: in questo senso, il confronto diretto con altre realtà, spesso associative e di supporto, rappresenta un requisito di base. A un livello superiore, spesso su base territoriale, stupisce (e conforta) l’esistenza sempre più diffusa di consorzi per la condivisione delle best practice: è il caso degli storici Museum Access Consortium di New York, del CANE – Cultural Access New England, e dei più recenti fondati a San Francisco e Chicago. Sempre in termini di costruzione di rete altre due colossali istituzioni contribuiscono alla diffusione di una consapevolezza comune: è il caso della già citata John Kennedy Performing Center (promotrice anche dell’International Organization on Arts and Disability) e dello Smithsonian Institute di Washington, quest’ultimo autore di un imprescindibile documento che definisce le principali linee guida per l’accessibilità museale.
In questo settore si è compreso che, rispetto alla concorrenza, la condivisione rappresenta una strategia più efficace. Del resto, gli stessi visitatori con disabilità e i rispettivi caregiver sei rincontrano settimanalmente in musei diversi; le persone rincorrono proposte con entusiasmo, partecipando a esperienze differenti soprattutto per temi, collezioni di riferimento e contesti. Questa pratica di collaborazione spesso assume valenza verticale. L’accessibilità, d’altronde, è anche frutto di decisioni legate alla struttura fisica del museo, nonché relative all’articolazione dei contenuti esposti. Per questa ragione, numerose esperienze prevedono la collaborazione attiva fra dipartimenti curatorali ed educativi, abbattendo l’implicita gerarchia presente anche nei nostri musei. Luoghi come il Whitney Museum e il Metropolitan Museum of Arts, il MoMA, i Fine Arts Museums di San Francisco e, più recentemente, il Contemporary Jewish Museum (solo per citarne alcuni) lavorano proprio a partire dalla condivisione delle pratiche corrette.
ESEMPI ESEMPLARI: IL GETTY DI LOS ANGELES
Proposte per la formazione, incontri periodici, linee guida condivise sono gli strumenti principali che consentono ai musei di agire coerentemente rispetto a obiettivi di accesso, spesso esplicitati anche nelle mission. Obiettivi che spesso muovono nella stessa direzione del museo quale istituzione calata nel presente: l’accessibilità quale pratica creativa, connessa al critical thinking e che non si affida esclusivamente al testo per le sue comunicazioni. Ovviamente, tutto questo accade a partire dalla collaborazione fra la direzione, i diversi dipartimenti e le comunità con disabilità per una riflessione che non riguarda solo i musei d’arte: centri come lo storico Museum of Science di Boston o l’Exploratorium di San Francisco sono la dimostrazione di come ogni museo possa diventare centro di ricerca e sperimentazione sui processi di apprendimento e le pratiche di accesso.
D’altro canto, l’accessibilità si intreccia inevitabilmente con la pratica educativa: tenta la messa in discussione degli spazi, rende esperienziale la visita, incentivando le aspettative e supportando la tenuta della motivazione. Il caso del Getty Museum di Los Angeles è emblematico: completamente accessibile da un punto di vista fisico e sensoriale, non esplicita la propria accessibilità cognitiva, ma la delega alla didattica anche nell’articolazione su più livelli di tutti i contenuti.
Maria Chiara Ciaccheri
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #24
Abbonati ad Artribune Magazine
Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati