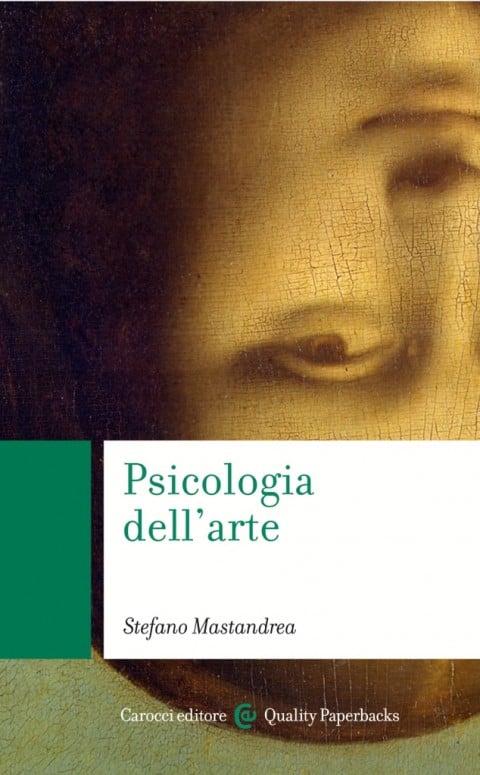Dialoghi di Estetica. Parola a Stefano Mastandrea
Stefano Mastandrea è professore associato di Psicologia generale e di Psicologia delle arti presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. Dal 2008 è segretario dell’International Association of Empirical Aesthetics. Con lui abbiamo parlato dei diversi approcci negli studi psicologici sulle arti, del ruolo e della natura della rappresentazione nelle creazioni artistiche e delle nuove direzioni delle ricerche psicologiche in rapporto alle trasformazioni dell’arte.

Un’importante svolta nella psicologia novecentesca si deve all’affermazione del cognitivismo. Che influenza ha avuto sulle ricerche di psicologia dell’arte?
Il cognitivismo ha contribuito a rendere più chiari e comprensibili i processi che presiedono all’elaborazione delle informazioni. L’apporto più affascinante, a mio avviso, è l’interconnessione che ha cercato di stabilire tra processi di natura diversa come attenzione, percezione, memoria, linguaggio, pensiero ecc.
Da tutto questo la ricerca psicologica sull’arte ha avuto dei sicuri benefici. Direi che il cognitivismo ha contribuito a spostare le ricerche psicologiche sull’arte da un’estetica dal basso, iniziata con Fechner (il cui scopo era quello di stabilire quali forme, sulla base di caratteristiche strutturali, fossero preferite) a un’estetica dall’alto, che tiene conto dei processi di elaborazione di livello superiore come conoscenza, expertise, vissuto emozionale, tratti di personalità, differenze individuali.
Un aspetto introdotto più di recente, poiché all’inizio era bandito dal cognitivismo, è la componente emozionale che caratterizza l’esperienza estetica.
Nel tuo libro, Psicologia dell’arte, presenti i quattro principali approcci che hanno contribuito all’evoluzione delle ricerche psicologiche sulle arti visive: l’approccio psicoanalitico, la psicologia della Gestalt, l’estetica sperimentale e la neuroestetica. Tra questi, qual è secondo te il più importante ai fini di una maggiore comprensione dell’arte?
Dipende da che cosa si vuole comprendere dell’arte e che tipo d’impostazione di ricerca si predilige. A mio avviso, attualmente in ambito psicologico la ricerca sperimentale sull’arte è la via più interessante e più battuta dagli psicologi che vogliono contribuire a una maggiore comprensione del fenomeno. Sono segretario dell’IAEA – International Association of Empirical Aestetics, un’associazione che raccoglie gli studiosi, prevalentemente psicologi, che rivolgono la loro attività di ricerca all’arte. Ci riuniamo ogni due anni per il nostro congresso (nel 2014 è stato a New York, nel 2016 si terrà a Vienna).
Da questo osservatorio posso affermare che le ricerche sperimentali sono le più numerose e anche le più interessanti. In questi studi empirici vengono presentati sempre di più dati sui correlati neuropsicologici dell’esperienza estetica. Quello che voglio dire è che lo studio comportamentale molto spesso non è più sufficiente: si va oltre, con l’esplorazione dell’attivazione cerebrale durante la percezione estetica.
Qual è oggi il rapporto tra la ricerca psicologica e gli studi condotti nell’ambito dell’estetica filosofica?
C’è sicuramente interesse reciproco e rispetto, però i filosofi mostrano una sorta di “orrore” per i dati quantitativi tipici della ricerca sperimentale (con le conseguenti analisi statistiche), mentre gli psicologi sono forse un po’ “intimiditi” dalle riflessioni e speculazioni filosofiche che sorgono intorno ai temi dell’arte. Partecipo e sono invitato, di tanto in tanto, ai seminari della società di estetica che si tengono a Palermo e a Firenze; sono incontri molto interessanti, con buone discussioni, con ampie prospettive e con buoni propositi di collaborazione, ma poi rimaniamo – lo dico con rammarico – solitari e indipendenti nel portare avanti le nostre ricerche. È un problema di linguaggi: dovremmo sforzarci di più di comprendere l’uno quello dell’altro.
Sicuramente, le estetiche del Novecento hanno contribuito a estendere l’ambito di ricerca psicologica. Dalle Avanguardie del primo Novecento in poi, le categorie estetiche-emozionali come “bello”, “mi piace” ecc. segnano il passo. L’arte moderna/contemporanea va indagata anche secondo altre categorie come “interesse”, “attivazione” ecc., con riferimento alla sfera delle emozioni negative (disgusto, inquietudine ecc.) suscitate dalle opere.
Soffermiamoci un momento sulla rappresentazione. Lo psicologo Rudolf Arnheim, mantenendo come riferimento la produzione di immagini, la distingueva dai segni e dai simboli. Qual è il tuo pensiero in proposito?
Arnheim, con il suo libro Il pensiero visivo del 1969, ha compiuto un importante passaggio dalla teoria gestaltista a quella cognitivista. Il libro di Neisser, Psicologia cognitivista (1967), considerato il manifesto del cognitivismo, fu pubblicato solo due anni prima di quello di Arnheim. Il concetto di “rappresentazione” diventa con Arnheim centrale secondo questo nuovo modo di concepire la mente. Gli oggetti presenti nel mondo non sono a contatto diretto con i nostri organi di senso; l’atto visivo non è una pura registrazione passiva dell’ambiente fisico esterno, ma una costruzione attiva che implica processi di elaborazione e di analisi che culminano nella rappresentazione.
Arnheim afferma che un’immagine può svolgere diverse funzioni: un triangolo può essere percepito come pericolo, come montagna o come simbolo di una gerarchia. Estremizza il concetto di simbolo come livello di astrazione della rappresentazione di un’immagine; è simbolo anche l’immagine del cane quando questa è utilizzata per esprimere il concetto di cane. Trovo che questa sia un’esasperazione del concetto di rappresentazione; mi trovo più d’accordo con il concetto di segno iconico di Peirce e, in seguito, di Morris, inteso come segno diretto, simile per diversi aspetti a ciò che denota.
L’arte si sta evolvendo non solo attraverso la produzione di immagini ma anche in virtù dell’uso di oggetti naturali e ordinari, della realizzazione di eventi e performance, della crescente combinazione tra media diversi e del coinvolgimento diretto dei fruitori tramite pratiche relazionali e partecipative. Possiamo ancora pensare che le opere siano delle rappresentazioni?
Potremmo essere drastici e definire tutto “rappresentazioni”. In un altro ambito della psicologia, la psicologia sociale, Serge Moscovici ha introdotto il concetto di “rappresentazioni sociali”, inteso come una modalità di conoscenza che viene elaborata e condivisa socialmente dai diversi attori sociali con lo scopo di costruire insieme una realtà comune e condivisa.
Direi quindi che anche la nostra esperienza delle espressioni d’arte più contemporanee può essere fruita attraverso forme di rappresentazioni diverse, che di volta in volta ci costruiamo. Per esempio, l’opera d’arte partecipata è resa possibile da una modalità di fruizione conversazionale: il nostro interlocutore è l’opera e la rappresentazione che il fruitore si costruisce può modificarsi sulla base delle diverse esperienze individuali. Lo spazio all’interno del quale si colloca l’installazione viene rappresentato attraverso una mappa cognitiva. La modalità personale di interazione con l’oggetto d’arte, la nostra risposta emozionale a una performance artistica, sono forme diverse di rappresentazione della realtà in quanto mediate non solo dalla nostra mente ma anche dal nostro corpo.
Rispetto ai cambiamenti menzionati sopra, in che direzione stanno andando oggi le ricerche psicologiche sulle arti?
Come dicevo anche all’inizio della nostra conversazione, il boom delle neuroscienze ha trascinato all’interno del suo ambito di ricerca anche gli studi psicologici sulle arti. È evidente l’indubbio valore di tale prospettiva di ricerca.
Bisogna però aggiungere che ci sono degli aspetti critici in tale impostazione; essi si riferiscono principalmente al fatto che la descrizione percettiva a livello cerebrale non coglie in sé il senso completo dell’esperienza dell’arte. Il neurologo indiano-americano Ramachandran afferma che un mobile di Calder attiva i neuroni del lobo occipitale (nello specifico, l’area V5) allo stesso modo di quando osserviamo un maiale che corre. Con un altro esempio è stato dimostrato che i neuroni del cosiddetto giro fusiforme si attivano quando guardiamo un ritratto di Rembrandt come quando ci troviamo di fronte a una faccia qualsiasi.
Manca quindi la specificità dell’esperienza artistica…
Esatto. Ciò che si dovrebbe spiegare è che cosa c’è di speciale nel volto dipinto da Rembrandt e come questo differisca da una normale fotografia di un ritratto o da un selfie. Quando percepiamo e valutiamo un oggetto d’arte, attiviamo parti del cervello che usiamo anche per fare altre cose. Il cervello risponde all’arte usando le stesse strutture cerebrali che sono coinvolte, per esempio, nella percezione di oggetti quotidiani.
Nonostante tutti gli esperimenti neuroestetici sin qui condotti, non si è ancora arrivati alla scoperta di un modulo dell’arte nel cervello. Più in generale, nessuno dei quattro approcci proposti (psicodinamico, gestaltista, estetico-sperimentale e neuroestetico) è di per sé sufficiente per comprendere un fenomeno così ampio e articolato come quello artistico. Ognuno, però, prediligendo una particolare prospettiva, contribuisce a una comprensione sempre più estesa, approfondita e possibilmente integrata dell’arte.
Davide Dal Sasso
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati