Francesco Jodice e il declino dell’impero d’Occidente
Sperimentatore instancabile, Francesco Jodice è l'artista italiano che ha maggiormente riflettuto sul significato di narrazione. Su un tema, cioè, incandescente da cinquant’anni a questa parte, in un mondo che dipende sempre più da come ce lo rappresentiamo. Lo abbiamo intervistato a margine della mostra in corso al Castello di Rivoli e alla personale da Umberto di Marino a Napoli.
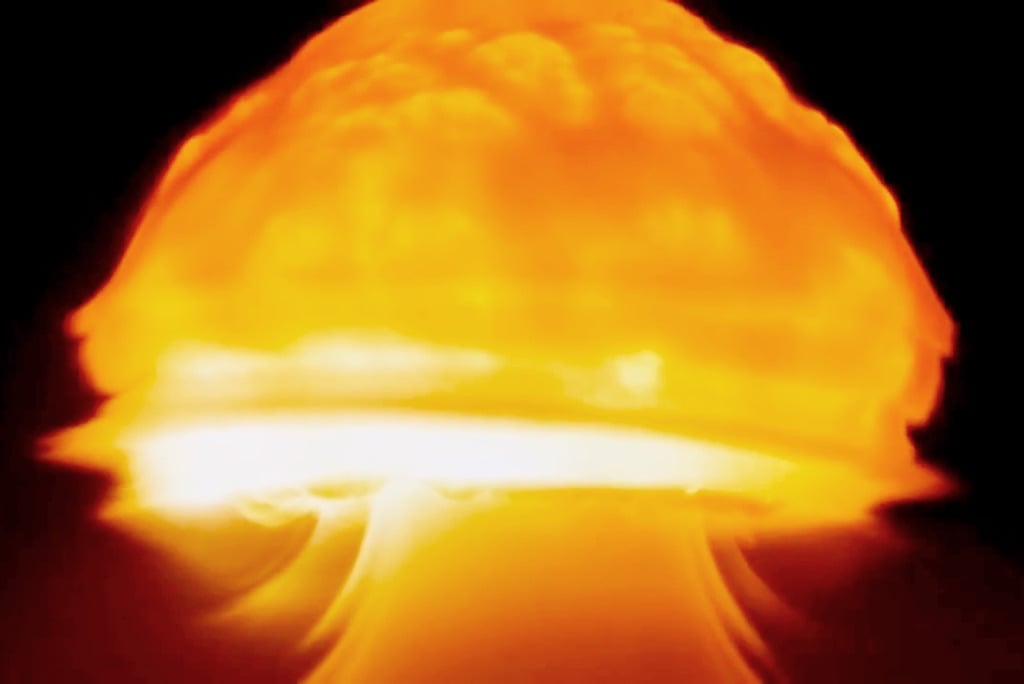
Il nostro mondo si fonda sostanzialmente su una rappresentazione i cui valori condivisi e le interpretazioni di fondo, così come gli orizzonti di senso, sono derivati da una civiltà dell’immagine prodotta e ordinata dalla capacità produttiva degli Stati Uniti. Un impero favoloso di cui Francesco Jodice (Napoli, 1967; vive a Milano) cerca le radici e i cardini d’appoggio, per giungere alla conclusione che è in atto una crisi più profonda di quella economica o politica.
Nel suo ultimo lavoro, American Recordings (videoinstallazione a 5 canali ospitata in una mostra curata da Massimo Melotti per il Castello di Rivoli, fino al 24 gennaio) usa la tecnica del mash-up per rivelare le radici di un immaginario al quale tutto l’Occidente appare debitore.
Come nasce il progetto esposto a Rivoli?
American Recordings è lo sviluppo di un’ossessione che coltivo da anni e che passa attraverso momenti della storia contemporanea che ci riguardano. Non si tratta soltanto di eventi cataclismatici come l’11 settembre o la grande era glaciale della crisi economico-finanziaria iniziata con la bancarotta di Lehman Brothers nel settembre del 2008, ma riguarda anche eventi minori, privi di una cuspide eclatante, che permettono di compiere un’analisi dello stato dei valori dell’Occidente.
Come hai pensato l’opera?
Come un osservatorio di diagnostica sulla storia recente, vista in chiave politica, economica e religiosa. Nella sua complessità si tratta di un progetto, quasi un ready made, che a Rivoli presenta l’installazione video come un portale d’ingresso, che ho pensato come una sineddoche.
Dopo essere stato ad Aral, Dubai e San Paolo con il progetto filmico Citytellers, torni agli Stati Uniti dove mancavi dal Caso Crandell. Cosa hai trovato?
Siamo in una fase di passaggio in cui il dominio culturale dell’Occidente, attraverso gli Usa, è in trasmutazione. L’impero americano è stato il primo, forse l’ultimo e comunque l’unico grande impero della storia a produrre un’occupazione de-territorializzata. Tranne in rari casi, ha occupato producendo una cultura pervasiva trasmessa per osmosi. L’arma virale è stata l’immagine: filmica, documentaristica, pubblicitaria. Nel progetto ho raccontato l’ascesa e la caduta di questo favoloso impero, trattandolo come se fosse quello ottomano o romano.
Un progetto in cui i video aprono a un libro, di cui parleremo, ma nei video per la prima volta usi la tecnica del mash-up, del collage, del patchwork di materiali filmici ready made.
Volevo far dialogare brani di film, di documentari e altro, tratti dalla storia americana costruendo una agorà con lo spettatore al centro. Questa forma di riutilizzo dell’archival footage l’ho usata già in un film breve, Atlante, presentato nella mostra Proportio a Palazzo Fortuny durante l’ultima edizione della Biennale di Venezia: è un film prodotto con la mia gallerista Michela Rizzo.
Una tecnica per te inusuale. Ma cosa cercavi?
Atlante è il mio primo lavoro de-territorializzato, nel senso che invece di andare sul posto a girare ho usato la forza dell’editing e del montaggio. Ho mixato immagini tratte dalla Prima guerra mondiale, dalla suburbia americana e dalla pubblicità degli Anni Cinquanta per indagare lo stato delle cose.
C’è un momento in cui metto insieme il discorso di addio di Eisenhower, un docente di meccanica quantistica tratto da un film di Carpenter, Angela Davis dei Black Panthers, il bassista dei Ramones e il cyborg del primo Alien: insieme sono come un coro, un’analisi critica del sistema di valori dell’Occidente. Ormai siamo davanti ai detriti della storia dell’Occidente, io ho preso i cocci e li ho rimontati per riscrivere il senso della storia.
La forma di questo progetto dimostra il tuo gusto per la sperimentazione.
Sono un artista incoerente e inorganico, almeno nella scelta del processo di formalizzazione. Quando inizio un progetto non so che modalità userò. In questo caso cercavo di raccontare come il potere di occupazione e seduzione degli Usa si sia esercitato anche attraverso la capacità di creare immagini. Oggi lo vediamo con la campagna di comunicazione di Star Wars.
Ha già superato il miliardo di dollari d’incasso, metà in casa Usa e metà all’estero, e mi pare che ciò sia una prova banale (Marx si porrebbe delle domande) di quanto dici in American Recordings.
Mi colpisce come Luke Skywalker lo si ritrovi sulle Highlands invece che nel deserto come accadeva nel primo film, un paesaggio molto meno “islamico” e più anglosassone, direi druidico.
Erri de Luca vorrebbe riprendere oggi il progetto di Walter Benjamin: progettare un libro di sole citazioni. Tutto è già stato scritto, si tratta dunque di rimontare i pezzi per distillare un’essenza pura di senso. Credi che sia possibile?
È quel che ho fatto nel libro American Recordings, l’ho scritto nei mesi estivi come testimonianza del processo della mostra ma anche come libro a sé, come opera d’arte non numerata ma di larga diffusione al prezzo di un libro. Edito da Humboldt Books, sta andando molto bene.
Ci sono i testi che tracciano la storia meravigliosa del secolo americano. Ho connesso tra loro 500 citazioni tratte da filosofi, giornalisti, comici, musicisti e altri fingendo una scrittura da moderatore. Un altro layer del libro è l’apparato iconografico, poi c’è la grafica alla quale ho collaborato come processo per costruire sensi.
Forse è il frutto di anni di ricerca sulle forme che usiamo per raccontare il mondo a noi stessi e agli altri. Passando al contenuto: Oswald Spengler parlava del tramonto dell’Occidente, cosa ne pensi?
Non sono un filosofo, un geopolitico o uno storico. Detto ciò, credo che l’indisponibilità dell’Occidente a confrontarsi con il proprio declino sia causa del declino stesso; non è in grado di confrontarsi con il cambiamento. Siamo terrorizzati da tasse, Isis e crisi economica, ma non affrontiamo il fatto che tutto ciò sia la conseguenza di decenni di soprusi: è la storia di tutti gli imperi, producono arte, storia, bellezza e libertà, ma anche aberrazioni.
Non siamo disposti ad accettare che qualcosa di epocale stia cambiando?
Non si accetta il passaggio di testimone, il cambiamento è però ricco di rinnovamenti, tra cui quello culturale.
Pensi che altrove si stiano producendo sistemi culturali alternativi a quello occidentale?
Sì, ma quando sei dentro il turbine di una fase storica fai fatica a percepire. Hans G. Gadamer dice che l’accelerazione della storia fa del rito di passaggio un fenomeno continuo. Trovo che alle notizie sugli attacchi dell’Isis non corrispondano notizie sulle responsabilità dell’Occidente. Ci si concentra su come una cellula singola sia stata sgominata, come se così si fosse salvato il mondo.
Eppure, fa notare Roberto Saviano, l’Isis sfrutta l’arma virale della comunicazione made in Occidente.
Quando fu costruito il progetto Manhattan, nei primi Anni Quaranta, furono coinvolti seicento fisici che erano consapevoli. Sapevano che stavano costruendo l’arma terribile e ne capivano l’urgenza. Un fisico disse: “Facciamo attenzione perché risolveremo questa guerra ma non le prossime”.
In generale, nella costruzione di un sistema di distruzione, o di comunicazione, nessuno calcola che prima o poi l’arma gli si rivolga contro. Quella potentissima arma di seduzione che è l’immagine è stata usata storicamente per propagandare la vittoria, ora diventa un’arma per diffondere il terrore.
È un nuovo capitolo di quella guerra di civiltà a cui, da tempo, ti interessi.
Le forze in campo sono impari, ma questa è la terza guerra mondiale. Cina, Russia e Stati Uniti non possono farla apertamente, non vi sarebbe un dopo. Quindi la terza guerra mondiale ha questa forma e l’arma da utilizzare è la comunicazione. È anche interessante notare la risposta dell’arte americana a questa situazione.
In che senso?
Nei miei corsi mostro agli studenti le immagini termocromatiche della prima Guerra del Golfo e subito dopo le comparo con le opere coeve esposte al MoMA di New York o al MOCA di Los Angeles per vedere come lo stile sia pacificato e disimpegnato.
Una discrasia intellettualmente imperdonabile a tuo modo di vedere.
Anche la tecnica di allora, con il ritorno in auge del disegno e della pittura, denunciava un anacronismo di linguaggio rispetto ai media con cui si sta facendo la storia del mondo. Trovo che sia un paradosso, perché l’arte deve essere altro. L’arte di oggi recupera in parte le proprie responsabilità etiche e civili, ma visto nel suo insieme il sistema dell’arte americano di quegli anni ebbe una grande responsabilità politica.
Facciamo in passo indietro in questo senso: Dubai Citytellers (2010-11) era il tuo terzo film dedicato a città e macroregioni dove si registrano inquietanti mutamenti. Il film narrava il neo-schiavismo in una zona cruciale e luccicante del mondo arabo. Che accoglienza ha ottenuto e come ha risposto alle tue aspettative?
Le produzioni di Citytellers sono costose e impegnative, significa andare in posti non facili e assumere dei rischi, ma i risultati sono significativi e per me importanti. Rimane uno dei miei progetti più seguito e richiesto.
In una nostra precedente intervista per L’Unità, nel 2012, ponevi l’accento sul fatto che Citytellers fosse un progetto pensato per avere massima diffusione, per debordare dai circuiti dell’arte contemporanea e assumere massima visibilità. Anche ciò fa parte del tuo modo di intendere la funzione e lo scopo dell’arte?
Il progetto infatti ha avuto e continua ad avere una notevole circolazione, su televisioni pubbliche di diverse nazioni e in prestigiosi festival cinematografici, oltre che nei musei.
Mi interessa sapere l’accoglienza di Dubai.
Ha generato tantissime reazioni, trasformandosi in una questione politica più radicale, universale se vuoi, anche se il fenomeno analizzato ha una dimensione locale. Tempo fa Walid Raad mi ha chiamato per intentare una class action artistica, perché l’avvocato che io intervisto in Dubai era stato arrestato due volte, torturato e morto in cella per cause misteriose; era il difensore dei diritti di questi lavoratori. Anche un sindacalista indiano, che avevo contattato e che non si era presentato al nostro appuntamento, pare sia scomparso misteriosamente.
Sembra una storia da film, mi perdonerai se dico così, del resto si usa ormai misurare la realtà paragonandola alla fiction.
Il film su Dubai è stato anche strumentalizzato in alcune occasioni, essendo durissimo con quella realtà locale del mondo arabo; per cui ho rifiutato alcuni inviti. Il film è stato usato in modo scomodo ma anche utile, credo. Non voleva essere scandalistico e credo che tra qualche anno Dubai sarà un documento storico, ma per ora è ancora ben vivo e di grande attualità, anche perché narra di una compromissione tra un certo mondo anglosassone e quello degli Emirati.
A cosa stai lavorando attualmente?
Sono stato da poco a Tokyo, città laboratorio su cui ho in mente di fare un progetto, in particolare sul quartiere di Akihabara “electric city”, ma è presto per dire. A maggio invece torno a Torino per una mia prima retrospettiva da Camera. Stiamo pensando a come impostare un libro adatto all’occasione.
Sarà un altro progetto d’artista?
Dovrebbe trattare tutti i concetti base del mio lavoro, come investigazione, networking, antropometria, partecipazione ecc. Ne sto parlando con Francesco Zanot, che curerà il progetto.
Nicola Davide Angerame
Rivoli // fino al 24 gennaio 2016
Francesco Jodice – American Recordings
a cura di Massimo Melotti
Catalogo Humboldt Books
CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia
011 9565222
[email protected]
www.castellodirivoli.org
MORE INFO:
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/47348/francesco-jodice-american-recordings/
 1 / 6
1 / 6
 2 / 6
2 / 6
 3 / 6
3 / 6
 4 / 6
4 / 6
 5 / 6
5 / 6
 6 / 6
6 / 6
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati















