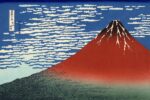If I were you I’d call me Us

If I were you, I’d call me Us è un progetto a lungo termine che nasce da una suggestione dell’artista Elisa Strinna sviluppata con la curatrice Elena Forin.
Comunicato stampa
If I were you, I’d call me Us è un progetto a lungo termine che nasce da una suggestione dell'artista Elisa Strinna sviluppata con la curatrice Elena Forin. Questa prima tappa del progetto vede protagonisti alla Galleria Massimodeluca sette artisti internazionali, tra cui la stessa Strinna. Il titolo della mostra, ripreso da una poesia del poeta americano Ogden Nash , allude alla possibilità di definire le identità in forma collettiva andando oltre ogni idea d’indivisibilità e aprendo a diversità, discussione, trasversalità, scambio o conflitto.
“L'idea di questo progetto – dice Marina Bastianello, direttrice della galleria - nasce dall’esigenza di Elisa Strinna di approfondire il dialogo con alcuni colleghi incontrati negli ultimi anni della sua ricerca. Partendo dalla necessità di articolare un discorso a più voci fondato sulla diversità, si punta così a restituire uno scorcio sulla realtà contemporanea, caratterizzata da una complessità che difficilmente si esaurisce nella voce di una singola individualità. Il risultato è una mostra concepita come un sistema dinamico”.
Le azioni, le strategie e i metodi messi in campo dalle opere si radicano in alcuni luoghi – spesso comuni – del pensiero, della cultura, del vivere sociale e dei canoni tradizionali legati alla creazione e alla percezione e a emergere è un potente valore di resistenza ai sistemi comunemente accettati. Viene a delinearsi così un mondo che non è esclusivamente politico o unicamente intimista, quanto un universo in cui l’importanza delle relazioni diventa cruciale, e in cui nessun aspetto esclude l’altro perché tutti i valori si costruiscono assieme.
Le opere in mostra alludono quindi alla possibilità di restituire questo complesso sistema di relazioni, includendo anche il ruolo dello spettatore chiamato a interagire in prima persona con esse. Il video di Shadi Harouni (The Lightest of Stones and the Heaviest of Men, 2015) vede impegnata l’artista in un’azione priva di utilità ma fortemente simbolica: la rimozione di singole pietre da una cava mentre un gruppo di uomini alle sue spalle commenta, mette in discussione la sua azione, e parla dei più svariati argomenti di attualità. L’operazione di scavare la pietra non comporta quindi un risultato pratico, ma diventa un mezzo per far emergere le connessioni sociali e politiche e i conflitti di una realtà locale con una più ampia comunità globale.
I DO di Jakob & Manila è un progetto che a sua volta innesca una riflessione sulla natura dei gesti, in questo caso però in relazione alle pratiche quotidiane. Il duo tedesco ha infatti messo a punto un lavoro in cui è il pubblico a dover svolgere delle azioni e a condividere la propria esperienza con gli artisti. I DO stimola infatti i fruitori a passare una intera giornata a propria scelta senza svolgere almeno una delle azioni indicate (come non usare dispositivi mobili, non usare cibo dal frigo, non parlare, non leggere) e di documentare le strategie creative conseguenti alla scelta: è in programma per sabato 21 maggio alle 16 un incontro tra gli artisti e i partecipanti al progetto per creare un confronto aperto sulle esperienze vissute.
Anche take out - 1 (turm des feuers) e take out - 3 (one men houses) - due disegni appartenenti a un ciclo di tre realizzati nel 2013 - di Ludovica Carbotta recuperano una riflessione sui gesti, ma la connettono alla natura originaria della forma e al potere dell’immaginazione: questo corpus di lavori traduce su carta delle architetture che l’artista non ha mai visto né dal vivo né in foto. A guidarla nella ricostruzione della Torre del Fuoco progettata dall’architetto del Bauhaus Johannes Itten è stato un testo che descriveva questo edificio simbolico dell’utopia del design modernista, mentre per take out - 3 a essere raccontata, in questo caso solo oralmente, è stata una scultura di Thomas Schutte dalla serie “One men houses”.
La nozione di ordinario e l’universalità del linguaggio vengono invece messi in discussione nei lavori di Kiyoto Koseki. Attraverso una performance (Arrangement with sign language interpreter, and public radio, 2016) e un’installazione (Two left halves: Cesca style chair, 2014) l’artista si sofferma sulla (im)possibilità di vivere un’esperienza e di parteciparla in maniera autonoma senza dover ricorrere a scambi o mediazioni. Due metà di una popolare sedia di design non consentono di ripristinare l’oggetto originario e di riattribuirgli lo scopo iniziale, mentre la traduzione gestuale di un contenuto nel linguaggio visibile dei non udenti risulta completamente inaccessibile ai più.
Un paesaggio intimo e personale che cerca di farsi strada nell’immaginario collettivo è invece nel video di Giovanni Giaretta (A thing among things, 2015), che racconta e ricostruisce l’universo della visione traducendo l’esperienza cognitiva e di memoria di una persona non vedente attraverso un’astrazione: le immagini generate da diverse conformazioni minerali. A questa prospettiva si aggiunge quella, opposta e contraria, di due opere di piccole dimensioni che restituiscono l’immagine di due specchi antichi che hanno completamente perso la loro funzione riflettente e la cui identità è quindi passata da quella di “generatori d’immagini” a immagini semplici.
Il grande lavoro a parete di Manuel Scano (Untitled (Acefalo magnifico), 2015) mostra invece l’opera come risultato processuale, alchemico e di relazione tra gli elementi che l’artista attiva ma che solo parzialmente vuole e può controllare, lasciando all’interazione tra le materie e al loro comportamento la responsabilità visiva della superficie. L’immagine che si genera in questo processo sfalda i confini della pittura astratta e figurativa arrivando quasi a incarnare le forme originate nel mondo biologico o siderale.
Lo studio dell’universo è anche il punto di partenza nel lavoro di Elisa Strinna, che presenta lo sviluppo di un nuovo e articolato progetto nato in Messico dove il macrocosmo naturale e il microcosmo umano s’incontrano. L’artista s’interroga sulla posizione dell’individuo contemporaneo nei confronti del sistema naturale a partire da una riflessione sull’architettura. Le sculture esposte, le cui forme sono derivate dalla tradizione post moderna, sono dei veri propri dispositivi da collocare all’esterno per studiare le luci dell’universo e degli strumenti per creare nel singolo un rapporto con il cosmo attivando quotidiani processi di “meraviglia”.