Arte e nichilismo. Intervista con Pietro Fortuna
Parola al protagonista della mostra ospite del Macro Testaccio di Roma, autore di una profonda riflessione sul senso dell’arte.

È una mostra composta interamente da opere realizzate ad hoc, quella di Pietro Fortuna (Padova, 1950) per il Macro Testaccio a Roma. Un affondo in tematiche che hanno attraversato da sempre il suo lavoro, con la convinzione che “l’arte sia profezia e non previsione”.
Il tuo pensiero sull’opera ha attraversato una fase importante di cambiamento dell’arte del nostro Paese. Queste riflessioni sono infatti partite già un decennio fa. Oggi torni al Macro con una mostra intitolata S.I.L.O.S. Cosa vuoi comunicare con questo nome?
S.I.L.O.S. è soltanto un titolo che ho scelto per questa mostra al Macro. In verità è un acronimo che sviluppato recita: “Senza Illusione Le Occasioni Svaniscono”. Devo premettere che i titoli nel mio lavoro non hanno la funzione canonica di annunciare lo sviluppo di una narrazione, ma sono assunti letteralmente, ossia come un valore che io conferisco all’opera, appunto: un titolo, un merito. Dunque le opere che ho realizzato per questa mostra meritano questo curioso acronimo che ci dice come le occasioni, che etimologicamente sono tutto ciò che cade dinnanzi a noi stabilendo un momento favorevole, siano soltanto una opzione tra le tante figure retoriche prese dal nostro sofisticato repertorio di immagini che presuppongono vere e proprie prescrizioni, regole che vanno osservate in quanto costituiscono le stesse ragioni del nostro pensiero.

Pietro Fortuna, Untitled, 2017. Courtesy of the artist
E se non volessimo seguirle?
Se volessimo tradire tale pensiero, ed è ciò che voglio, potremmo dire che l’incontro di questa sera [fra l’artista e l’intervistatore, N.d.R.] non ha nulla di occasionale, è semmai destinale. Non poteva che accadere così com’è accaduto, nella maniera in cui è accaduto. È la maniera a essere felice, favorevole. E la maniera non è forse l’espressione della tecnica? Quindi noi disponiamo in ogni momento della tecnica; ma attenzione, disporre non significa prendere in uso, come se la tecnica fosse da qualche parte a nostra disposizione, noi siamo tecnici, ogni organismo è tecnico, la natura è tecnica. Avresti mai pensato che incontrarsi in questo ristorante, disporsi intorno a un tavolo, parlare tra noi, ebbene, che tutto ciò che illusoriamente appare come un’occasione è invece il frutto di un uso felice delle nostre capacità tecniche?
E come ci comportiamo dunque a tuo parere?
Sarebbe interessante immaginare di disattivare per un istante i canoni su cui si è formato il nostro umanesimo, privarci del soccorso dell’illusione, della speranza, del valore per lasciar emergere le ragioni della natura. Certo di questa esperienza non potremmo nemmeno parlare, ma chi può smentire che il silenzio non sia altrettanto utile? Disattivando il pensiero muterebbe anche il nostro sguardo. Si dimentica che lo sguardo e il pensiero sono inseparabili, e quando non c’è nulla da vedere, ammesso quindi che si possa vedere il nulla, è il pensiero a deciderlo, il pensiero è l’architetto delle nostre visioni. E se un pensiero contempla in sé la propria fine, obbedendo al destino che si è dato (mi riferisco al pensiero dell’Occidente), le nostre visioni saranno fatte di macerie. E molti artisti non sanno di fabbricare macerie. La presa di distanza da ogni mediazione teorica che costringe l’arte a una bulimica produzione di immagini è soltanto la forma di questa fine, una fine orgogliosa di sé, una bella fine!
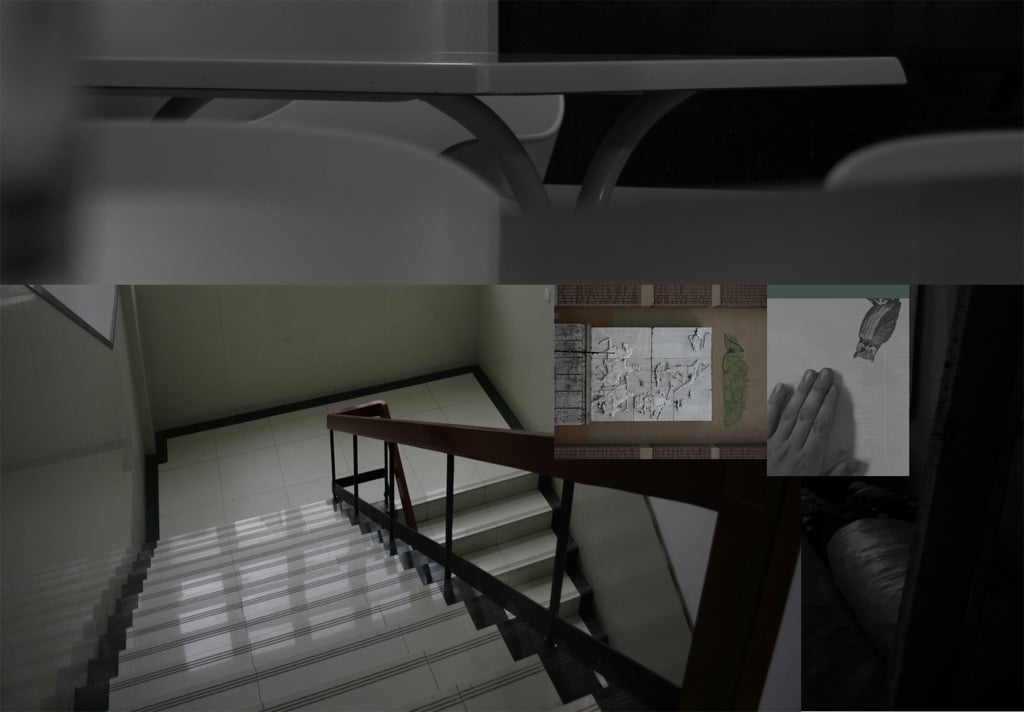
Pietro Fortuna, Untitled, 2017. Courtesy of the artist
Ma c’è una crisi del pensiero o c’è una crisi dell’arte?
Pur apparendo paradossale, direi che il successo del nichilismo, uno dei tanti modi per raccontare al presente la nostra forma di umanesimo, può essere misurato solo attraverso il suo indice di crisi: tanto è più prossimo alla fine e più soddisfa il suo stesso scopo. E mi pare che siamo già a buon punto! Quindi se l’arte è un pensiero che incontra un oggetto ma ritorna a essere un pensiero, in quanto l’opera, destinando il proprio fine oltre sé stessa, necessariamente trascende il suo essere oggetto, ne consegue che l’arte non può avere altra funzione se non quella di promettere, prevedere, annunciare il raggiungimento di uno scopo che, come dicevo, si attualizza in una fine. E l’arte, quando nel migliore dei casi aspira a un pensiero, non può che adottare quegli stessi canoni ereditati dal corso della metafisica e del pensiero giudaico-cristiano. Escluderei, allora, che qualcosa sia sorto come ostacolo o limite alle sue risorse, credo invece che stiamo soltanto assistendo all’agonia di un pensiero dogmatico e finalistico con cui si è costruito un umanesimo schiacciato sullo sfondo di un destino escatologico.
Vedi in altri mondi emergenti una forza vitale che da noi sembra essere appannata?
Purtroppo non vedo cosa possa accadere, da parte di altre culture, in grado di rigenerare un modello che come dicevo non è propriamente in crisi, ma contempla l’idea di una fine. Dopo un lento processo di dismissione delle culture originarie, il nostro modello è stato assunto probabilmente per come è riuscito ad affidare alla scienza quel carico di promesse e di fede per la sorte di un’umanità sempre più esposta alla propria fragilità. Praticamente gli abbiamo venduto una patacca! Né mi aspetto un qualche effetto virtuoso da quelle forme di meticciato che oggi caratterizzano il globalismo.
– Paolo Cuccia
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #37
Abbonati ad Artribune Magazine
Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune
 1 / 6
1 / 6
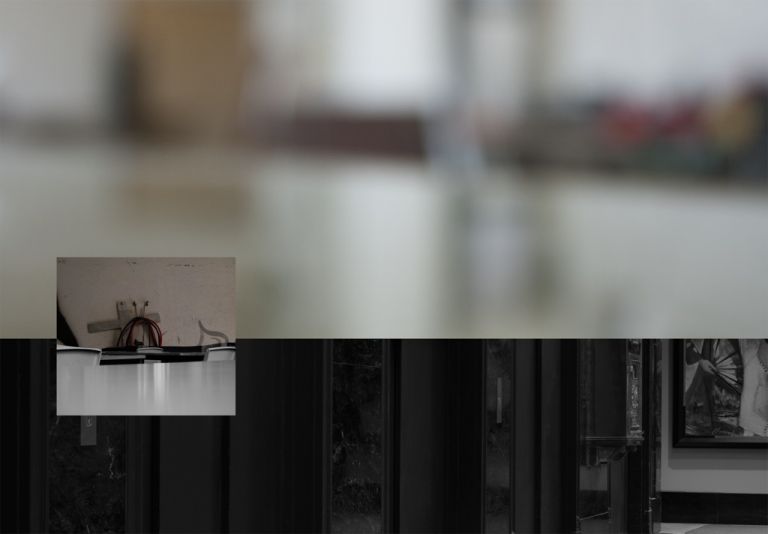 2 / 6
2 / 6
 3 / 6
3 / 6
 4 / 6
4 / 6
 5 / 6
5 / 6
 6 / 6
6 / 6
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati











