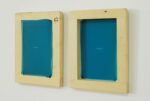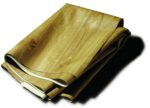Dialoghi di Estetica. Parola a Ermanno Cristini
Curatore, artista e docente, Ermanno Cristini riflette sulla sua pratica e ne descrive origini e obiettivi.

Attivo dagli Anni Settanta, Ermanno Cristini (Varese, 1951) lavora su più fronti. La sua ricerca artistica si dirama in direzioni diverse, nel segno della progettualità relazionale e della condivisione poetica. I temi del confronto e della negoziazione sono all’origine del suo lavoro. È coideatore dei progetti Roaming, L’ospite e l’intruso, Riss(e) –Zentrum, Dialogos, Prière de Toucher, Abitare un ritardo, Camminare l’orizzonte, Doppio Stallo, Walktable e Walkabout, Strabismi. Ha esposto tra l’altro a: Assab One, Milano; Cabaret Voltaire, Zurigo; Musée Cantonal Des Beaux-Arts, Losanna; Current Space, Milano; Ex Archivio Szeemann, Maggia; Forum Stadpark, Graz; Fondazione Fabbrica del Cioccolato, Blenio; MACT/CACT, Bellinzona; Mestna Galerija, Nova Gorica; MNAC Annexe, Bucharest; Musée Saint Denis, Parigi; Museo Riso, Palermo; Nowhere Gallery, Milano; Vitrina Deniska e Galerie Caesar, Olomouc; Triennale di Milano; 91 mq, Berlino; LATO, Prato; Kunsthalle West, Lana, Bolzano. Ripercorrendo alcune tappe fondamentali dell’attività di Cristini, il dialogo affronta diversi temi: il rapporto tra teoria e pratica, le dinamiche della progettazione relazionale, la riflessione sui ruoli di artista e curatore, l’indagine sulla prassi artistica.
Il tuo lavoro artistico è considerabile come una piattaforma in continua trasformazione. Di essa fanno certamente parte numerose opere – cose e materiali che hai elaborato nel corso del tempo – ma uno dei suoi nuclei principali credo sia, prima di tutto, l’intreccio tra teoria e pratica.
Il nesso del quale parli è stato decisivo fin dall’inizio perché mi ha permesso di sviluppare il mio lavoro artistico in tre direzioni con l’elaborazione di progetti, testi e oggetti. Ho sempre pensato che non vi sia un confine netto tra teoria e pratica. Sono due binari sui quali scorre la mia ricerca, il recto e il verso di una stessa medaglia. L’aspetto teorico era comunque una necessità per me già negli Anni Settanta. Allo stesso tempo, mi sono sempre dedicato alla pratica intesa come un fare che può generare nuove possibilità, anche con il minimo indispensabile. Il mio lavoro artistico si alimenta certamente di questi fattori, ma la sua trasformazione è avvenuta nel tempo – e devo dire, anche grazie agli studi che ho fatto prima e durante l’università.
Quali sono stati i principali riferimenti per la tua formazione?
Durante l’ultimo anno del liceo ho avuto due amori, due libri che considero ancora oggi fondamentali perché mi hanno aperto la mente e indirizzato nelle mie scelte: uno era Arte come mestiere di Bruno Munari e l’altro Opera aperta di Umberto Eco. Subito dopo la nomina come docente al liceo – in quegli anni era un percorso più lineare rispetto a oggi – mi affrettai a scrivere a Munari per chiedergli un incontro. Lui mi rispose positivamente e riuscii a invitarlo al Liceo Artistico dove insegnavo. Nacquero poi un’amicizia e una collaborazione durate a lungo che furono per me fondamentali. In quegli stessi anni Eco insegnava al Politecnico di Milano: la mia scelta di iscrivermi per seguire le sue lezioni fu immediata. Il Politecnico era un luogo vitale, c’era una grande apertura alla ricerca, una riflessione significativa sulle attività didattiche. Il mio interesse era comunque per l’arte e insieme ai corsi di Eco frequentai anche quelli di Corrado Levi, molto attivo nella ricerca al confine tra arte e architettura. Sviluppando i miei studi su temi legati a quell’area, mi laureai con una tesi sull’Architettura Radicale in rapporto alle pratiche artistiche degli Anni Settanta.

Ermanno Cristini. Salon Style. Exhibition view at Nowhere Gallery, Milano 2019
Dopo gli studi, come si è sviluppata la tua attività artistica?
Ho diviso il mio tempo lavorativo fra tre attività: la ricerca artistica, alcune consulenze pubblicitarie e l’insegnamento. Poi nel 2007 le cose sono cambiate. Ho deciso che i tempi erano maturi per occuparmi di una sola cosa e mi sono dedicato quasi esclusivamente all’arte. Per molti anni la mia ricerca si era concentrata su un tema in particolare: il rapporto tra realtà e finzione. La mia prima grossa mostra su questo argomento fu una personale al Centro Attività Visive di Palazzo dei Diamanti a Ferrara nel 1987. Certo, l’avevo fatto concentrandomi sul piano delle pratiche, senza trascurare comunque quello della riflessione teorica.
Quali sono le principali ragioni alla base del tuo modo di lavorare?
Da una parte, direi la volontà di proseguire il mio percorso su entrambi i fronti (teorico e pratico). Dall’altra, la scelta di ridare centralità alla produzione di pensiero critico esercitato in quanto artista.
Sulla base di questi presupposti, in seguito come si è sviluppato il tuo lavoro?
Innanzitutto, ho avviato il progetto Roaming che considero il generatore di tutti i progetti successivi. Il tema, investigato insieme al curatore e critico Alessandro Castiglioni, era quello del rapporto tra realtà e finzione a partire da una condizione oggi sempre più diffusa: spesso la circolazione delle opere è legata alla loro riproduzione in forma di immagini. Ma, data la pervasività del fenomeno, queste ultime sono da considerarsi parte costitutiva dell’opera oppure no? Roaming è nato da questa domanda.
Come era strutturato il progetto?
Il format prevedeva diverse fasi: individuare un sotto-tema per ogni sua tappa; sulla base di questo sotto-tema invitare gli artisti chiedendo loro di elaborare lavori pensati appositamente per lo spazio che avrebbe ospitato una tappa del progetto; quindi, costruire la mostra. Queste fasi erano determinate da due aspetti che hanno caratterizzato l’intero format. Da una parte, si trattava di lavorare in un tempo di preparazione molto lungo – proprio perché determinato dal tempo del pensiero, dal suo dispiegarsi secondo un ritmo proprio e dalla necessità di ancorare in profondità la mostra allo spazio ospitante. Dall’altra, l’obiettivo era quello di comprimere la mostra nel momento stesso della sua inaugurazione, confrontandosi con la dimensione dell’‘evento’ – prima di Roaming, negli Anni Novanta, avevo già fatto diverse esperienze di questo genere: mostre che vivevano solo come inaugurazione o addirittura solo come annuncio.
Sul piano operativo vi era poi un elemento importante: parte integrante della mostra era un fotografo; le sue immagini delle opere, concepite come testimonianza più che come documento, erano tutto quello che rimaneva della mostra, riallestita in questa forma su un sito internet dedicato.
Lavorare sulla relazione tra realtà e finzione ha significato anche sviluppare una indagine sulla natura dell’opera.
Certo. L’opera dell’artista invitato – nel momento in cui diventava l’immagine del fotografo, il quale era invitato a sua volta a forzare l’immagine del lavoro – permetteva di mettere in luce il problema: l’opera che cosa era? Quella dell’artista o l’immagine? Era quella del fotografo o era il processo che si innescava?
Credo infatti che l’opera debba intendersi come una sorta di processo di rotolamento continuo. Il suo farsi immagine è quindi elemento costitutivo del suo statuto attuale.

Ermanno Cristini, Parquet, 1988, linoleum, 35x50x20 cm. Photo Pietro Bianchi
Insieme all’intreccio tra teoria e pratica, per gli sviluppi del tuo lavoro sono altrettanto cruciali la possibilità di stabilire connessioni e istituire relazioni.
La forza di Roaming è stata di essere un progetto del tutto indipendente, autoprodotto e alimentato mediante le relazioni. In sei anni, dal 2008 al 2014, abbiamo fatto ventidue mostre in giro per l’Europa, metà in musei e l’altra metà in project spaces. Questo mi ha permesso di coltivare proprio i due aspetti che hai menzionato. Roaming è stato infatti anche un generatore di rapporti umani. Attraverso le mostre è stato possibile sperimentare qualcosa come una ‘logica del dialogo’: invitare artisti di nazionalità e generazioni diverse voleva dire gettare le basi per il confronto e l’incontro al fine di creare una sinergia basata sulla disponibilità a lavorare insieme.
Che ruolo ha il dialogo nel tuo lavoro artistico?
Un ruolo di primaria importanza. È sempre stato decisivo, tant’è vero che con l’andare del tempo ho deciso di metterlo sempre più al centro delle mie attività. Proprio da questa scelta nel 2009 è nato il format L’ospite e l’intruso, sviluppato poi di nuovo con Alessandro Castiglioni.
Soffermiamoci su questo progetto: qual era l’idea di base?
Tutto ruotava intorno all’esigenza di richiedere degli interventi in un ambiente che era sia spazio di lavoro sia spazio abitativo: la casa-studio dove abitavo in quel periodo. Ogni volta invitavamo due artisti. Un artista in qualità di ospite e un secondo artista in qualità di intruso, sconosciuto anche all’ospite fino al momento dell’inaugurazione. L’intervento di quest’ultimo era perturbante rispetto alla linea curatoriale tracciata a priori la quale si trovava così a essere imprevedibilmente ridisegnata nei fatti.
Come lavoravano gli artisti?
Ti faccio qualche esempio. Sergio Breviario e Roberto Pugina furono i primi due. Breviario aveva ricostruito nel mio studio una parte del suo studio, mentre Roberto aveva disperso, con una logica interstiziale, una serie di piccoli elementi negli spazi della mia parte abitativa. Umberto Cavenago ha realizzato un intervento intitolato L’orizzonte di Ermanno: con il laser aveva tracciato una linea su tutte le pareti, il riferimento della linea era l’altezza dei miei occhi. Tutti gli oggetti presenti nella stanza erano stati allineati senza però mettere chiodi nel muro. Abbiamo passato quattro giorni per riuscire a rispettare la linea con giochi di equilibrio e senza far cadere alcunché: poi per venticinque giorni il mio studio era così, diciamo tutto allineato, e questo alterava la mia abituale esperienza dello spazio. Gli interventi sono stati diversi, anche ‘invasivi’: Giovanni Morbin, per esempio, mi aveva sigillato il bagno; chiesi ospitalità per la doccia a tutta la mia mailing list e dal suo lavoro sulle abitudini corporee è nato anche un mio lavoro.

Ermanno Cristini, Prière de Toucher with out handle, 2014, tubo in acciaio inox con coperchio, 20x20x110. Photo Miriam Broggini
In entrambi i progetti risalta il tuo interesse per una messa in discussione non solo del ruolo dell’artista ma anche di quello del curatore.
I progetti mi hanno consentito di sviluppare una riflessione sull’autorialità, sul senso della relazione e dell’attività artistica e curatoriale. Su quest’ultimo fronte si è trattato di operare in modo da ripensare la struttura stessa di un evento espositivo; con L’ospite e l’intruso, più che di mostre, si trattava infatti di attività volte a ottenere interferenze in un ambiente domestico, il mio, che era una casa studio. Ma, allo stesso tempo, questo voleva dire rivedere continuamente anche il ruolo del curatore. Essendo una pratica, la curatela può infatti essere svolta da figure diverse, anche dagli artisti come ormai accade sempre più spesso.
Che cosa è emerso dal ripensamento della struttura dell’evento espositivo?
Il format L’ospite e l’intruso durò circa un anno e mezzo, sviluppandosi attraverso una decina di appuntamenti grazie al contributo di venti artisti. A quel punto ho sentito la necessità di passare a una dimensione più espositiva. Questo mi spinse a spostare il mio studio e così nacque Riss(e). Il primo evento fu una mostra sul vuoto: svuotare infatti è stato il primo atto che ho compiuto in questo spazio. Invitai Marion Baruch e Cesare Pietroiusti perché in passato avevano realizzato esperienze importanti sul vuoto. Da Riss(e), a distanza di qualche anno, è nato Zentrum, un sistema di quattro spazi espositivi tutti diretti da artisti.
Con questo sviluppo del tuo lavoro risaltano ancora di più i presupposti che lo animano: fare arte e investigarne l’essenza.
L’ospite e l’intruso, Riss(e), Zentrum sono una declinazione della pratica artistica intesa come negoziazione, forma dell’incontro. In altri progetti questa concezione è andata via via rifinendosi. Per esempio, attraverso Dialogos, un progetto che pone al centro la questione del confronto e quella della “inutilità” del fare artistico, ovvero di un fine che non può essere immediatamente prestazionale. Con Dialogos ho provato a lavorare direttamente sul fare arte come fine in sé. Il quesito guida era: e si ci mettessimo a lavorare senza sapere perché, entro quando, per quale spazio ma trovando invece un senso attraverso lo sviluppo stesso del lavoro? Ho invitato una decina di artisti di diverse età e nazionalità. Ho proposto loro un semilavorato, una struttura incompleta e suscettibile di possibili variazioni. Un sasso buttato nell’acqua, chi partecipava reagiva a sua volta con una propria azione, un proprio lavoro in nuce, e così via per un tempo indeterminato. È stato difficilissimo.
Perché?
La sfida stava nel riuscire ad allontanarsi dalle tradizionali idee di arte, mostra e pratica artistica. Nonostante gli artisti possano accettare un progetto del genere, il quesito sulla realizzazione della mostra e sulla concretizzazione delle opere c’è sempre. Ma l’idea che andava via via definendosi era: ‘sprechiamo’ il tempo per riappropriarcene, questo è il solo fine.
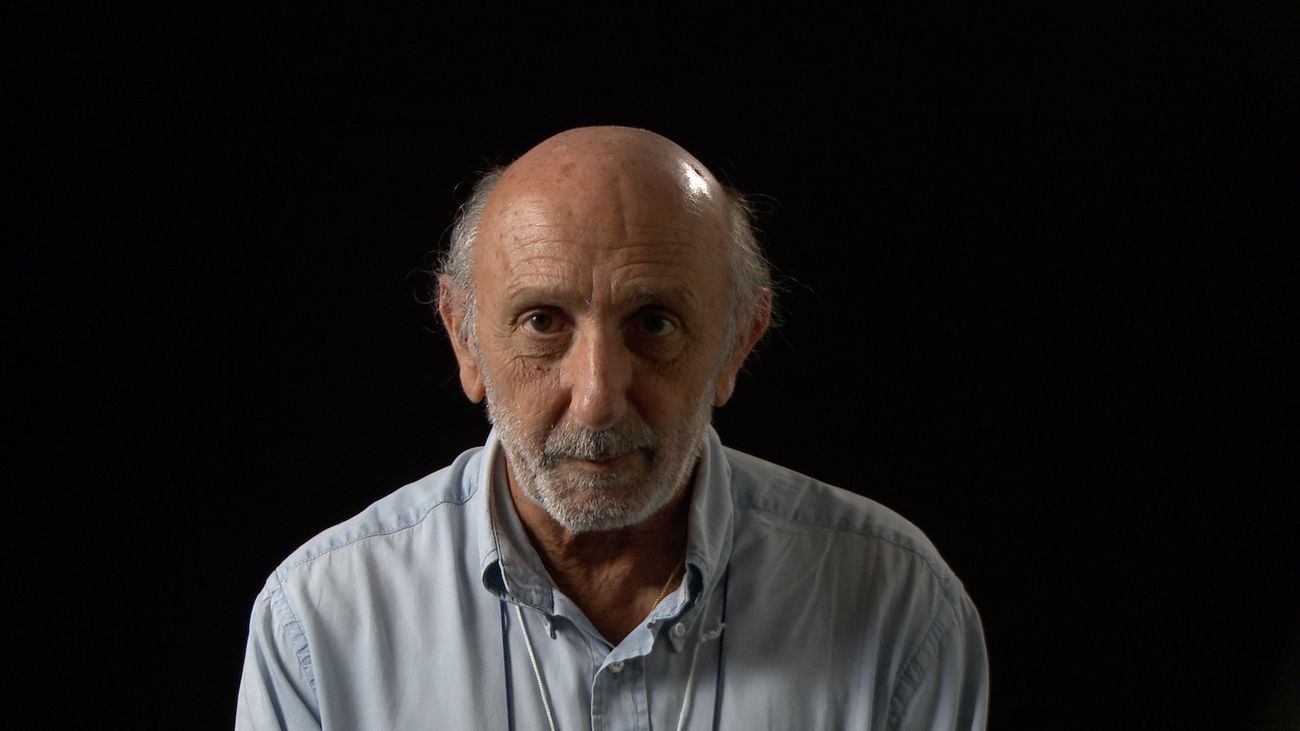
Ermanno Cristini. Photo L&L Videoforart
Quale esito hai conseguito attraverso questa indagine meta-artistica?
Direi soprattutto il tentativo di sancire in modo evidente e radicale la improduttività del fare artistico, il suo essere fuori tempo, il suo essere costantemente in ritardo. Dialogos è stata l’occasione per indagare questa dimensione, dall’interno, mentre facevamo. Tutto lo scambio avveniva su un documento condiviso di Google Drive; poi ci furono anche le mostre, esse non erano però il punto di arrivo, ma una parte del processo. Erano delle mostre non mostre: la messa in forma di un naufragio. La prima la proposi ad Elena Quarestani di Assab One dicendole che volevamo esporre dei semilavorati, ossia volevamo mettere insieme i relitti del nostro naufragio, mostrò tutto il suo stupore ma poi accolse la proposta con interesse e la ospitò.
Come consideri il tuo lavoro artistico?
Col passare del tempo, mi rendo conto sempre di più che il mio lavoro è un inciampare derivato dal fare. Per un momento, a occhi chiusi, inciampo in una cosa vista da sempre ma che, da quel momento, conosco in una forma diversa. Poi ci penso su. A quel punto scatta l’elaborazione teorica che probabilmente mi porta a inciampare di nuovo andando così in altre direzioni.
Consideriamo gli oggetti.
Sono legati naturalmente agli sviluppi del mio lavoro. Per esempio, una delle mie ultime mostre, Salon Style, nasce curiosamente da un camino di metallo con coperchio che avevo acquistato nel 2000, messo nel mio archivio e poi ritrovato solo quattro anni fa. Ha un fascino irresistibile, anche perché non si può più aprire… Ma la cosa più importante è che, quasi per concatenazione, mi ha permesso di attivare vari altri dispositivi.
Come si è sviluppata questa concatenazione tra oggetti?
Per una residenza a Berna nel 2016, incentrata sul tema dell’ozio, lo fotografai e poi ne ricalcai i contorni – seguendo l’idea che ricalcare è un gesto legato al fare arte, un gesto diversamente ozioso, se si vuole. Da questo disegno ne sono nati altri e, poiché in quel periodo avevo per le mani diverse cornici, ho iniziato a incorniciarli. La visita di un’amica che apprezzò quei disegni fu l’occasione per chiederle la prima cornice in regalo. Da lì iniziò il gioco: chiedere a conoscenti, amici e artisti una cornice. Ciascuno ha contribuito con quello che aveva e così ha preso forma prima il lavoro, poi le mostre. Cinquanta cornici, poi cento, e il lavoro prosegue… Mi piaceva l’idea di trovare nella monotonia del ricalco, nel ripetersi dei disegni, un pretesto per innescare l’incontro con gli altri. E questo voleva dire riconoscere le diversità: individuare ciò che non appartiene più alla ripetizione, ma alla individualità, alla relazione e ai cambiamenti.

Marion Baruch. Zero Pa. Riss(e), 2011
Come hanno contribuito le persone che hai coinvolto?
I contributi sono stati diversi: alcuni mi hanno donato cornici con storie personali significative, altri mi hanno detto: ‘non uso cornici’, ne hanno comprata una e me l’hanno data; qualche artista l’ha prodotta, così il suo contributo è diventato un’opera; la figlia di Harald Szeemann mi ha donato una cornice del fondo di suo padre, nella quale abbiamo trovato un piccolo rimando al suo archivio (un pezzetto di scotch con la sigla H. S. sul quale c’era, timbrato, un frammento del numero di telefono del suo studio di Maggia), un ricordo che resta. Oltre a fare delle mostre a parete mettendo insieme una quadreria in progress, ho potuto sviluppare qualcosa come un ‘tessuto di relazioni’, un muro di storie intrecciate.
In altri casi è proprio ciò che non si vede a essere centrale per la tua attività. Penso in particolare al progetto Prière de Toucher che hai sviluppato insieme a Giulia Brivio.
Da qualche anno sto lavorando a un ciclo di mostre incentrate sul nascondimento. Prière de Toucher è un ‘dispositivo’ nato dalla ricchezza del dialogo con Giulia, per sperimentare una dimensione che in arte è problematica: il nascondimento contrapposto all’esporre, al mostrare qualcosa agli occhi altrui. In un’epoca di sovraesposizione come l’attuale la questione assume un particolare rilievo.
Come è nata l’idea?
Da un bisogno di discrezione nel frastuono contemporaneo e da una visita al Museo de l’Art Brut di Losanna. Mi aveva colpito moltissimo il lavoro di Judith Scott: una stanza nella quale vi erano degli enormi ovuli, colorati e appariscenti, realizzati con un grande quantitativo di fili di lana. Mi incuriosì il fatto che l’opera non era la cosa visibile: l’autrice realizzava infatti dei piccoli assemblage con oggetti comuni, poi però la sua preoccupazione, a causa della sua malattia, era di nasconderli, avvolgendoli con chilometri di filo. Così, quello che si vedeva, ed era mostrato, non era quel che si sarebbe dovuto vedere.
Le tue attività rivelano una componente in particolare che le caratterizza: la consapevolezza delle possibilità e dei limiti. Un elemento che rimanda anche alla tecnica: che ruolo ha quest’ultima nel tuo lavoro?
La tecnica ha un ruolo importante come tutte le cose secondarie! È naturale che vi sia, ma è anche necessario tendere a superarla continuamente. Se non fosse così, si rischierebbe di arrivare ai tecnicismi.
Nel tuo lavoro potremmo considerarla come l’elemento che da una parte rende possibile la coltivazione delle relazioni e dall’altra il continuo innesco di connessioni.
Assolutamente. Per me si tratta principalmente di competenza pratica. Di fare e rifare, di progettare e stupirsi, di scoprire e ripartire con altre esplorazioni delle materie, delle persone. Il lavoro si trasforma attraverso la possibilità stessa di intessere relazioni. Credo che la tecnica sia importante soprattutto se diventa maestria, ovvero una sorta di “discrezione”, un trattenersi. Ma si tratta, come dici tu, di consapevolezza dei limiti e delle possibilità.
Coltivare le relazioni e rigenerare il senso con esse è possibile proprio perché il lavoro si sviluppa continuamente attraverso la prassi che tu intendi anche come improduttiva, nonostante essa sia comunque all’origine di nuove possibilità.
Per me questo vuol dire procedere attraverso ‘un fare in meno’, un fare sottraendosi. Si tratta di un fare che si amplia perché nasce e si sviluppa dal presupposto di sganciarsi dalla sua natura produttiva. Alla base c’è l’ulteriore consapevolezza della possibile inutilità del fare e della profonda utilità dell’inutile. È un fare che esiste in quanto fare, in quanto prassi che, seppure è in meno, è comunque in più.
E, Forse?
Prima di tutto, è un intercalare che popola il mio parlare, e dunque le mie riflessioni, da sempre. Poi è il titolo di una raccolta dei miei scritti pubblicati di recente. Ma non è solo questo. Ho sempre difeso strenuamente le mie posizioni. Spesso si è convinti di avere delle verità da difendere, tuttavia c’è sempre un ‘forse’ che a un certo punto si palesa. È parte integrante del pensare, del guardare il mondo; potremmo parlare di un atteggiamento di “certezza dubitativa”, dove i due termini si presuppongono a vicenda e si alimentano.
Una semplice parola che indica un’apertura.
Forse sì!
‒ Davide Dal Sasso
 1 / 13
1 / 13
 2 / 13
2 / 13
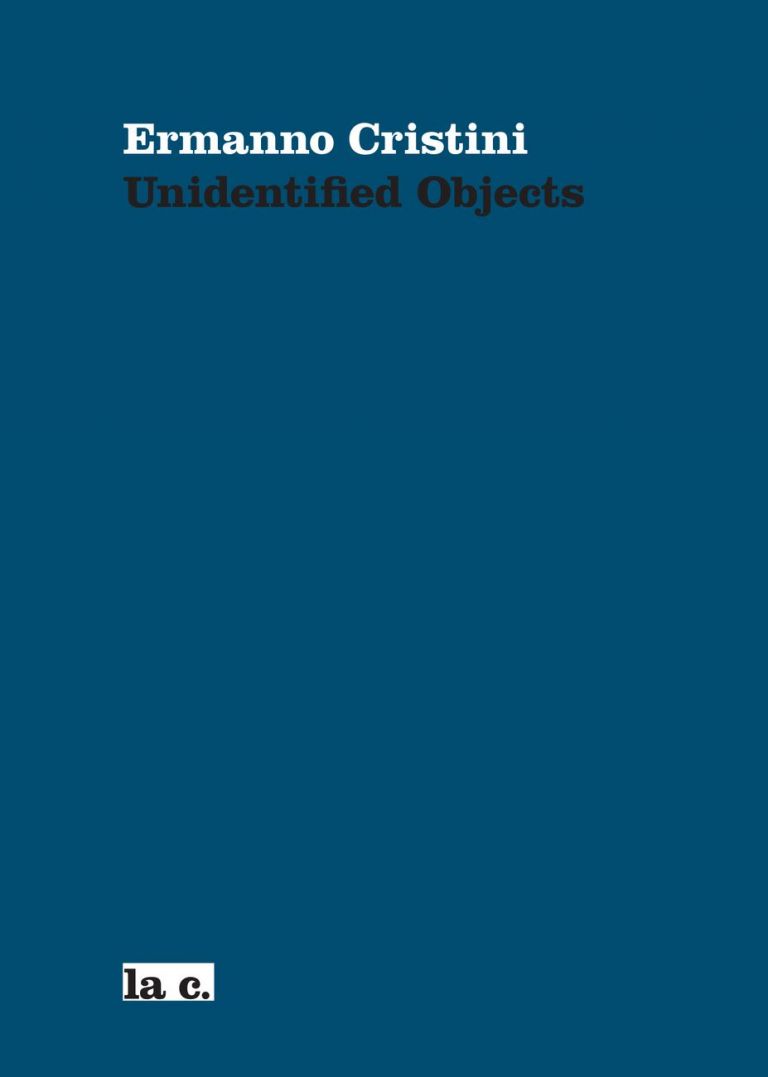 3 / 13
3 / 13
 4 / 13
4 / 13
 5 / 13
5 / 13
 6 / 13
6 / 13
 7 / 13
7 / 13
 8 / 13
8 / 13
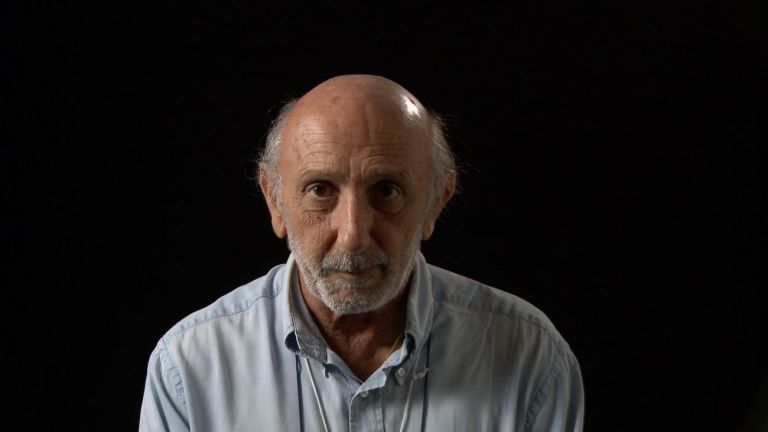 9 / 13
9 / 13
 10 / 13
10 / 13
 11 / 13
11 / 13
 12 / 13
12 / 13
 13 / 13
13 / 13
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati