Pittura come poesia e filosofia. Guccione, tra luce e mare. A un anno dalla morte
Tra verso poetico e pensiero filosofico, la pittura di Piero Guccione racconta l’esperienza della meditazione dinanzi all’infinito e alla natura. Dalla ricerca ossessiva del mistero luminoso alla consapevolezza, parallela, di una notte necessaria. A un anno dalla scomparsa, avvenuta in Sicilia il 6 ottobre 2018, una lettura critica del suo lavoro, insieme ad alcuni maestri del verso, del pensiero e del colore.

“La poesia ha questo compito sublime di prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci romba nell’anima e di placarlo, di trasfigurarlo nella suprema calma dell’arte, così come sfociano i fiumi nella vastità celeste del mare”. Ritrovare la pittura quieta di Piero Guccione (Scicli, 1935 – Modica, 2018), fra le linee e i timbri di certa poesia, è un esercizio semplice. Pittura piena di grazia, come un’elegia antica e pure contemporanea. Pittura lirica, con ogni evidenza, che nella parola poetica si specchia e si ritrova, essendo dolce di una dolcezza incompiuta, e severa, di una severità quasi dissolta, contraddetta.
SUBLIMAZIONI. MISURA E DISMISURA
Queste righe di Antonia Pozzi, per esempio. Elegante tessitrice di versi in punta di tormento e di tenerezza, morta suicida giovanissima, su un tappeto d’erba e di neve, nella sua Milano, il 3 dicembre 1938: cinque anni prima, in una lettera a Tullio Gadenz, Pozzi trasportava tutto quel dolore esistenziale nell’esperienza poetica, che definiva “sublime”. Sub limen, spinto fino al limite massimo, radicale e verticale, coniugato all’infinito, se perdere il senso della finitezza era forse come morire, oppure al contrario salvarsi. Senza alcun peso sollevarsi.
Una questione di soglie, di livelli penultimi, di tensioni tra il piano e il bordo, tra la forma aperta e il suo contenimento. La dismisura tradotta nella serena misura del verso. Per Antonia Pozzi quest’idea di suprema trasformazione trovava senso nella poesia, salvifico dispositivo di rigenerazione e di spostamento, dall’inquietudine tirando fuori qualcos’altro: e così imparare daccapo a vedere, più in là.
Sembra di riconoscerlo, Guccione, in quelle righe e in questo slancio. Ut pictura poësis. Lui, che in un’intervista recente aveva detto: “la pittura per me è proprio una commistione di meraviglia e di dolore. Certo, i miei temi non sono abitualmente dolorosi, ma, nell’intimo, io sento agitarsi percezioni di questa natura”. E sembra di vederli, il suo mare ed il suo cielo tenui, incollati e divisi da una riga incerta e dritta, con quella “vastità celeste” che era luogo di rifondazione: tempo, spazio, luce, i nomi e le cose, la bellezza e il dolore affioravano altrove. Trasfigurati. Riconsegnandosi nuovi agli occhi di chi, del quotidiano, aveva fatto materia aurea, degna d’alchimisti, di poeti e di profeti. E di pittori.

Caspar David Friedrich, Luna nascente sul mare, 1822, 55 x 71, Nationalgalerie, Berlino
TRA L’ONDA E LA BRUMA. LA LEZIONE ROMANTICA DI FRIEDRICH
Tutto allora era nel mare, contiguo al cielo, e nello scivolare reciproco attraverso mille timbri luminosi. Tutto il tormento e lo splendore dell’esistenza erano, definitivamente, sinteticamente, mare. Crepuscolo, alba, tramonto, aurora: passaggi immortalati su tela, fuor di metafora e in seno al paesaggio, con le sue temperature.
E quella “suprema calma” evocata da Pozzi, che era in lui perpetua declinazione di azzurri organizzati in superficie, del sublime restituiva proprio la voce romantica, appresa presto – già negli anni ’70 – da un gigante come Friedrich, cantore dello stupore e della solitudine umana dinanzi alla spregiudicata monumentalità della natura. Nel 1984 l’artista siciliano esponeva una serie di tele alla Galleria Bergamini di Milano, per la mostra “Guccione, Viaggio intorno a Caspar David Friederich”, a cura di Giovanni Carandente.
Scriveva il critico: “Caspar David Friedrich – lo si è riconosciuto assai più tardi malgrado il tempestivo apprezzamento di Goethe – rappresenta nel miglior modo la visione soggettiva, panteistica e a un tempo melanconica, della natura e dell’uomo nella natura, che fu propria dei Romantici (…). Friedrich, ad esempio, è il pittore che, nel celebre quartetto di Hannover, dipinse il trascorrere del giorno, dall’alba alla sera, ed è significativo che la luce in tre di quei dipinti sia brumosa, persino all’ora del mezzogiorno, quando un pallido sole bagna la pianura e la fa trascolorare: è soltanto ne ‘La sera’ che il sole calante di là dall’invisibile orizzonte si accende come una striscia di fuoco ai piedi della folta e scura quinta dei pini. Ebbene, Guccione è in sintonia con questo tipo di mutazioni luminose assai più di quanto non si creda, lo era già molto prima di accostarsi al Friedrich”.
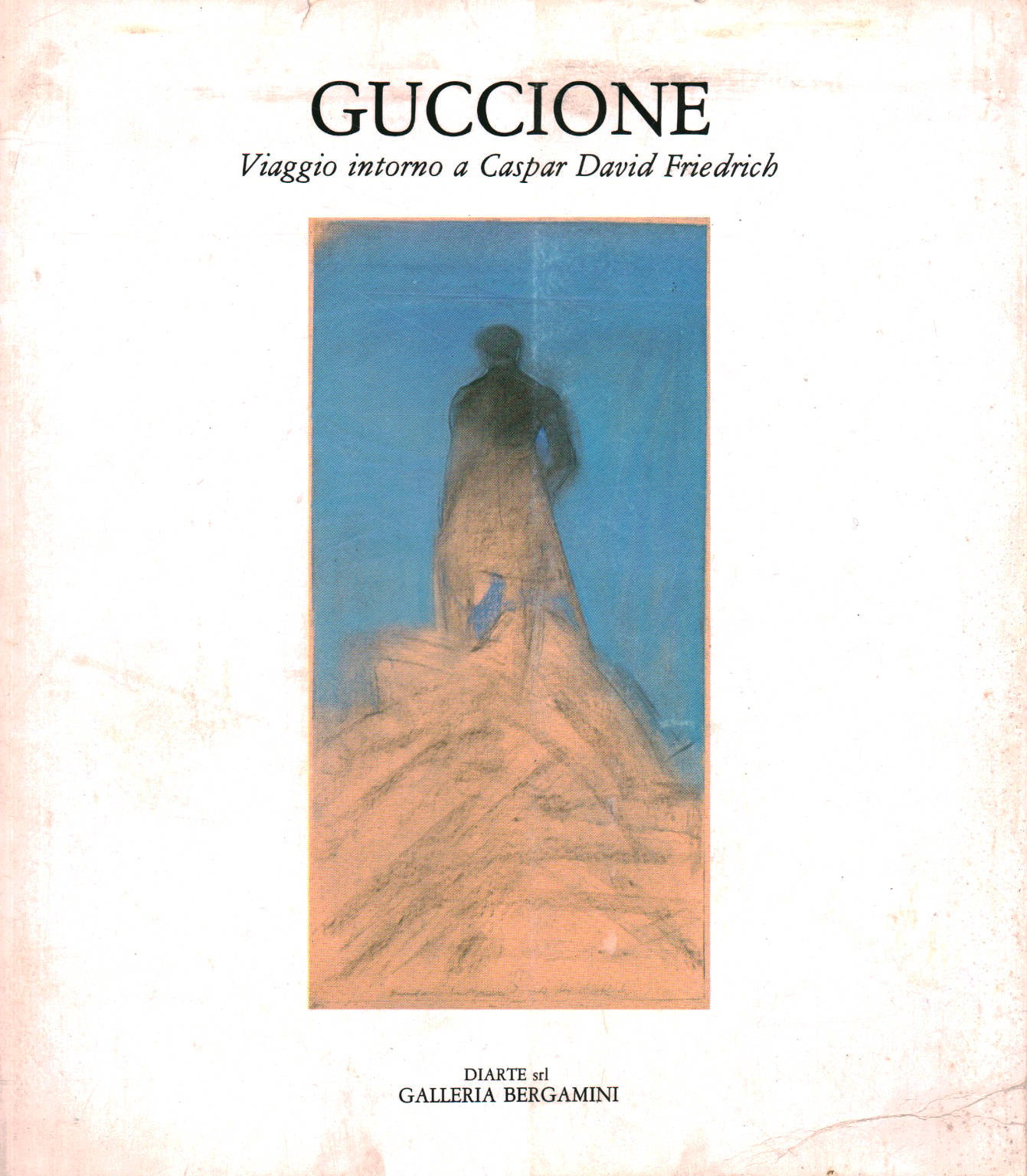
Piero Guccione, il catalogo della mostra su Friedrich alla Galleria Bergamini di Milano, 1984
Un romanticismo di apparizioni vespertine, pulviscolari, nebbiose, in cui il paesaggio è materia indistinta di riflessi e di cromie soffuse, di toni morbidi e contorni diradati, nella visione che si realizza solo poiché l’invisibilità ne è precondizione. E non si tratta dell’avventura retinica impressionista, ma di una traslazione più spirituale che ottica, più esistenziale che percettiva. È la furia delle cose, del sacro e della natura, tradotta in epifania pittorica, in elegiaca carezza, potente non solo e non più come la tempesta, ma come una meditazione turchina.
Quella stessa furia che per Antonia Pozzi somigliava al “dolore che ci spumeggia e ci romba nell’anima” e che in Friedrich conservava l’eco di Kant e di Turner, a proposito d’infinito, d’incommensurabilità matematica, di schianti d’onde sulla prua e di dissoluzione luminosa. E che poi diventava silenzio, contemplazione vasta.
Ed è singolare come tra due contesti culturali e geografici così lontani – dal profondo Nord Europa all’estremo Sud, ai confini con l’Africa – questa sintonia tra i due autori si sia consumata e rafforzata: se Friedrich amava” la luce fredda del settentrione, le brume, le distese innevate e solitarie, gli alberi spogli e nodosi e quella natura immersa nei vapori boreali rispose con il mistero soffuso della sua pittura”, Guccione omaggiò il suo sguardo, dal tepore della sua Sicilia, non già per mera citazione, ma riconoscendovi la possibilità di staccare la pittura dalla cronaca del reale e di farne occasione di invenzione, di trasposizione poetica, di visione del mondo e incantesimo vivo.

Piero Guccione, Piccola spiaggia, 2001, pastello cm 17×24
COME SOGNI DIPINTI
Scriveva ancora Carandente a proposito di Guccione: “i suoi Giardini dal 1963 al 1965 hanno quella luce mentale, irrealistica se si pensi alla visione mediterranea pura e semplice, ma palpabilmente riferita al peso e al volume dell’immagine prescelta, fosse soltanto quella di una nuvolaglia spessa, soffice e questa volta biancastra”. C’è una vena metafisica, davvero, nella pittura di Piero Guccione. Boschi, giardini, marine, restano sospesi, scolpiti sul bordo tra il concetto e l’emozione: nebbiose o assolate, sempre sul punto di apparire o scomparire, le sue finestre sul paesaggio sono dispositivi mentali, mai unicamente ottici, né realistici o narrativi. Qualcosa accadeva, tra la miracolosa esperienza dell’occhio e la sua elaborazione interiore. Questo qualcosa era simile alla poesia. Una sintesi autentica, talmente pura da ferire.
“Il mio pensiero sull’idea di dipingere il mare”, raccontò il pittore, “nasce dalla mia memoria di bambino. Col carretto arrivavo da Scicli e improvvisamente, terminata una breve salita, lungo la discesa si vedeva il mare. Era un’apparizione meravigliosa. Il senso di profondità, la distanza, la luce, davano al mare un movimento dolcissimo. Quella visione rappresentava, per me bambino, un paradiso. Quando, sul finire degli anni Sessanta, quel mare ho cominciato a dipingerlo, era come se nessuno mai l’avesse dipinto prima. La nostra tradizione ci portava a fare della pittura gestuale, e così penso che i primi quadri siciliani siano più idee che paesaggi. Non si tratta di uno sprofondamento dentro le cose, ma di sogni dipinti, come dice Merleau-Ponty. Avrei voluto che in quei piccoli quadri si avvertisse di più lo scontro con le cose”. Illuminante il richiamo a Maurice Merleau-Ponty. E non era dunque un calarsi dentro, nell’impeto espressionista, ma un toccare, sfiorare, producendo una frizione. Siamo sul piano assoluto dell’immagine, che confina col mondo delle cose e che con queste collide, contestandole e dunque partorendole daccapo. Uno scontro generativo, una specie di miraggio nel cuore del reale, e viceversa. Pittura come filosofia.

Piero Guccione
RITROVANDO RENOIR. L’OSSESSIONE LUMINOSA
E intanto scorrono le tele di Guccione, lungo mezzo secolo di carriera, nell’ossessione pacata della reiterazione, restando su alcuni soggetti ad infinitum, senza timore di esaurire la spinta. Morandiano, in questo. Dipingere il mare calmo, tutta la vita, come dipingere bottiglie. E provare a contenervi quella grandezza assurda, di meraviglia e di dolore, di dubbio e di tempesta, di fragilità e di ardore. Come fare a trasporre tutto questo in uno scampolo di mare? E come fare a ritrovarvi una risposta, una qualche compiutezza? La scommessa è inesauribile, quanto il desiderio.
È il bisogno continuo, diceva – come molti artisti hanno detto – di “appropriarsi” del soggetto. Un furto, un amplesso, una presa, una verifica, un esercizio disperatamente diligente. Una salvezza. E quando morì, il 6 ottobre del 2018, Guccione era ancora alle prese con quest’enigma. Giorgio Agamben, nei giorni del lutto, scrisse a proposito dei suoi ultimi lavori visti in studio: “Rimasi senza parole, quasi senza respiro. Non erano quadri quelli che avevo davanti agli occhi, non erano tele su cui la mano aveva dipinto: le tele erano perfettamente diafane, erano pura luce. Certo le marine di Piero ci avevano abituato a questo estenuarsi delle forme e dei colori: ma ora, in queste opere estreme, non cercava più di dipingere ciò che la luce gli permetteva di vedere, cercava di dipingere la luce stessa, cercava di dipingere l’impossibile. Per questo mi disse quel giorno: ‘aspetto il miracolo, il miracolo che mi permetta di finire questi quadri’“. Estenuarsi, estenuando la pittura, ma nelle serenità del lavoro e della meditazione.
Il racconto di Agamben richiama prepotentemente la figura di Auguste Renoir, a cui Guccione non era legato per via dell’attitudine impressionista, ma di cui avrà certo ammirato il fervore per lo studio del fenomeno luminoso: negli ultimi anni di vita, piegato da una violenta artrite deformante, il maestro francese dipingeva ancora, aiutato dalla famiglia a raggiungere il cavalletto, nel punto del suo studio in cui la luce della Provenza penetrava copiosa. Per decenni aveva inseguito la potenza del sole e il mistero dell’immagine, un incantesimo consumato tra la meccanica dell’occhio e la sostanza ineffabile del reale. Leggenda vuole che il 3 dicembre del 1919, costretto a letto da una polmonite, terminò di disegnare dei fiori, e riponendo i pastelli, disse: “Penso di iniziare a capirci qualcosa”. Subito dopo si spense, all’età di 78 anni.

Piero Guccione, Grande spiaggia, 1996 2001, olio su tela, cm 151 x 91,5, collezione privata
CANTI NOTTURNI, DALL’IMMAGINE AL VERSO
“M’illumino d’immenso”, avrebbe potuto scrivere in calce alle sue marine Guccione, rubando la magnifica brevità di quei versi, con cui Ungaretti folgorò la letteratura del ‘900. La qualità sensibile e spirituale è la stessa che unisce certi pittori. Pittori-poeti, che nella luce consumano la propria volontà di perdurare e insieme decodificare l’incanto – per la natura e per le cose – strutturandone l’informe mistero nel ritaglio di una tela: le marine di Guccione sono avvicinamenti progressivi e radicali, frammenti aperti, senza figure umane né contesti, sono piani e linee che trasbordano dall’inquadratura e che si danno come materia pura. Luce, pigmento, nebbia, atmosfera, lirismo e smarrimento. Eppure l’immagine è lì. Perentoria, celeste, cangiante. Squagliata da mille vibrazioni. Non conclusa ma presente.
Luce che trova anche nel buio la sua ragione. L’ombra, la notte, il vespro, la morte, l’assenza, l’interruzione: fondamento oscuro di ciò che è visibile, vitale. Guccione aveva dedicato un ciclo di paesaggi all’”Elogio dell’ombra” di Borges; e brillano, dell’immenso poeta lucidamente visionario, alcuni versi di quella lirica che ispirò i rettangoli di mare nero o azzurro del pittore, le insenature sabbiose e i cieli rosa, i giardini sensuali e gli orizzonti pastello: “Vivo tra forme luminose e vaghe / che ancora non son tenebra”, scriveva il poeta argentino, accennando alla sua cecità progressiva e tirandone fuori brandelli di memoria e d’immaginazione. Il buio, ancora una volta, è luogo di pensiero, di genesi, di visione, di “sogni e immagini del dormiveglia”. Come la vecchiaia, vestibolo della morte, che “può essere per noi il tempo più felice. È morto l’animale o quasi è morto”. E così conclude Borges, ammutolendo audacemente ogni mestizia con il tema della rivelazione: “Presto saprò chi sono”.

Piero Guccione, Albero del siparietto, 1989, collezione Iannaccone
È lo stesso Carandente a citare un’altra nota al margine della serie su Friedrich, conclusa con dei tramonti e poi con un’immagine notturna: “Una notte stellata che ho guardato a lungo da questo osservatorio“, scrisse l’artista, riferendosi alla sua Sicilia come prospettiva d’eccellenza. L’explicit finale, in quella raccolta, Guccione lo affidava a Giacomo Leopardi e all’attacco sublime del “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie” (1824), una delle “Operette morali”: “Sola nel mondo eterna, a cui si volve / ogni creata cosa, / in te, morte, si posa / nostra ignuda natura”. Fatalmente simmetriche, vita e morte configgono ma non si separano. La seconda, però, è l’unica che può vantarsi eterna e certa. Nessuna beatitudine è concessa, avverte il poeta: né ai mortali, né ai morti.
Ed è allora qui, nella trasfigurazione in versi o in pittura, che tutto si tiene, si riscatta, trovando una sua forma alta con cui sfidare il trascorrere del tempo. Il dolore, il mistero, l’irruenza dello spirito, la seduzione e la vastità della natura: tutto si fa scrittura di luce e di parola, di segni e di sintassi, di larghe campiture e di versi in equilibrio, su tela, sul foglio. Al margine della notte e al di là della storia.
– Helga Marsala
 1 / 11
1 / 11
 2 / 11
2 / 11
 3 / 11
3 / 11
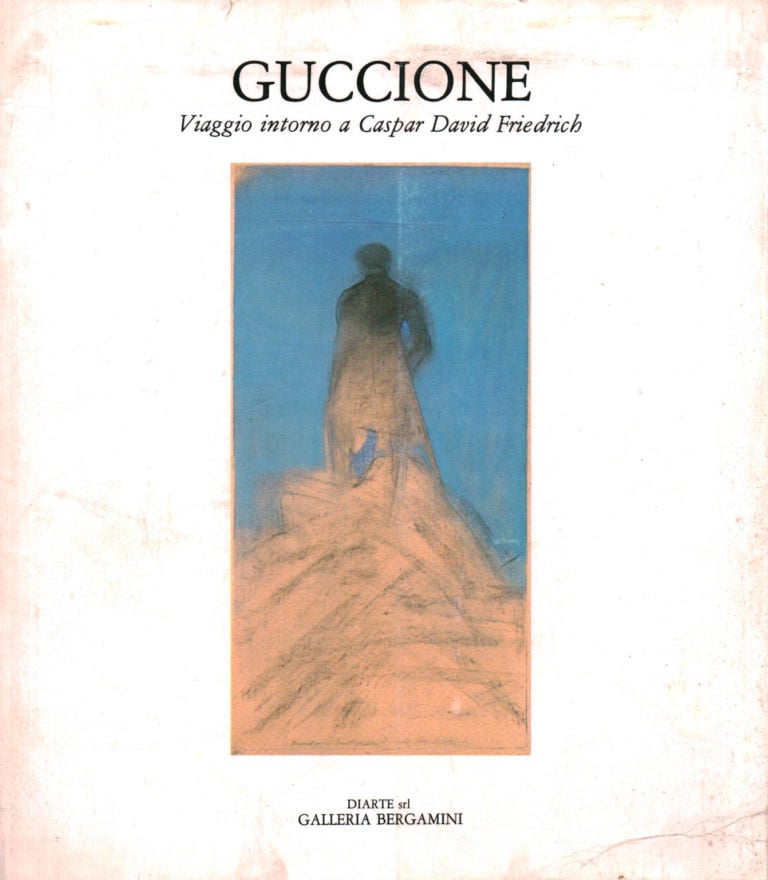 4 / 11
4 / 11
 5 / 11
5 / 11
 6 / 11
6 / 11
 7 / 11
7 / 11
 8 / 11
8 / 11
 9 / 11
9 / 11
 10 / 11
10 / 11
 11 / 11
11 / 11
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati
















