Dialoghi di Estetica. Parola a Cosimo Veneziano
Arte e comprensione della realtà quotidiana si intrecciano nella pratica di Cosimo Veneziano, che si racconta in questa intervista.
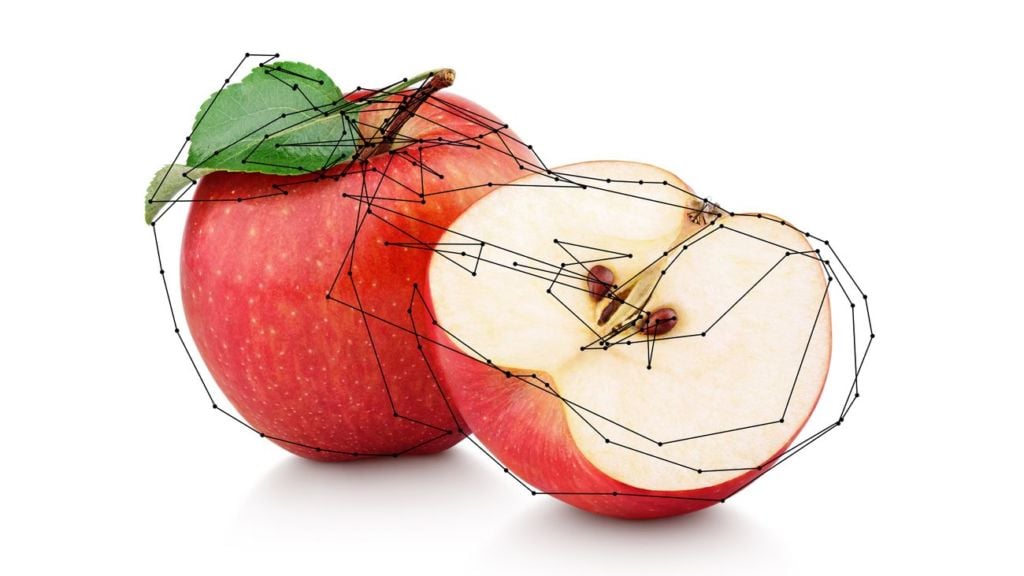
Cosimo Veneziano (Moncalieri, 1983) sviluppa la sua ricerca artistica spaziando dalla scultura agli interventi urbani, dal disegno alle pratiche relazionali e partecipative. Co-fondatore della residenza Internazionale Progetto Diogene, nata nel 2007, ha esposto le sue opere in numerose mostre personali: Rompi la finestra e ruba i frammenti!, AlbumArte, Roma, 2018; Petrolio, MEF ‒Museo Ettore Fico, Torino, 2016; Monochrome, Villa Straüli, Winterthur, 2015; Verso occidente l’impero dirige il suo corso, Galleria Alberto Peola, Torino, 2014; Los contrabandistas copiaron una escultura de mucho valor, Lugar a Dudas, Cali (Colombia), 2013. Motivato dall’idea che l’arte possa essere anche uno strumento di comprensione della realtà quotidiana, Veneziano è attualmente impegnato nel progetto multidisciplinare Biomega che mira a investigare i nessi tra arte, natura, antropologia e neuroscienze. Nel dialogo ci siamo soffermati sul ruolo delle immagini e della tecnica nella sua ricerca, sulla variabilità e l’alchimia in direzione di un’arte del puro pensiero progettante.
Credo sia anche tu d’accordo a riconoscere che una costante delle tue attività artistiche è la produzione di immagini.
Raramente riesco a fare a meno di una immagine. Resta però che sono in difetto con la loro presenza, soprattutto per quanto riguarda il lavoro da cui nascono. Le immagini ci sono, ma con esse c’è sempre anche un rapporto contrastante.

Cosimo Veneziano, Biomega Multiverso, 2019. Installation view at Fondazione La Raia, Novi Ligure. Photo credit © Matilde Martino
Da dove nasce questa tensione?
Dal mio legame con il disegno. È un mezzo che uso da molto tempo e che è presente nelle mie opere. Però, è un mezzo con il quale mi alleo solo dopo un certo periodo di sperimentazione. Finché non ne capto immediatamente le effettive possibilità, soprattutto dal punto di vista del suo eventuale riutilizzo in più progetti. Spesso lo sento il meno opportuno tra altri possibili mezzi espressivi. Nonostante questo, continuo a lavorare con il disegno.
Si tratta di un problema che affronti indagando in particolare il ruolo della tecnica.
Esattamente. E da questa riflessione arrivo spesso a riconoscere che la tecnica è tutt’altro che una scelta felice. È necessaria ma allo stesso tempo rivela inevitabilmente anche la sua insufficienza.
Riflettere sulla tecnica vuol dire affrontare anche i limiti operativi che incontri.
È così: quando penso ai limiti penso a un problema che immediatamente credo sia tecnico. Me ne accorgo soprattutto quando riconosco l’impossibilità di reiterare una stessa tecnica per progetti diversi.
Qual è la ragione di questa impossibilità?
Per me è importante riuscire a dare forma a una idea. Spesso però quest’ultima non favorisce la tecnica. È come se tra le due venisse meno qualsivoglia relazione. Il lavoro va comunque avanti. Ma, allo stesso tempo, si presentano con chiarezza anche i suoi potenziali tratti fallimentari.

Cosimo Veneziano, Il pallido contorno del sole, 2014
Pensi che questo approccio sia anche all’origine della variabilità che caratterizza la tua pratica?
Non ho mai coltivato un solo modo di fare arte. E questo è dovuto a una ‘struttura piramidale’ all’origine del mio lavoro. Prima di tutto c’è un impulso, qualcosa che vorrei fare, che trova una sua forma attraverso un progetto. Quest’ultimo, l’idea organizzata in modo da arrivare all’opera, può poi diventare un manufatto, può prendere forma in modi diversi: con un oggetto, un’azione, un workshop o altro ancora. Quando si interrompe la relazione tra idea e tecnica, si apre perciò la via della variabilità.
Questa impostazione operativa caratterizza il tuo recente progetto Biomega, considerabile come una sintesi della tua poetica, nel quale risalta anche una oscillazione tra progetto e tecnica.
Sono d’accordo con te, è una sintesi. E credo che lo sia proprio perché rende manifesti gli sviluppi del mio approccio basato sulla progettazione e l’indecisione rispetto alla tecnica. La stesura del progetto per me è fondamentale: lo considero come il grado zero dell’opera. Ma proprio da questo nasce poi la riflessione sulla tecnica che, alla fine, è legata a un problema in particolare: come affrontare l’ignoto. Farlo vuol dire scegliere quali strumenti usare e come servirsene. E, in questo, l’alchimia diventa decisiva.

Cosimo Veneziano, Membrana, 2017. Installation view at Galleria Alberto Peola, Torino
Però nel tuo lavoro l’alchimia sembra essere legata anche alla variabilità.
Prendi Quarto fuoco: è un’opera nata seguendo il filo della casualità. Mi interessava realizzare un cannocchiale. Sapevo che avrei offerto un punto di vista. Avrei voluto anche ottenere una ulteriore frammentazione dell’opera, ma alla fine questa parte del lavoro non è stata compiuta. Allora è stato importante riuscire a trovare un punto di incontro tra l’ipotesi – come avrei potuto comporlo e disporlo – e l’atto vero e proprio di installarlo fisicamente in sala. Ho tentato, ho visto come andava. È alchimia.
E, forse, è anche una questione di presenze, di scegliere come disporre le cose.
Negli ultimi tempi sto riflettendo sulla possibilità di andare sempre più verso la purezza delle relazioni, verso le sole riflessioni sul lavoro.
La tua meta è un’arte che sia espressione del puro pensiero?
Torno costantemente alla centralità del progetto e più volte mi chiedo se non si possa identificare l’opera direttamente con esso.
‒ Davide Dal Sasso
 1 / 11
1 / 11
 2 / 11
2 / 11
 3 / 11
3 / 11
 4 / 11
4 / 11
 5 / 11
5 / 11
 6 / 11
6 / 11
 7 / 11
7 / 11
 8 / 11
8 / 11
 9 / 11
9 / 11
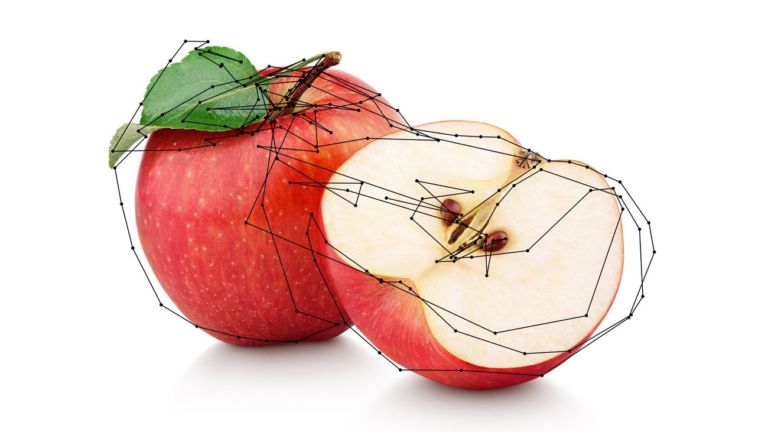 10 / 11
10 / 11
 11 / 11
11 / 11
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati














