Dialoghi di Estetica. Parola a Lia Cecchin
La pratica basata sull’osservazione della realtà, l’interesse per un equilibrio tra dimensioni soggettiva e oggettiva, l’attenzione per la quotidianità, il linguaggio e le relazioni umane sono solo alcuni dei temi affrontati in questo dialogo con Lia Cecchin.

Dopo la laurea in Arti Visive e dello Spettacolo presso l’Università IUAV di Venezia, Lia Cecchin (Feltre, 1987; vive a Torino) ha partecipato a diversi programmi di residenza e workshop tenuti presso: Fondazione Spinola Banna (Poirino), Fondazione Bevilacqua La Masa (Venezia), Halle 14 (Lipsia), Progetto Diogene (Torino), Lastation (Gagliano del Capo) e (a cura de La Quadriennale di Roma) Museo Madre (Napoli). Le sue opere sono state esposte in istituzioni, gallerie e spazi non profit italiani e stranieri tra i quali: AKV (‘s-Hertogenbosch); Fondazione Bevilacqua La Masa (Venezia); GAM (Milano); Associazione Barriera (Torino); Fabbrica del Vapore (Milano); CLOG (Torino); Fanta Spazio (Milano); PAV Parco Arte Vivente (Torino); Greylight Projects (Bruxelles); MAMbo (Bologna); Museo Giovanni Fattori (Livorno); A plus A Gallery (Venezia).
A Genova, il 24 settembre 2020, ha inaugurato l’opera di arte pubblica intitolata Una città cancella, l’altra scrive, progetto curato da Luca Cerizza, installata presso il Parco di Villa Croce.
Ad alimentare la tua attività artistica mi sembra sia anzitutto una sorta di indagine sulla realtà.
L’esplorazione di ciò che mi circonda è sempre alla base del mio lavoro. È un passaggio imprescindibile per individuare quelle che – con un po’ di superbia – definirei delle ‘esigenze’ collettive e che – consapevole del rischio di incorrere negli abbagli – affronto cercando di rimanere il più imparziale possibile a qualsiasi forma di interferenza soggettiva o affettiva.
Le tue opere mostrano anche come la tua pratica di osservazione si traduca spesso nel tentativo di avvicinarti il più possibile ai materiali, agli oggetti per quel che sono, a quello che già c’è nel nostro mondo.
Ci sono due discorsi da fare in merito a questa tua riflessione. Il primo riguarda le finalità. Ciò che mi interessa dell’utilizzo di materiali preesistenti è la loro immediatezza. Usare un linguaggio che non lascia spazio all’interpretazione è ciò che mi permette anche di mettere lo spettatore a suo agio; ponendolo di fronte a degli oggetti per quello che sono, per come li conosce, riesco a mantenere un rapporto più diretto e saldo con quello che è il vero focus del mio lavoro: la realtà e le complessità che la caratterizzano. Gli oggetti sono solo un mezzo.
E il secondo?
È un discorso più ideologico. Una delle ragioni per cui prediligo l’uso degli oggetti a delle riproduzioni degli stessi (o a forme più fantasiose di rappresentazione) è legata alla costruzione di un pensiero sostenibile. Viviamo in un’epoca che ha visto la sovrapproduzione spingersi all’esasperazione. Da qualche tempo, qualcosa ha cominciato a cambiare. Ma, se settori a noi vicini come quelli di design, moda e architettura hanno ormai assimilato modelli fondati sul concetto di sviluppo sostenibile, nelle arti visive questo è un processo che – mi pare – fatichi di più ad attecchire. Comunque, il mio punto di vista alla fine è molto semplice: così come se devo comprare una lampada guardo su subito.it e per un libro su comprovendolibri.it, quando penso a dei nuovi progetti penso sempre prima a quello che esiste già. Se creo vuol proprio dire che non ho alternativa. Sarà anche che di vedere il mio lavoro legittimato come opera d’arte mi interessa poco.

Lia Cecchin
L’ARTE DI LIA CECCHIN
Che rapporto hai con ciò che osservi?
Mi lascio guidare da un approccio ‘sociologico’: mi piace vedere quali sono le cose che in un certo momento influiscono in maniera particolare sulla vita delle persone. Qualche anno fa c’è stato il boom delle magliette con le scritte sopra. Camminando per la strada mi capitava di leggere addosso a ragazzini, signore e miei coetanei scritte che comunicavano dei messaggi. Ne sono rimasta affascinata proprio perché riconoscevo fosse un fenomeno diffuso. Spesso l’operazione che mi capita di compiere è solo quella di ribadire la presenza di qualcosa che, pur godendo di una certa popolarità, risulti poi non essere davvero palese a tutti. A volte sono proprio le cose più evidenti quelle che si notano meno.
Con ASAP Research Library, progetto avviato nel 2013 e tutt’ora in corso, proponi di ripensare l’identità della biblioteca considerandola essenzialmente come un dispositivo culturale che può essere allestito e riallestito in sedi diverse e ampliato attraverso la raccolta di volumi dedicati al tema del futuro. In quest’opera il nesso tra oggettivo e soggettivo si coglie soprattutto attraverso il ruolo della relazionalità umana.
Io penso che alle persone il mio punto di vista dovrebbe interessare molto poco. Voglio dire, c’è gente là fuori che fa davvero cose incredibili. Gli artisti a confronto sono degli inetti, dai, diciamocelo. Quando ho iniziato a lavorare al progetto di ASAP Research Library ero da poco rientrata in Italia. In quel periodo mi ero accorta di come la parola ‘futuro’ venisse usata in modo smodato, eppure non la vedevo concretizzarsi in nulla. Come se il futuro così – puff! – a un certo punto per magia si dovesse palesare e risolvere tutti i problemi del mondo. Riconoscevo l’urgenza, ma sentivo che mancava una capacità di visione. Sentivo che per riuscire a ottenerla bisognava offrire degli strumenti e che questi strumenti dovevano contenere in sé un’idea forte di condivisione. Così, esclusa una prima selezione di libri che ho fatto personalmente, ho subito pensato ad ampliare la mia indagine coinvolgendo altre persone e restituendo una pluralità di voci dove la mia si mimetizzasse tra le altre. La decisione di creare una piattaforma aperta e un dispositivo culturale in perenne trasformazione è ciò che ha permesso al progetto di vedere oltre i limiti dell’approccio artistico e di cogliere le potenzialità dettate dalle continue oscillazioni tra l’oggetto futuro e le letture soggettive di chi ha interagito e continua a interagire con l’opera, dal vivo o via web.
Insieme all’attenzione per la realtà e la relazionalità coltivi anche un vivo interesse per il linguaggio – penso, per esempio, alla tua opera Dada Poem (To a Fearless Female), esposta al MAMbo in occasione della mostra That’s IT! curata da Lorenzo Balbi.
Il fenomeno del quale parlavamo prima, quello delle magliette con le scritte sopra, è stato decisivo per sviluppare Dada Poem (To a Fearless Female). Il progetto è pensato come una sorta di antologia i cui singoli ‘capitoli’ sono nati commissionando ad autrici e autori l’elaborazione di testi che dovevano partire dalla stessa richiesta: attingere da un catalogo di oltre 600 frasi da me collezionate e prese da vari capi d’abbigliamento prodotti da aziende low cost. I risultati si sono rivelati i più diversi: dalla costruzione di una canzone pop nel caso della cantautrice Bea Zanin con Dada Poem (22 Missed Calls), alla scrittura di una lettera d’amore da parte di Vincenzo Estremo con Dada Poem (To a Fearless Female). La vera difficoltà però di lavorare con il linguaggio da un punto di vista espositivo è quella di far capire al pubblico che l’opera non va solo guardata, ma va anche letta o ascoltata ed è qui che entra ancora una volta in gioco il ruolo dell’immediatezza.

Lia Cecchin, ASAP Research Library, 2013 ongoing. Installation view at Associazione Barriera, Torino 2013. Photo Yukai Ebisuno, Raffaella Mantegazza
UN APPROCCIO POLITICO
Da un punto di vista operativo, come hai lavorato per favorire questo esito?
Al MAMbo per Dada Poem (To a Fearless Female) avevo creato una imponente struttura in tubolare metallico – molto simile a quelle usate nei negozi di fast fashion – su cui erano stati adagiati una ventina dei capi selezionati dal mio archivio. Questa si articolava dietro a due vetrine ricavate chiudendo due aperture all’interno del museo e permettendo così l’accesso al lavoro solo seguendo il percorso di mostra. Il testo era infatti fruibile solo una volta dentro alla sala ospitante l’installazione, dove questo veniva diffuso nell’ambiente attraverso la registrazione audio di una voce femminile, interprete delle parole di Vincenzo Estremo; le stesse prese in prestito da quegli abiti che il pubblico poteva vedere esposti.
Questo modo di lavorare credo riveli anche la tua distanza da un eventuale esito decorativo che potresti ottenere con l’arte. Forse, favorendo così un approccio più politico nel praticarla.
Sì, sono davvero lontana da una idea decorativa dell’arte. Ma lo sono anche da una eventuale sua concezione politica, nel senso più stretto e popolare del termine. Piuttosto sono incline a riconoscere un legame con un’attitudine, che potrebbe essere detta ‘politica’, soprattutto nella scelta di lavorare sulle urgenze, su aspetti della realtà cercando di esaminare fenomeni che sono all’ordine del giorno e di coglierli mentre si presentano.
Lo stesso approccio è anche all’origine della tua ultima opera: Una città cancella, l’altra scrive, installata nel Parco di Villa Croce a Genova.
Io trovo che la realtà abbia una sua poeticità. Una città cancella, l’altra scrive nasce da una scritta lasciata con lo spray su un muro di Torino nel 1976 e immortalata in una foto dell’epoca. Un periodo in cui le scritte sui muri erano particolarmente dure, spesso taglienti e minacciose. Qui invece c’era una grafia gentile e una constatazione semplice. Quella scritta l’ho osservata per anni. Poi, l’anno scorso, grazie agli Amixi per l’Arte Contemporanea e a Luca Cerizza che mi hanno dato fiducia scegliendo il mio progetto, ho avuto l’occasione di rendere omaggio alla creatività anonima della strada con questo intervento che si relaziona davvero con lo spazio pubblico.
Consideriamo il rapporto con lo spazio pubblico: l’opera è una insegna sulla quale con il neon c’è scritto: ‘è un momentaccio!’ Perché hai scelto di usare una insegna luminosa?
Mi interessava che prendesse vita di notte, in quel lasso di tempo in cui chi ha un messaggio da comunicare prende coraggio di scriverlo su un muro; così ho sostituito lo spray con il tubo di neon. Quando si legge che ‘è un momentaccio!’, prima di tutto, si tende a pensare alla soggettività: come se si trattasse dell’affermazione di una persona che si trova in particolare difficoltà, ma si dovrebbe invece guardare alla comunità, alle relazioni. In questo senso anche la sua collocazione non è casuale: si rivolge sì, alla città, ma anche al mare e anche a quello che c’è aldilà.
Riconosciuto che la situazione è complicata, può darsi sia possibile trovare anche una via per ripartire…
La situazione è sempre e da sempre complicata, per qualcuno, da qualche parte. Un punto di contatto tra questa e altre mie opere è la visione del tempo come qualcosa di ciclico. Spesso capita che ammettere che sia un momentaccio voglia dire ridurre l’affermazione a un particolare momento, ma questo come altri eventi – e come anche i recenti fatti di cronaca tendono a mostrarci – può invece capitare ciclicamente a chiunque.
‒ Davide Dal Sasso
 1 / 8
1 / 8
 2 / 8
2 / 8
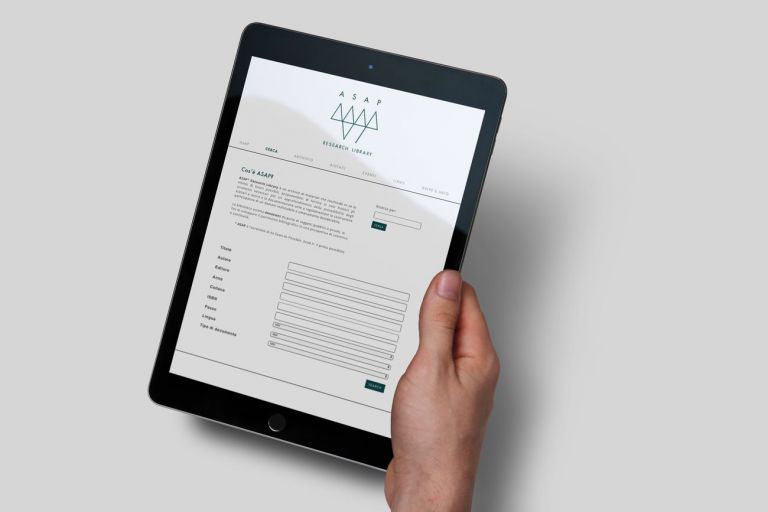 3 / 8
3 / 8
 4 / 8
4 / 8
 5 / 8
5 / 8
 6 / 8
6 / 8
 7 / 8
7 / 8
 8 / 8
8 / 8
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati













