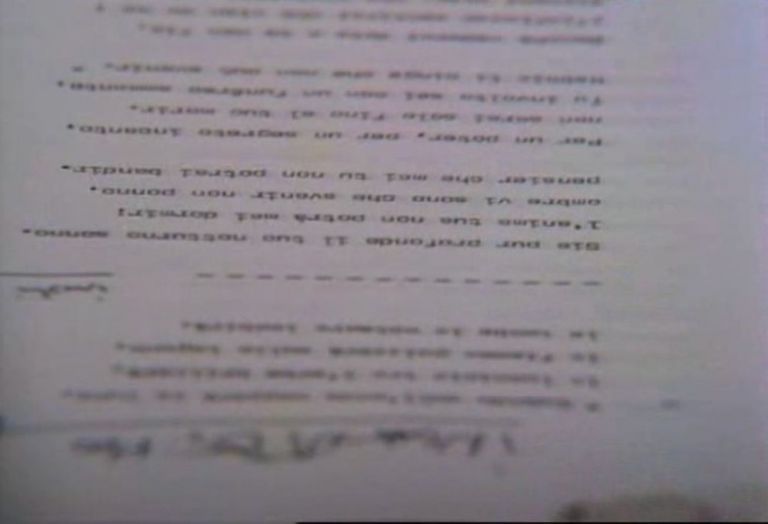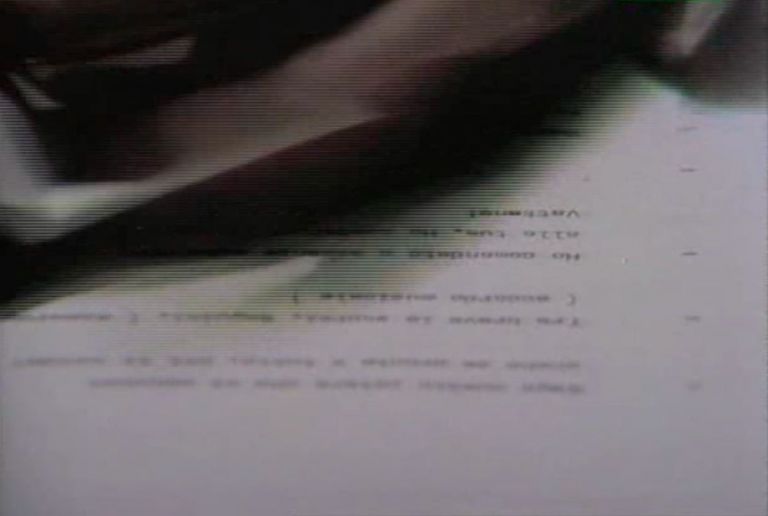Intervista a Leonardo Mancini, lo studioso di Carmelo Bene
Lo studioso protagonista di questo nuovo Dialogo di Estetica è Leonardo Mancini. Partendo dal suo ultimo libro, pubblicato pochi mesi fa e intitolato “Carmelo Bene: fonti della poetica”, abbiamo affrontato alcuni temi che riguardano il teatro e la voce.
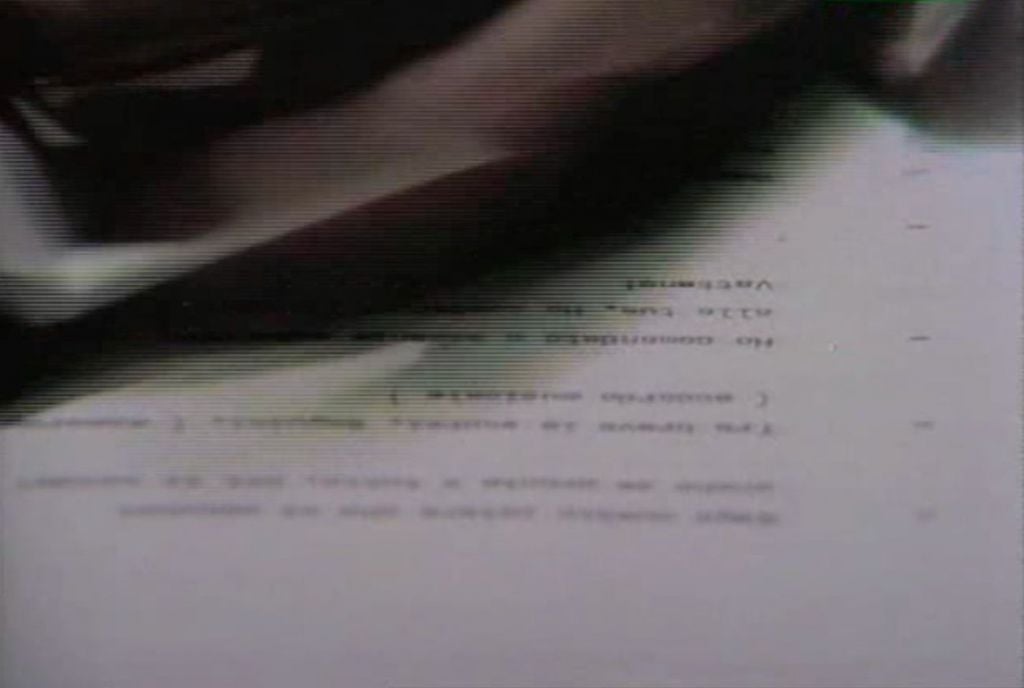
Leonardo Mancini è assegnista in Discipline dello Spettacolo presso l’Università di Verona. Le sue ricerche sono rivolte al teatro italiano fra Otto e Novecento con particolare attenzione per i temi della declamazione e della lettura ad alta voce. Ha condotto progetti teatrali in Italia e all’estero, collaborando con compagnie e con registi internazionali. Dal 2010 ha inoltre operato come consulente e responsabile nel settore dell’editoria digitale per conto di case editrici e di fondazioni. È membro di comitati scientifici ed editoriali di diverse riviste di studi, fra cui recentemente il Journal of Theatre Anthropology fondato da Eugenio Barba nel 2021. Il dialogo affronta alcuni aspetti della poetica di Carmelo Bene alla luce degli studi presentati da Mancini nel suo recente libro Carmelo Bene: fonti della poetica, pubblicato per i tipi di Mimesis nel 2020.
Il tuo libro Carmelo Bene: fonti della poetica offre un prezioso studio dedicato all’approdo di Bene al melologo nel quadro della sua pratica artistica. Quali sono le principali ragioni che hanno orientato le tue ricerche su questo tema?
Nonostante la sua rilevanza storica e la sua forza innovatrice, la cosiddetta svolta musicale di Carmelo Bene, avviata con il Manfred di Byron-Schumann nel 1979, ha goduto di una ricezione minore, manifestatasi soprattutto nel periodo successivo alla scomparsa dell’artista. Ciò può essere in parte dipeso da alcune zone d’ombra nella ricostruzione di quella vicenda; da un lato, in relazione al percorso unico di Bene nell’ambito della sua carriera; dall’altro, a quello storico più ampio entro cui essa ha avuto luogo. Il mio desiderio è stato dunque quello di indagare le tappe della maturazione nell’ampia rete di relazioni storiche e culturali dalla quale tale “svolta” scaturì.
Approfondiamo il discorso sul melologo.
Punto di incontro per eccellenza fra musica e declamazione, all’interno di un repertorio rimasto minore in Italia, il melologo si prestò a campo di sperimentazione ideale per un ulteriore passo avanti nella ricerca sulla voce e sulla parola da parte di Bene. La musicalità della parola declamata, che in verità per Bene si esprime massimamente in assenza della musica, divenne così una delle condizioni per l’avvento della phonè, annunciata poco dopo il Manfred. Visto in una prospettiva più ampia e in quanto fenomeno culturale, Bene getta una luce particolare in grado di illuminare percorsi inediti a lui antecedenti, rispetto ai quali egli costituì un momento di espressione culminante e di recupero inatteso per la storia del teatro italiano ed europeo.

Leonardo Mancini – Carmelo Bene. Fonti della poetica (Mimesis, Milano 2020)
CARMELO BENE E IL TEATRO
Considerando il teatro alla luce della sua relazione con la cultura e le altre arti, nel tuo libro prende forma anche una riflessione sul fare teatro, sulla natura stessa della pratica artistica. L’uomo di teatro – almeno nei termini in cui Bene ne parlava – è un lavoratore, un produttore di opere ma anche un “‘facitore di farse’, un consolatore”. Che importanza pensi abbia avuto la consapevolezza di queste sfaccettature del mestiere nella sua personale ricerca sui rapporti tra musicalità e parola declamata?
Sin dai primi passi nell’arte, Bene delineò la propria poetica teatrale sulla base di un netto rifiuto della rappresentazione, reso evidente tanto sul piano scenico quanto su quello, per lui niente affatto secondario, letterario. Negli anni cruciali del suo apprendistato giovanile, trascorso in parte a Firenze, si era inoltre avvicinato ad alcuni importanti compositori, dalla cui collaborazione avrebbe istituito un rapporto fondativo con la musica che in seguito non avrebbe mai abbandonato. Sulla base di queste premesse, maturò un elemento cruciale della sua ricerca, nella quale parola, voce, musica e immagine miravano a convivere in un unico contesto. Fu così che, quando fece il suo ingresso nei teatri lirici d’Italia con il Manfred (ma il debutto vero e proprio era stato nell’edizione dello Spettacolo-concerto Majakovskij del ’68 al Regio di Parma con Vittorio Gelmetti), poté chiarire la sua attenzione verso la musica come un teatro dell’irrappresentabile, una scena dell’assenza non priva di una tensione di tipo metafisico.
Attraverso uno studio di carattere storiografico, nel libro metti anche in risalto la necessità di riconoscere quella che proponi di chiamare “la pars construens” della poetica di Bene. Quali sono le sue caratteristiche?
Di Bene è noto soprattutto il successo, ma è purtroppo un fatto che subì anche forme di delegittimazione e dovette deporre numerosi progetti sin dai suoi esordi, in una fase in cui nutriva radicali propositi di riforma del teatro comprendenti anche una riconfigurazione dello spazio scenico. I progetti irrealizzati di Bene, lungo tutto il corso della sua carriera, sono altrettanto interessanti e rivelatori di quelli portati a termine, e denotano una linea poetica che a più riprese desiderò approfondire maggiormente.
Quali sono questi progetti irrealizzati?
Rientrano in questa categoria, ad esempio, progetti riguardanti l’Eugenio Onegin di Puškin, ideato nel ’68, e le Scene dal Faust di Goethe di Schumann nei primi Anni Ottanta. Si deve anche considerare che l’ostinato rifiuto di adeguarsi al sistema di organizzazione dello spettacolo e ai suoi canoni estetici portarono Bene a manifestare un’insofferenza e una polemica incalzante che, con gli anni, hanno finito per creare uno dei modi più consolidati, e immediati, di guardare alla sua figura. Dopo la scomparsa di Bene, complice anche la circolazione parziale e senza criteri scientifici di alcuni stralci relativi alle sue apparizioni pubbliche, si è assistito a una crescente ricezione frammentaria e aforismatica non priva di rischi di banalizzazione e di decontestualizzazione. È possibile porsi al riparo da una lettura omologante del suo pensiero e della sua opera adottando una prospettiva più ampia che superi la sola provocazione. Guardare alle cose nella direzione da lui indicata non dovrebbe dunque servire a un’imitazione pallida del suo genio, quanto semmai a una prosecuzione dello scavo che egli ha saputo tracciare.

Leonardo Mancini
CARMELO BENE SECONDO LEONARDO MANCINI
L’interesse per la declamazione da parte di Bene – un riferimento cruciale nel tuo studio – permette di considerare l’ipotesi secondo cui nella sua poetica si conservino elementi rilevanti della tradizione culturale nella quale coesistevano musica e teatro. Attraverso il suo lavoro sulla phonè e sulla “macchina attoriale”, Bene insisteva infatti sulla non appartenenza del discorso all’essere parlante e sulla possibilità di “essere parlati” fisiologicamente. Come hai affrontato questi aspetti?
Il linguaggio è vissuto da Bene come tradimento e la voce, nella sua dimensione quotidiana di falsificazione e trascuratezza, come un veicolo di trasmissione di significati soggiacenti: in definitiva, come uno strumento del potere, in grado di annidarsi anche nei contesti dell’arte. In questo senso un teatro concepito solo come spettacolo rinuncia alle sue potenzialità più profonde e si allinea inevitabilmente alle mode del momento. Di fronte a una dimensione impositiva della rappresentazione, Bene opera così uno smarcamento all’insegna della sottrazione che, sulla scia di una tradizione teatrale e filosofica cui dichiara espressamente di ricongiungersi, da Diderot a Mejerchol’d, gli consente di ricercare una dimensione diversa, ulteriore. Attraverso la propria poetica di attore-artefice, niente affatto improvvisata ma basata su strutture precise, approda così a una tipologia di convenzione scenica che apre, e non preclude, a una dimensione sacra del teatro, da lui esplicitata nel saggio sulla Voce di Narciso del 1981. Anche per quanto attiene alla declamazione, si allaccia a un percorso storico del passato, avvertito come interrotto ma da lui rivivificato.
Nella sua Autografia d’un ritratto, risaltano in particolare due questioni presentate da Bene che credo siano importanti da considerare: la critica alla scrittura (benché parte del lavoro teatrale si basi anche su di essa, è ritratta come “funerale” dell’oralità) e la centralità del fare, che Bene afferma almeno in due modi: identificando un’azione interrotta con una “sospensione del tragico” e dichiarando che “chi non lavora non esiste, comunque”. Credi siano stati rilevanti queste posizioni per l’inclinazione di Bene al melologo – tenendo conto anche della sua passione per poesia e letteratura?
Bene manifesta una vivacità letteraria esuberante prima ancora del suo approdo al teatro e si congeda infine dal mondo con due poemi: ‘l mal de fiori (2000) e l’inedito Leggenda. Nel corso della vita compone inoltre alcune opere, in versi e in prosa, che sono oggi parte della letteratura italiana e che, recentemente, sono state sceverate alla ricerca dei meccanismi interni di funzionamento. Il rapporto con la scrittura è dunque ininterrotto nella vita di Bene e traccia una delle linee di continuità cruciali all’interno della sua arte. Ma l’attenzione microscopica alla parola è raggiunta sommamente sulla scena, non sulla pagina scritta, e scatena un campo di battaglia nel quale le sonorità più recondite di ciascuna sillaba acquisiscono una forza altrimenti a loro negata. Così, quando Bene scopre il melologo, lo affronta sì con spirito di innovazione, ma sulla base di un terreno fertile già predisposto alla riconquista di una dimensione musicale della lingua. Anche le sue altre letture poetiche, tra cui la Lectura Dantis del 1981 a Bologna o l’Adelchi di Manzoni nel 1984 a Milano, sono tutte incentrate sull’attenzione metrica e si collocano perfettamente nel contesto che Bene predilige: la lettura in versi ad alta voce, con o senza musica.
Bene era interessato alla interruzione delle sequenze, al risuonare dell’instabilità nella pratica artistica. Quando c’è un rintocco di eventuale irregolarità, un intervallo inaspettato, si presenta la fisiologia dell’atto teatrale: quella “sospensione del tragico” che lascia spazio alle possibilità dell’espressione. Come possono essere considerati questi aspetti della sua poetica in rapporto alle sue scelte inusuali, all’interesse a coltivare anche generi minori del teatro?
Ciò che potrebbe essere considerato come un equivalente scenico dello squarcio della tela si manifesta in Bene al vertice della melopea. Nel Manfred un tale atto si verifica nel monologo di apertura, volutamente anticipato rispetto all’ouverture dell’op. 115 di Schumann. Riconosciuta la fallacia della conoscenza, Manfred riflette sulla propria condizione solitaria e irrisolta nel mondo, in attesa di passare all’azione. Nell’edizione televisiva di Bene, l’inquadratura sposta improvvisamente l’attenzione su una pagina annotata del copione dattiloscritto, appena sfogliato con forza dall’attore; il foglio contiene un brano testuale che è in verità successivo nel poema, relativo all’incantesimo degli spiriti nella prima scena del primo atto, poi declamato da Lydia Mancinelli in una traduzione ottocentesca. Un analogo e ancora più forte spiazzamento narrativo avviene nuovamente nel brano relativo alla lugubre descrizione della città avvolta dalla peste, da parte della seconda Parca (a. III, s. III), declamata da Bene con voce funerea. Come si legge nella didascalia al testo, l’attore “strappa il foglio e cestina”; nella versione televisiva ciò avviene ex abrupto in una brevissima sequenza della durata di due secondi che rivela nuovamente il copione di Bene, ancora capovolto. La pagina del testo è improvvisamente stracciata dall’attore e il gesto, amplificato dal microfono, produce il suono metallico di una lacerazione spaventosa. Questi gesti improvvisi interrompono l’opera dal suo interno e attuano quella “sospensione del tragico” cui Bene mirava: proprio come essa è esercitata dal cavaliere della fede in Kierkegaard (Abramo, opposto all’eroe tragico), che si “rifiuta alla mediazione”, sospende la morale e insegue un telos più in alto.
– Davide Dal Sasso
Leonardo Mancini – Carmelo Bene: fonti della poetica
Mimesis, Milano 2020
Pagg. 382, € 26
ISBN 9788857571133
mimesisedizioni.it
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati