Reportage e recensione dalla 15esima Sharjah Biennial
Fa i conti con gli effetti del colonialismo la nuova edizione della Sharjah Biennial, la rassegna in corso negli Emirati Arabi Uniti. Ecco quali sono le opere che abbiamo apprezzato di più

Da che mondo è mondo le espressioni artistiche creano linguaggi in grado di connettere il qui e ora con il là e allora. Decodificare quei linguaggi e leggere quelle connessioni è cruciale per creare sistemi culturali articolati. Un atlante di questa complessità è la Sharjah Biennial. Inaugurata il 7 febbraio e in corso fino all’11 giugno, l’edizione 2023 della biennale porta in cinque aree del terzo emirato per estensione e popolazione oltre 300 lavori di 150 artisti, provenienti da più di 70 Paesi.
A curare la quindicesima edizione, che segna anche il trentesimo anniversario della manifestazione e che era inizialmente prevista per il 2021, avrebbe dovuto essere il nigeriano Okwui Enwezor, scomparso tuttavia nel 2019, quando le idee per l’edizione del trentennale erano ancora in embrione. A prendere lo scettro curatoriale è stata così la sceicca Hoor Al Qasimi, direttrice della biennale, nonché della Sharjah Art Foundation, nata nel 2009 per dare continuità al lavoro della biennale.
Al pensiero e alla pratica di Enwezor Al Qasimi si è ispirata fin dai suoi primi passi nel mondo dell’arte, dai tempi della rivoluzionaria documenta 11 che la convinse della necessità di cambiare il formato dell’allora giovane biennale emiratina, come ci aveva raccontato in un’intervista dell’anno scorso.
Un legame, quello con il curatore nigeriano, che Al Qasimi sottolinea spesso, identificandolo come filo conduttore delle scelte di questa edizione, quasi a obliterare il proprio contributo, quasi ne fosse ancora lui il curatore, per interposta persona. Delle loro conversazioni in vista dell’edizione del trentennale, la direttrice ricorda come il curatore nigeriano riconoscesse l’unicità del modello Sharjah nell’aver creato un’istituzione a partire dalla Biennale e non viceversa. “Non era interessato a un’ennesima biennale”, ha detto Al Qasimi in apertura della mostra, bensì al processo comunitario di creazione di un’istituzione in grado di lavorare sul territorio.
Per questa quindicesima edizione la Sharjah Biennial celebra i risultati raggiunti in tre decenni di lavoro in cui è passata da rassegna di artisti locali a manifestazione di respiro globale, senza perdere le proprie radici. Quest’anno la biennale guarda al Sud del Mondo e a quella che Enwezor definiva costellazione post-coloniale, quel campionario di esperienze complesse originate dall’impatto dei poteri imperialisti sulle popolazioni dominate. Un universo geografico e culturale di cui la Sharjah Biennial e gli Emirati in genere vogliono essere propulsore, incubatore e punto di riferimento. Questa edizione in particolare diventa manifesto di un’espressione artistica che è rivendicazione e riappropriazione. A emergere è un ecosistema artistico in cui le esperienze post coloniali si intrecciano e riflettono all’interno della cornice creata da un’istituzione ben radicata nella sua storia e allo stesso tempo ben consapevole del suo presente.

Hajra Waheed, Hum II, 2023. Commissioned by Sharjah Art Foundation; supported by Canada Council for the Arts, Ottawa. Photo Shanavas Jamaluddin
LA SHARJAH BIENNIAL SECONDO LA CURATRICE AL QASIMI
Il concetto curatoriale, espresso nel titolo Thinking Historically in the Present, sintetizza una visione circolare del tempo e dello spazio, che, da una parte, è lettura del presente attraverso una visione storica, dall’altra è movimento multicentrico e multidirezionale. Con tale idea, la Sharjah Biennial si presenta a questo anniversario come una biennale legata alla sua storia e a quella della zona del mondo in cui è stata concepita, in dialogo con le sue stesse origini, ma allo stesso tempo in grado di esprimere e aggregare le istanze di un oggi in cui una parte del mondo è decisa a disincagliarsi dalla storia coloniale. La biennale, come Sharjah stessa e gli Emirati Arabi in genere, è espressione di un presente proiettato verso il futuro, quanto ancorato alla tradizione. La circolarità si esprime anche in una biennale che rifiuta il modello di centro vs periferie, di grandi nomi vs artisti emergenti.
“Per questo ho bandito la parola offsite”, ha detto ad Artribune la curatrice Hoor Al Qasimi, “per me tutti i luoghi sono egualmente importanti e centrali. Recuperare edifici storici abbandonati e preservare il patrimonio architettonico è da sempre parte di quello che facciamo. Ma per me è importante anche che in questi luoghi ci sia una nuova vita. Per questo abbiamo sette centri d’arte che la Fondazione utilizza già da diversi anni, impiegando persone locali”.
Quest’anno la Fondazione ha scelto di coinvolgere tali spazi nella biennale, diffondendo la manifestazione tra le diverse aree dell’Emirato, dalla città di Sharjah alla costa est, passando per le regioni rurali del centro. “Quando mi dicono ‘quello spazio è lontano’, io rispondo: lontano da cosa? Ci sono persone che abitano in quei luoghi e per loro è quello il centro. Per me è importante coinvolgere le comunità di queste aree che non voglio vedere come periferiche. Per questo abbiamo creato diversi workshop anche per bambini, incontri con gli artisti e collaborazioni con l’università. In questo senso questa biennale, più di altre, riflette quel concetto di Okwui del modello che va dalla biennale all’istituzione e non viceversa”.
Una manifestazione che è stata in grado di crescere con il territorio e le sue comunità, creando lavoro e formando un’intera generazione. “Ci vogliono generazioni per produrre cambiamento”, dice ancora Al Qasimi, “e, quest’anno più che mai, vedo quel cambiamento”. Alle comunità locali la biennale porta lo sguardo globale di esperienze, pratiche e storie individuali provenienti da altri luoghi del mondo, creando, ancora una volta, una circolarità tra locale e globale, tra particolare e universale. “Abbiamo la necessità di riscrivere la nostra storia e per questo c’è molto spazio nell’arte contemporanea, ma c’è anche spazio per creare una risonanza nelle voci”. Risonanza che tuttavia sembra avere un punto cieco proprio nel locale. Se la biennale guarda al mondo attraverso la lente della critica socio-politica, non può che risultare evidente che le manca qualcosa: la capacità (o la possibilità?) di rivolgersi verso l’interno, di girare il cannocchiale con cui guarda al mondo verso un presente fatto di libertà limitate e forti diseguaglianze.
“A volte sei limitato da governi e istituzioni e provi ad abbattere le barriere con l’arte e a volte ti metti nei guai, come a me è successo molte e molte volte [ride, N.d.R.]. Altre volte trovi altre strade. Si può comunque creare una conversazione senza dover gridare e credo che questa biennale chieda soprattutto di sentire le cose, è una biennale molto emozionante. Ed è importante sentire le cose, non solo parlarne”, conclude Hoor Al Qasimi.
Ecco allora cinque delle installazioni in cui abbiamo “sentito” di più il tema della biennale.

Doris Salcedo, Uprooted, 2020 2022. 804 dead trees and steel; courtesy of the artist. Photo Juan Castro Photoholic
DORIS SALCEDO, KALBA ICE FACTORY
Una foresta di 804 alberi sradicati e scheggiati si fa sempre più fitta fino a che tronchi e rami diventano pareti di un’impenetrabile casa. L’installazione site specific di Doris Salcedo (Bogotá, 1958), dal titolo Uprooted (2020-22), empaticamente simbolizza la condizione dei migranti, sradicati e costretti all’impermanenza dalla distruzione ambientale causata dal capitalismo. L’edificio che i tronchi degli alberi (i corpi dei migranti? La natura stessa?) vanno a formare ha l’apparenza di una casa ma non ne ha la funzione: non c’è porta, non c’è ingresso, non c’è spazio. Non c’è spazio per i migranti nella casa che i loro corpi hanno costruito, non c’è spazio per l’umanità nella natura morente che si chiude su se stessa. Eppure c’è un intreccio di rami, che, insieme, danno forma a un reticolo, a un sistema, a una struttura monumentale, solida e protetta. C’è una forza collettiva che, appoggiando su radici sradicate, si oppone all’esterno e continua la sua avanzata. A volerla leggere nello specifico contesto del Paese che ospita questa biennale, quella di Salcedo è un’opera che non ha bisogno di tante parole.

Lavanya Mani, Imperiled Geographies, 2022. Installation view Sharjah Biennial 15, Al Hamriyah Studios, 2023. Photo Motaz Mawid
LAVANYA MANI, AL HAMRIYAH STUDIOS
Storie fantastiche e miti esotici circondano l’immaginario legato all’Oriente e si intrecciano nelle trame della tradizione tessile dell’India. Lavanya Mani (Hyderabad, 1977) ricontestualizza quell’immaginario attraverso una varietà di tecniche di lavorazione e colorazione dei tessuti. Nella stanza a lei dedicata all’interno dell’edificio degli Al Hamriyah Studios, l’artista espone una serie di opere realizzate tra il 2009 e il 2022 che esplorano il rapporto tra l’arte tessile indiana, la flora locale che tanto affascinò i viaggiatori europei e i prodotti e materiali che accesero gli interessi coloniali. Il suo lavoro è una mappatura delle interrelazioni tra sistemi ecologici, saperi tradizionali, rapporti di potere e dinamiche globali. Attraverso disegni reminiscenti delle tavole botaniche di era coloniale, pitture realizzate con la ruggine, ricami e tessuti naturali, l’artista esplora il ruolo di specie vegetali e animali nel modificare ecosistemi e culture e dare forma alla storia umana.

La stanza con le cassette di sicurezza che compongono Cultural Exchange Rate (2019) di Tania El Khoury. Foto Maurita Cardone
TANIA EL KHOURY, BANK STREET BUILDING
L’artista di origini libanesi porta alla Sharjah Biennial una performance e un’installazione. Quanto informativa e analitica è la prima, tanto è intuitiva ed emozionale la seconda, in grado, come pochi altri lavori in mostra, di muoversi giocosamente sul terreno al confine tra storia personale e storia collettiva, tra esperienze individuali e fenomeni sociali. Cultural Exchange Rate (2019) è un’installazione composta da decine di cassette di sicurezza; lo spettatore riceve un mazzo di chiavi e, seguendo un ordine stabilito dall’artista ma di cui esistono diverse versioni, le apre una alla volta per scoprire piccoli scorci attraverso i quali costruisce un percorso nella ricerca compiuta da Tania El Khoury (Jouneih, 1982) nella storia della sua famiglia, tra il villaggio di Akkar e Città del Messico, tra il sogno di una vita migliore, guerre e patriarcato. In ogni cassetta di sicurezza, lo spettatore si immerge in un’esperienza multisensoriale che racconta un pezzo di quella ricerca e le sue intersezioni con la vita dell’artista.

Isaac Julien, performance view, Sharjah Biennal 15, 2023
ISAAC JULIEN, CALLIGRAPHY SQUARE
Il passato riemerge per dare una lettura del presente fatta di chiaroscuri in Once Again (Statues Never Die) (2022), una videoinstallazione a cinque canali in bianco e nero che è forse une delle opere che più letteralmente interpreta il tema della biennale. Nei video, spezzoni di una messa in scena di una conversazione tra il collezionista Albert Barnes e il filosofo afroamericano Alain Locke si alternano a immagini di collezioni di arte africana, interventi di una fittizia curatrice che scardina lo sguardo occidentale su quell’arte e sequenze in cui la cantante Alice Smith riempie con la sua voce gli spazi vuoti di quello che appare come l’atrio di un museo. Creando un contesto storico al dibattito contemporaneo sulle restituzioni e sull’autorialità nell’arte africana, l’opera di Isaac Julien (Londra, 1960) apre una riflessione sulle infinite possibilità del presente diasporico, in una circolarità temporale visivamente sottolineata da una neve che cade dal basso verso l’alto. Usando le parole del teorico della Négritude Aimé Césaire nel saggio del 1950 Discourse on Colonialism, l’artista sintetizza: “Il problema non è fare un tentativo utopico e sterile di ripetere il passato, ma andare oltre”.

Bahar Behbahani, Garden of Desire, 2023. Produced by Sharjah Art Foundation. Installation view Sharjah Biennial 15, Bait Al Serkal, Sharjah, 2023. Photo Danko Stjepanovic
BAHAR BEHBAHANI, BAIT AL SERKAL
Quando Bahar Behbahani (Teheran, 1973) aveva iniziato a interessarsi ai giardini persiani e al fascino esotico che questi avevano per l’Occidente, uno dei testi più noti sull’argomento era quello di Donald Wilber. Anni dopo venne alla luce che l’autore era in realtà un agente della CIA che utilizzava le sue ricerche come copertura per le attività di spionaggio a supporto del colpo di stato del 1953 che rovesciò il governo democraticamente eletto di Mohammad Mosaddegh, il quale aveva avviato piani per la nazionalizzazione del petrolio del Paese, una prospettiva invisa agli Stati Uniti. Documenti desecretati in anni recenti hanno confermato il coinvolgimento del governo americano negli sconvolgimenti politici che hanno portato l’Iran alla situazione attuale.
In Garden of Desire (2023), Behbahani riproduce le geometrie e il sofisticato sistema di auto irrigazione del Giardino di Fin, uno dei più spettacolari giardini persiani, creando un’opera che, nel corso della biennale, si riempirà di erbe spontanee che, un po’ alla volta, fagociteranno pagine dei documenti desecretati, appoggiate sulla terra. In un movimento ancora una volta circolare, il presente, vivo e attivo, ingoia l’indelebilità del passato, per creare un futuro la cui natura è complessa e ibrida.
Maurita Cardone
https://sharjahart.org/biennial-15
 1 / 31
1 / 31
 2 / 31
2 / 31
 3 / 31
3 / 31
 4 / 31
4 / 31
 5 / 31
5 / 31
 6 / 31
6 / 31
 7 / 31
7 / 31
 8 / 31
8 / 31
 9 / 31
9 / 31
 10 / 31
10 / 31
 11 / 31
11 / 31
 12 / 31
12 / 31
 13 / 31
13 / 31
 14 / 31
14 / 31
 15 / 31
15 / 31
 16 / 31
16 / 31
 17 / 31
17 / 31
 18 / 31
18 / 31
 19 / 31
19 / 31
 20 / 31
20 / 31
 21 / 31
21 / 31
 22 / 31
22 / 31
 23 / 31
23 / 31
 24 / 31
24 / 31
 25 / 31
25 / 31
 26 / 31
26 / 31
 27 / 31
27 / 31
 28 / 31
28 / 31
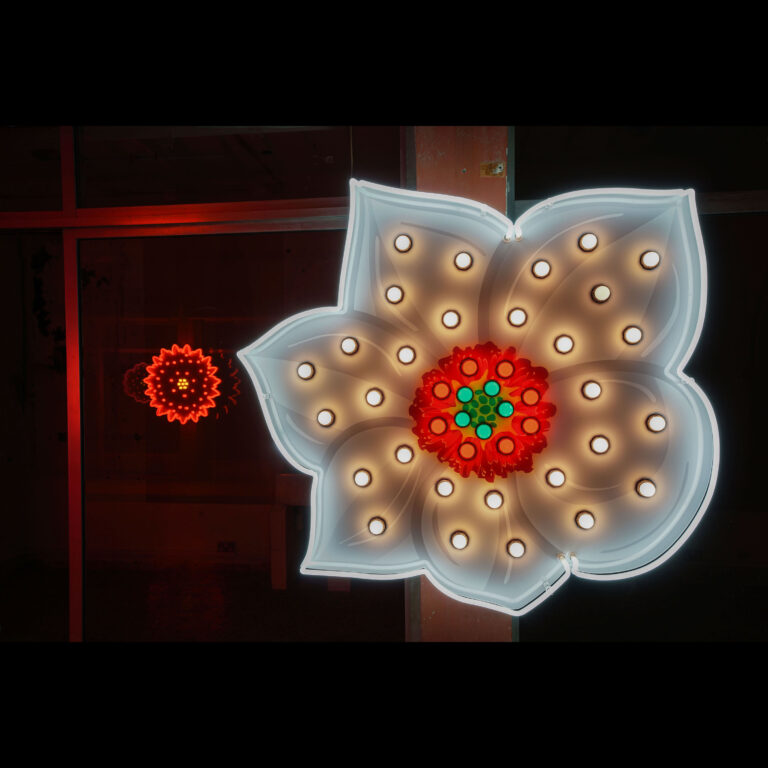 29 / 31
29 / 31
 30 / 31
30 / 31
 31 / 31
31 / 31
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati




































