Ma perché *?!!** non facciamo film così?
Un film inglese sugli anni ’80, che viene girato nel 2006 e arriva in Italia cinque anni dopo. Un film coraggioso, realizzato con fondi pubblici. Viene naturale fare un paragone col nostro Paese.

This Is England (Shane Meadows, 2006, distribuito in Italia soltanto adesso) è un film meraviglioso. Cattivo, coraggioso con la storia collettiva di un Paese, in grado di fare i conti con un’identità (che è anche un’eredità) completamente al di fuori di retoriche pelose. Basterebbero i titoli di testa: un attimo e bum!, siete già immersi nei primi anni ‘80 del Regno Unito, tra crisi economica, neoconservatorismo d’assalto, rivolte sociali e grande cultura popolare.
Ma c’è molto di più. C’è il romanzo di formazione, e va bene. C’è l’amicizia, la scoperta dell’ingiustizia e della violenza. Tutti questi elementi compongono il ritratto efficace e fulminante di un’intera società.
Soprattutto, This Is England è un’opera controversa, esattamente come dovrebbero essere tutti gli oggetti culturali che vogliono far riflettere, e non solo accarezzare, confermare i preconcetti e il “già noto”. Controversa perché ritrae senza fronzoli la rabbia e la frustrazione – così simili a quelle attuali – di una generazione. E lo fa con uno stile coerente, consono, senza cadute televisive. E originale, pur rimanendo ricco di richiami anche colti al grande cinema inglese di denuncia.

Shane Meadows - This Is England - 2006
E – udite, udite – il film è realizzato anche con fondi pubblici: la lotteria nazionale, lo UK Film Council e soprattutto lo Screen Yorkshire. Vale a dire, l’equivalente delle nostre Film Commission regionali. Immaginate, per dire, l’articolo 8 che finanzia un film sulla scoperta dolorosa della vita da parte di un gruppo di giovani skinhead. Con le crepe della società tutte in evidenza, che fanno male a guardarle. Con l’educazione all’odio come risposta alla desolazione e alla disintegrazione.
Ora, la domanda è: perché diavolo noi non siamo in grado di fare un film del genere? Perché non è possibile in questi anni vedere sugli schermi una freschezza del genere? È certamente vero che i nostri primi anni ‘80 non sono stati così culturalmente brillanti come quelli britannici. Eppure, se proprio ci volessimo fermare a quel periodo, di materiale “ottimo e abbondante” (come direbbe l’Oreste Jacovacci de La grande guerra: quello sì, un ottimo esempio…) ce ne sarebbe eccome. La mutazione antropologica di un’intera società. La transizione dal conflitto sociale all’epoca del riflusso e dell’“edonismo”. La nascita delle tv private, che equivale all’introduzione storica di un intero, nuovo dispositivo spettacolare e culturale, destinato a durare almeno trent’anni. La letteratura – per esempio, con il recente Dove eravate tutti di Paolo Di Paolo – sta cominciando appena adesso a fare di quell’epoca il proprio tema.
Ma non è detto che ci si debba occupare per forza degli anni ‘80 (e quindi, il problema non sta lì). Anche questi tempi che ci sono dati da vivere sono – purtroppo – piuttosto interessanti. Ma tutti i film che lambiscono gli argomenti sociali lo fanno con le armi spuntate della commedia italiana “annizero”: un genere ormai a sé stante, che fa dell’autoconsolazione e dell’autoassoluzione il suo tratto distintivo, contro peraltro la stessa tradizione italiana degli anni ‘60 e ‘70. Che è come dire: “Ho un modello di atteggiamento e di approccio che funziona, e scelgo invece per convenienza e comodità di fare regolarmente l’esatto opposto”.
La questione non è il periodo storico in cui è ambientata la narrazione (il Ventennio, gli anni ‘50, gli anni ‘70). La questione ha a che fare con il tipo di storie che si sceglie di raccontare, e soprattutto con il modo in cui le si racconta: sempre uguale a se stesso, costantemente avvitato su se stesso, non “esorbita” mai e non accenna mai al resto, al mondo contemporaneo di cui ogni altra storia è una metafora. C’è anzi una fobia di questo stesso mondo, un’ansia di rimozione e un desiderio irrefrenabile di fuga. Di evasione. Ecco perché la storia, recente e lontana, quasi sempre fa cilecca sugli schermi italiani: scappa scappa, alla fine sei scappato anche da te stesso. E ti ritrovi a raccogliere le schegge di memoria di qualcun altro, mettendoli insieme nell’unica maniera che ti hanno insegnato. E solo in quella. Non c’è alcun fuori, al momento, nel cinema italiano: a ben guardare, cambiando radicalmente prospettiva, questa è già la condizione pressoché ideale perché questo fuori ricompaia in forme nuove, e non solo al cinema.
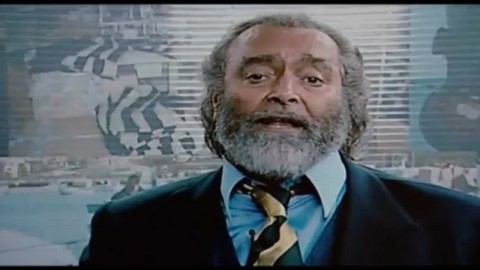
Francesco Patierno - Cose dell’altro mondo - 2011
Per ora quelle poche opere che provano a mettere, timidamente, un piede oltre la soglia nella rappresentazione della realtà nazionale (come il dignitosissimo Cose dell’altro mondo di Francesco Patierno) si beccano contumelie, semplificazioni e interpellanze parlamentari. Veramente, cose dell’altro mondo.
Christian Caliandro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





