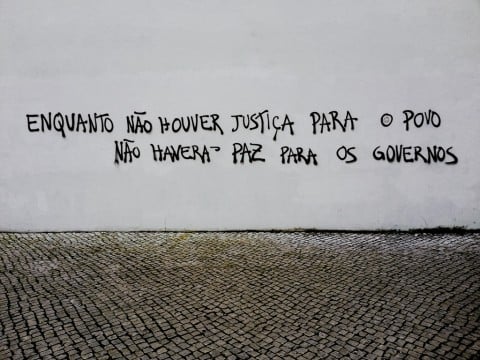La Primavera araba in un film. Intervista con Mario Rizzi
Inaugura domani 9 dicembre a Roma la nuova mostra di Mario Rizzi. Allo Studio Miscetti si presenta il primo film di una trilogia. Tre opere per raccontare la Primavera araba, insieme a un premio Pulitzer. Qui trovate il dialogo fra l’artista e la curatrice Cristiana Perrella.

Al Intithar, il film che presenti nella tua mostra allo Studio Stefania Miscetti a Roma, è il primo episodio di una trilogia sulla primavera araba intitolata Bayt, ispirata dagli scritti del giornalista due volte premio Pulitzer Anthony Shadid e in particolare alla sua autobiografia La casa di pietra, un viaggio alla scoperta delle radici libanesi dell’autore. Bayt è una parola araba che significa sia “casa” sia “famiglia” e che in tutto il Medio Oriente si usa accostare al proprio cognome quando ci si presenta, dimostrando come l’identità personale sia strettamente legata al luogo abitato dalla famiglia e a ciò che questo luogo contiene, ai legami, alle storie ai ricordi, alle immagini. Scrive Shadid: “Nel Medio Oriente, la bayt è sacra. […] Gli imperi cadono. Le nazioni crollano. I confini possono essere cancellati o spostati. La casa, vale a dire la struttura fisica o l’idea di famiglia, è invece l’identità che non sbiadisce“. È difficile immaginare come questo fondamento identitario possa essere mantenuto in una situazione come quella del campo profughi siriani di Al Zaatari, in Giordania, dove il tuo film è girato. Dove trova la forza delle radici Ekhlas, la vedova protagonista di Al Intithar, sola con i suoi figli?
Come scrive Shadid, la casa non sono solo le pietre ma qualcosa che ti porti dentro. Quando ci si trova in una situazione come quella del campo, o si riesce a tirar fuori ancora più forte il proprio senso di appartenenza, d’identità, oppure vivere diventa impossibile, ci si perde. Ekhlas riesce a tenere unita la sua famiglia attraverso la loro storia, attraverso lo spirito familiare che lei come donna cerca di tener vivo, di trasmettere ai suoi figli anche in quelle condizioni proibitive, vivendo in una tenda anonima, in mezzo a sconosciuti. Si può dire, anzi, che la vita nel campo rilevi ancora di più la coesione del loro nucleo.
Una vita che però, nonostante gli sforzi di Ekhlas, si rivela insopportabile per Abdo, il più grande dei suoi figli, che decide di tornare in Siria a combattere. Una settimana dopo il suo arrivo sarà ucciso dai fondamentalisti.
È la parte più tragica della loro storia, accaduta dopo che avevo finito il film, ma le cui premesse già si leggono nei fatti che vi sono raccontati. C’è chi riesce a convivere con quanto gli accade, senza aspirare al cambiamento – come l’altro figlio di Ekhlas, che nel campo apre una tenda-negozio e si mette a vendere pizzette – e chi invece non accetta la situazione, non si adatta, come Abdo, che ha aspirazioni differenti. L’osservazione del modo con cui ciascun individuo reagisce diversamente alla situazione in cui si trova è un elemento che torna sempre nel mio lavoro. In questo caso va anche detto che l’80% delle persone nei campi sono donne e bambini. Gli uomini generalmente rimangono a combattere nel loro Paese e quelli che sono nel campo provano una grande frustrazione, sentono di essersi sottratti al compito di difendere la loro bayt.
A motivare la scelta di Abdo c’è dunque un dato generale, condiviso, cioè il senso d’inutilità a stare nel campo quando in Siria si combatte, ce n’è poi uno caratteriale, l’incapacità di adattarsi, e poi c’è un terzo elemento che è la sua storia personale. Subito dopo l’inizio della guerra civile siriana, infatti, Abdo e suo padre vengono fermati dalle milizie di Assad, torturati e messi in carcere fino a che, dopo tre mesi, il padre viene ucciso davanti ad Abdo, che allora ha solo diciassette anni e che riesce poi a scappare. Per questo Ekhlas decide di andare via e rifugiarsi con i figli a Zaatari, ma è logico che qualcuno che ha visto uccidere suo padre davanti ai propri occhi non può accettare di rimanere nel campo, ha un’irrequietezza di fondo che glielo impedisce. La forza di Ekhlas è anche nella capacità di fare fronte a questa tensione, di riuscire comunque a tenere unita il più a lungo possibile la famiglia.
Come sei arrivato a Zaatari e come sei entrato in contatto con Ekhlas?
Quando nel 2012 ho deciso di lavorare sulla Primavera araba, raccontandola attraverso la narratività del quotidiano, le storie personali, le memorie intime piuttosto che gli eventi storici, il tema del senso di appartenenza alla storia familiare, il bayt per l’appunto, mi è sembrato un elemento importante da cui partire, proprio per la sua rilevanza nella cultura araba. Per il primo film della trilogia ho pensato di usarlo “in assenza”, parlando di qualcuno che la casa era stato costretto a lasciarla. Volevo lavorare con i profughi siriani ed ho scelto la Giordania, più precisamente il campo di Zaatari, che ospita circa 85mila profughi siriani a sette chilometri dal confine con la Siria.
Sono riuscito ad avere il permesso di passarci sette settimane, stando al suo interno per tutto il giorno ma dormendo nella città vicina di Al Mafraq, una libertà di movimento impossibile ai profughi, che dal campo non possono uscire. Zaatari è, infatti, un campo anomalo, sorto per far fronte all’emergenza su un terreno che è rimasto proprietà della Giordania e non è stato preso in leasing dall’UNHCR, l’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, come avviene di solito. La Giordania controlla il campo con i carri armati, come si vede nel film, e non permette che i rifugiati escano dal suo perimetro, se non in casi eccezionali, autorizzati dalle autorità giordane, anche se poi qualcuno riesce a scappare. Il campo tra l’altro è in una posizione geograficamente anomala, perché è in una valle che con le piogge invernali si allaga, ma è accanto a una grande base aereoportuale sotterranea utilizzata dagli Stati Uniti in varie occasioni, ad esempio durante la guerra in Iraq, che costituisce una protezione per il campo sia da attacchi esterni sia da possibili infiltrazioni al suo interno. La Giordania è, infatti, il Paese arabo più povero, senza riserve idriche, senza petrolio ma solo gas, con un altissimo tasso di disoccupazione e di corruzione, dunque la presenza di un enorme numero di rifugiati crea grosse tensioni.
Gli aiuti economici dall’estero di cui il campo gode hanno creato animosità nei giordani, così come il fatto che i siriani che potevano permetterselo abbiano affittato delle case ad Al Mafraq e nel resto della Giordania senza la necessità di richiedere lo status di rifugiati, e questo, oltre ad aumentare notevolmente la popolazione, ha fatto schizzare in alto il costo della vita. Inoltre la presenza del campo costituisce un potenziale rischio per la monarchia giordana, perché il contatto con l’opposizione siriana potrebbe rafforzare i Fratelli Musulmani, già piuttosto forti nel Paese, minando la stabilità della forma di stato attualmente vigente.
I rifugiati siriani in Giordania sono moltissimi. Solo quelli registrati dall’UNHCR, una minoranza, sono circa 640mila. Il totale si pensa superi il milione di persone.
Sì, e non sono tutti nei campi, anzi, molti lavorano ad Amman, in condizioni di sfruttamento incredibili. Intere famiglie vivono in una stanza, come la famiglia di Ekhlas, che ora non è più a Zaatari, ma ha seguito suo fratello nella capitale, lasciando la protezione del campo.
Bayt prosegue poi con un secondo film girato in Tunisia, di cui è protagonista sempre una donna. Chi è?
Kauther Ayari, la prima attivista a fare un discorso appassionato alla folla all’inizio della rivoluzione tunisina, incitando alla libertà e alla giustizia sociale, sei giorni prima della caduta del dittatore Ben Ali. Il controllo di quanto avveniva a Tunisi era fondamentale per Ben Ali, i moti contro di lui erano già iniziati da alcuni anni, ad esempio nel sud del Paese, nel distretto minerario di Gafsa, con uno sciopero generale che ha coinvolto tutta la popolazione per un periodo di sei mesi nel 2008, ma la capitale era stata sempre protetta con la forza dalle manifestazioni. All’inizio di gennaio 2010 invece la situazione precipita, un gruppo di circa 200 persone si raduna in Place Mohammed Ali, a Tunisi, sotto il palazzo dei sindacati, circondato da un numero impressionante di poliziotti, protestando per la mancanza di lavoro, il rialzo dei prezzi, la corruzione e per l’indifferenza delle autorità allo stato delle cose. Il presidente del sindacato si affaccia e cerca di disperdere la folla, dicendo che il dittatore farà loro delle concessioni purché tornino a casa, altrimenti la manifestazione sarà repressa nel sangue.
A questo punto Kauther Ayari prende la parola e invita tutti a proseguire la lotta, rivolgendosi anche ai poliziotti, dicendo che la causa dei dimostranti è anche la loro, che il pane manca ai figli degli uni e degli altri. È il detonatore della rivoluzione. La folla si sposta in Avenue Bourghiba, s’ingrossa, e pochi giorni dopo il dittatore è costretto a lasciare. Come dice Kauther nel film, tra chi era in piazza in quei giorni non c’erano donne velate né uomini con la barba, era un movimento laico, di sinistra, in cui non erano coinvolti membri dei Fratelli Musulmani. Nei mesi successivi però le cose prendono una piega diversa e Kauther, delusa dal ritorno al potere dei soliti personaggi e dalla deriva religiosa, decide di tornare a casa, di ritirarsi dalla militanza. Oggi ha quattro figli, all’epoca ne aveva solo una, vive nel quartiere più povero di Tunisi ed è stata completamente dimenticata, anche dalla stampa internazionale, che quando vuole parlare dell’inizio della rivoluzione cerca personaggi più politici, in genere uomini, oppure blogger che non sono stati attori della rivoluzione come Kauther, ma che sono stati in grado di gestire la propria immagine attraverso i social media.
I suoni che fanno da sottofondo al racconto di Kauther sulla sua vita e sui giorni della rivoluzione sono suoni domestici. Per lei la bayt ha il sapore amaro della rinuncia, del fallimento di una grande speranza, del cambiamento imposto di uno stile di vita che non escludeva la famiglia ma la comprendeva in un contesto molto progressista, condiviso con il marito, in cui l’impegno e la casa erano per lei la stessa cosa. Ora la casa è invece un luogo dove è confinata, parlarne diventa un modo per parlare della condizione della donna nel mondo arabo, complicata anche in un Paese come la Tunisia, dove un processo di democratizzazione si sta comunque, faticosamente, compiendo.
E il terzo episodio della trilogia a cosa sarà dedicato?
Il progetto della trilogia è parzialmente cambiato da quando l’ho concepito nel 2012, così com’è cambiata la situazione in Medio Oriente. Fortunatamente il production grant che lo finanzia, ricevuto dalla Sharjah Art Foundation, mi lascia molto libero di modificarlo. Inizialmente il lavoro doveva essere girato in un campo profughi siriano, in Tunisia e in Egitto, ma il momento di totale restaurazione militare che quest’ultimo Paese sta attraversando me l’ha fatto sentire distante, non in linea con la mia ricerca.
Adesso la terza parte conto di girarla in Libano, nel campo di Mar Elias, che accoglie profughi palestinesi dal 1952 oltre che un gran numero di profughi siriani dopo la recente crisi. È da un anno che sto lavorando per stabilire i contatti necessari. Nel mentre le cose sono precipitate anche in Libano e dovrò capire cosa è possibile fare. La scelta di Mar Elias non era strettamente legata a rappresentare la situazione libanese, bensì al sorgere di una possibile “primavera palestinese”, raccontando così un popolo che amo e che conosco bene.
Come mai scegli quasi sempre delle donne come protagoniste dei tuoi lavori?
C’è senz’altro un aspetto autobiografico, essendo stato cresciuto principalmente da tre cugine, il che mi ha avvicinato molto alla psicologia femminile, con cui riesco più facilmente a entrare in contatto. Poi credo che in una società neoliberale e capitalista quale quella in cui viviamo, e non solamente in Medio Oriente, gli uomini siano molto legati al mondo del lavoro, all’economia, al profitto, mentre le donne, al di là della cura della famiglia, lascino più spazio per la cultura, per l’impegno civico, proprio gli aspetti che m’interessa maggiormente approfondire quando cerco di avvicinare e conoscere un ambito che non è il mio. Se si pensa ad esempio al movimento di Gezi Park in Turchia, la componente femminile è stata maggioritaria.
Conosci molto bene il mondo islamico mediorientale, cosa ti ha spinto ad avvicinartici e a studiarlo?
Da un lato una vicenda personale, dall’altro incontri fortunati che mi hanno dato una chiave d’accesso a un contesto che avevo il desiderio di comprendere meglio. Durante la guerra in Bosnia sono stato là più volte come volontario, dal 1993 all’inizio del ’96. Avevo studiato psicologia, poi fotografia ad Arles, ma non avevo ancora perfettamente chiare le scelte della mia vita. Andare in Bosnia era un modo per impegnarmi, ma senza volermi dedicare al volontariato in pianta stabile. Mi sono appoggiato a un’associazione, Sprofondo a Como, coinvolta in progetti di aiuto a Sarajevo. Con loro sono stato in Bosnia le prime volte, poi ho continuato ad andare da solo, impegnandomi soprattutto con i paraplegici all’ospedale Koševo di Sarajevo.
Proprio a Sarajevo ho conosciuto questa cultura “altra” che per me era la cultura islamica, essendo ospite in casa di persone con cui ho scoperto i modi e il senso della preghiera, le loro abitudini – ad esempio vivendo con loro durante il Ramadan – e iniziando così a capire differenze che oggi credo sia essenziale conoscere in una società multiculturale. Si tende, infatti, ad assimilare rifugiati, islamici, fondamentalisti, terroristi come se fossero la stessa cosa, dimenticando che ci sono rifugiati perché c’è il terrorismo e non viceversa. L’Islam mi è apparso come il nuovo “altro” nella nostra società e attraverso l’arte ho cercato di parlarne. Ecco com’è nato l’interesse per questo mondo, perché era un mondo completamente diverso dal mio.
Il primo progetto che ho realizzato in Medio Oriente è stato Il dono, nel 2001, in seguito a una residenza avuta in Israele, un modo per mettere in dialogo, attraverso lo scambio di doni e la condivisione del cibo e attraverso le storie personali, un gruppo di settantaquattro ebrei e palestinesi, da me riuniti in due eventi conviviali. In quell’occasione ho collaborato con Yona Fischer e Jack Persekian che sono state le persone che mi hanno introdotto alla storia e alla cultura ebraica e palestinese. La Palestina, come ho detto, è diventata poi un Paese molto importante per me, come in seguito anche la Turchia.
Infatti, tra tanti Paesi dell’area che hai conosciuto per realizzare i tuoi progetti – Israele, Giordania, Tunisia, l’emirato di Sharjah – insieme alla Palestina, la Turchia è sicuramente quello con cui hai una relazione più profonda e duratura. Là hai realizzato alcuni tra i tuoi lavori più significativi, come Murat e Ismail, la storia del passaggio generazionale tra due uomini, un padre e un figlio, piccoli artigiani a Istanbul, e Kazın Ayağı (Lucciole per lanterne), che utilizza la tecnica del teatro delle ombre turco per parlare di un tema molto attuale come la gentrificazione e la spinta ai margini della società di Rom e Curdi, nonchè le due serie fotografiche e il film The Outsider che presenti al Maxxi nella mostra Istanbul: passione gioia e furore, dove sei l‘unico artista italiano a esporre. Ti è stato facile entrare in relazione con una realtà così complessa e contraddittoria come quella turca di questi ultimi anni?
Prima di essere invitato da Charles Esche e Vasif Kortun alla Biennale nel 2005, ero stato a Istanbul solo come turista. Non ero mai stato a Beyoglu, ad esempio! E non avevo percepito la ricchezza della cultura turca, devo dire. Quando sono tornato nel 2005, ho avuto la fortuna di incontrare persone che mi hanno guidato, preso per mano, aiutato a capire la Turchia, la sua varietà, la sua storia, la sua multiculturalità. Il mio stesso progetto, cioè l’idea di raccontare il cambiamento sociale in atto in Turchia attraverso la storia di due uomini, un padre e un figlio, ciabattini, mi ha posto dei doveri rispetto all’entrare veramente in contatto con la realtà locale, altrimenti il mio lavoro sarebbe stato superficiale, il mio sguardo documentaristico, troppo esterno. Ho cercato di capire cosa voglia dire essere turco, ho compreso le caratteristiche di un popolo molto diverso, mi verrebbe da dire complementare, rispetto a quello italiano.
Da quel momento in poi ho cercato di vivere molto in Turchia, di non avere troppi mediatori o meglio di averne ma molto diversi tra loro, con approcci differenti. Di questi ultimi dieci anni ne ho trascorsi quasi tre là e credo di essere riuscito non dico a essere un insider, perché credo non lo si diventi mai, ma a ridurre la distanza che il mio essere straniero pone tra me e la gente. Il gap rimane, e per fortuna, perché ti lascia sempre la curiosità e il desiderio di colmarlo, di capire di più.
I tuoi lavori presentano frammenti di storie molto personali, racconti intimi che non aspirano a una narrazione compiuta ma piuttosto a offrire un momento di empatia tra il pubblico e i tuoi personaggi e l’occasione per permettere loro di autorappresentarsi anche se sempre attraverso il filtro del tuo sguardo. Prima hai detto di non voler limitarti a “documentare”. Qual è il ruolo della realtà nel tuo lavoro?
Penso che il ruolo dell’artista in un periodo di crisi culturale e sociale non sia più quello di prefigurare il futuro e neppure di crogiolarsi in una ricerca puramente estetica, ma sia un ruolo d’interpretazione, di lettura del presente, di prospettiva direi, che sicuramente ha nell’idea di “documentare” uno stimolo importante. Non nel senso di riportare la realtà (questo lo fanno già i media, spesso molto male, sollecitando il voyeurismo di un’audience benpensante e radicata alle proprie certezze) ma di decostruirla, di renderla incoerente, e di ristrutturarla infine per vedere che effetto fa e se questo aiuta a capire i suoi elementi nascosti o meno evidenti. È un lavoro di ricerca visiva, anche estetica certamente, ma con una carica di responsabilità sociale, d’impegno, perché penso che non sia tollerabile che un artista viva distante dal mondo, senza curarsi di affacciarsi al presente, di contribuire, anche semanticamente, al cambiamento.
Se parliamo di linguaggi filmici, non credo che il mio lavoro possa essere considerato documentario in senso stretto, e lo dico senza alcun pregiudizio per il documentario. Certamente filmo il reale e non creo situazioni di fiction, ma il reale per me è un punto di partenza per creare nuove narrative che certamente riflettano la storia dei miei protagonisti ma che anche assumano un valore simbolico non necessariamente confinato agli eventi della loro vita. Amo il reale, perché è molto più ricco di qualsiasi struttura narrativa che io possa creare a priori, offre infinite sfaccettature da analizzare e leggere, crea una contemporaneità che sfugge all’essere solo “contemporaneo” ma che cerca di assumere un valore universale. Che ci riesca o no, non spetta a me dirlo. Certamente la storia che costruisco diviene anche autobiografica, perché, volente o nolente, rispecchia me e le mie passioni e curiosità.
Parlavi di ricerca visiva ed estetica che nel tuo lavoro è bilanciata con la responsabilità sociale. Tu vieni da una formazione di fotografo e nel taglio delle tue inquadrature, nel modo in cui le componi si sente sempre la conoscenza della grammatica dell’immagine. Qual è la funzione degli aspetti formali nel tuo lavoro?
Si dice che s’imparino le nozioni per poi buttarsele dietro, per me è molto vero, mentre filmo non cerco di teorizzare troppo, è tutto molto immediato. Chiaramente la mia formazione emerge inconsciamente nel filmare, ma non mi pongo teoricamente il problema di che taglio dare all’inquadratura, di come costruire l’immagine. Mi pongo il problema di quello che voglio dire, di quello che voglio scoprire io stesso e comunicare allo spettatore e di come andare all’interno delle cose, senza rimanere in superficie. Le scelte estetiche, più strettamente semantiche e di costruzione narrativa, emergono molto più nettamente nel momento del montaggio e della postproduzione: non che m’interessino gli effetti formali come tali, ma curo comunque con grande attenzione il significato visivo di ogni immagine che produco.
Cosa ti spinge a raccontare soprattutto storie di persone che provengono da mondi lontani da quello da cui provieni, tu italiano trasferito a Berlino? Penso anche ai tuoi primi lavori, realizzati nei Paesi nordici e comunque alla tua propensione e capacità di stabilire un rapporto profondo e intimo con dei perfetti sconosciuti, piuttosto che rivolgere la tua attenzione e la tua telecamera a quanto conosci meglio e ti è più prossimo.
Lo stimolo da cui parte il mio lavoro è proprio il desiderio di comprendere delle situazioni che non conosco, di riuscire a penetrare un contesto che non è il mio. La curiosità è la mia molla più potente. La condizione di estraneità da cui parto quando inizio un progetto mi spinge a immergermi nella nuova realtà senza preconcetti. Persino non conoscere la lingua è un vantaggio in certi casi. Quando filmo, infatti, e capisco cosa dicono le persone che sto riprendendo, diventa naturale focalizzare la mia attenzione sul significato, mentre il fatto di non comprendere mi porta a concentrarmi sul linguaggio del corpo, sulle relazioni umane, sulle sfumature psicologiche. Mi meraviglio anch’io talvolta di come mi capiti di giungere a focalizzare la mia attenzione su momenti importanti e significativi dell’azione in modo del tutto istintivo. Sono convinto che se fossi attento solo al linguaggio verbale, forse sarei portato a trascurare aspetti che si manifestano come un dono inaspettato e improvviso al mio cercare di avvicinarmi ai miei soggetti, di capire ciò che è tra le righe, non solo il linguaggio delle parole, ma anche quello delle emozioni, della psicologia.
Un grande documentarista brasiliano, Eduardo Coutinho, che mi ha sempre molto sostenuto, diceva che so fare film interessanti solo quando non conosco la lingua dei miei personaggi. Lavorare su qualcosa che conosco, che vivo ogni giorno, mi spaventa molto per la paura di non avere la stessa curiosità di capire, di cercare di entrare in contatto con l’essenza profonda dei fatti che voglio raccontare, per il rischio che avere un’opinione chiara su ciò che filmo possa rendermi miope a storie e situazioni diverse dal mio sentire. E questo significa perdere due aspetti importanti del lavoro di un artista: l’universalità e l’impegno non “politico”, non partigiano.
Giri sempre con una sola telecamera?
Sì, talvolta, anzi abbastanza spesso, con un microfono esterno, ma sempre con una camera sola, che uso personalmente.
Temi e soggetti dei tuoi lavori sembrano essere ogni giorno più attuali. Pensi che l’arte sia in grado di produrre un cambiamento nel modo in cui le persone guardano alla realtà? Tuoi lavori come Il dono mi fanno pensare che tu possa avere una dose di ottimismo in questo senso.
Assolutamente sì, diciamo che non penso che potrei fare il tipo di lavoro che faccio se non credessi nella capacità dell’arte di entrare nelle menti, di creare un’esigenza di cambiamento, di crescita, di attenzione all’altro. Chiaramente sono cosciente che il mondo dell’arte si rivolge a un’élite ma molto spesso, e questo l’ho capito ancora di più in questi giorni lavorando sulle idee di cambiamento nate a Gezi Park, quello che avviene in una parte ben definita della società, anche se si tratta di un gruppo minoritario, s’insinua e cresce, crea delle domande e delle reazioni, una sensibilità che man mano si espande.
Essere artista non vuol dire per me pensare di raggiungere tutti, ma sapere che posso creare consapevolezza e coscienza critica in qualcuno e attivare così un processo che potrà raggiungere altre persone e arrivare a modificare la realtà. Non riuscirei a fare nulla nel mio lavoro se non pensassi questo, forse è molto idealista, forse è molto ottimista, ma credo che l’arte possa arrivare a modificare il modo di pensare della gente, possa contribuire a cambiare il nostro sguardo sul mondo e che questo abbia un potenziale rivoluzionario.
Cristiana Perrella
Roma // fino al 30 gennaio 2016
Mario Rizzi – Al Intithar. L’Attesa
a cura di Cristiana Perrella
STUDIO STEFANIA MISCETTI
Via delle Mantellate 14
06 68805880
[email protected]
www.studiostefaniamiscetti.com
MORE INFO:
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/50276/mario-rizzi-al-intithar-lattesa/
 1 / 7
1 / 7
 2 / 7
2 / 7
 3 / 7
3 / 7
 4 / 7
4 / 7
 5 / 7
5 / 7
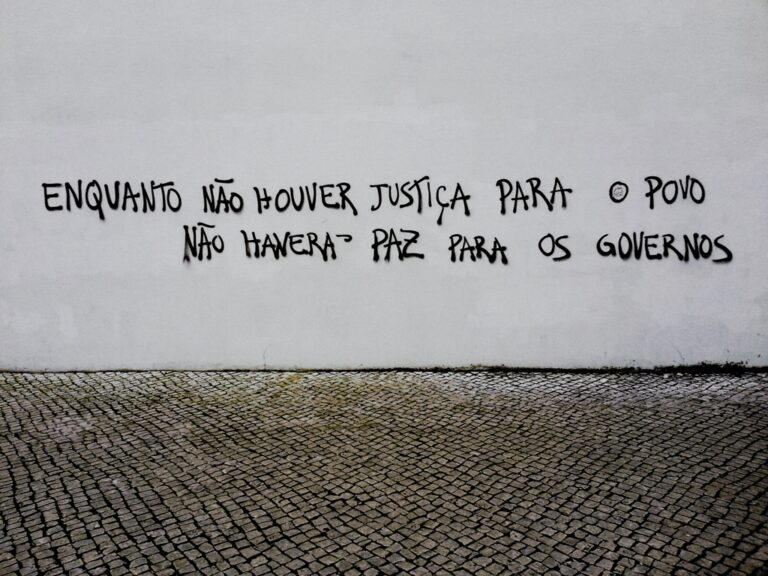 6 / 7
6 / 7
 7 / 7
7 / 7
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati