Fase Tre (VII). Imprevisti e responsabilità
“La responsabilità dell’opera significa principalmente non rinunciare alla propria verità, a favore dell’immagine che essa – e il suo autore – proiettano verso l’esterno”. Christian Caliandro torna a parlare di Fase Tre.

L’opera d’arte nuova non appartiene, letteralmente, al proprio tempo – ma a un altro, ipotetico tempo/futuro/domani, a un presente-futuro che potrebbe anche non realizzarsi (mai), ma a cui l’opera deve essere agganciata, da cui deve sbocciare e in cui deve fiorire. L’opera ipotizza, a partire da se stessa, un’epoca, delle condizioni e un’intera cultura che potrebbero anche non verificarsi mai.
“L’evoluzione spirituale è lo scopo della vita umana, della vita dell’uomo sulla terra: l’arte è un mezzo per aiutare l’uomo in questo processo” (Andrej Tarkovsky).
Tutto prevedibile, tutto protetto: è questo che ci blocca, che ci sta bloccando. Questa prevedibilità, questa illusione di protezione (la “sicurezza”). Questo controllo su ogni aspetto della vita individuale e collettiva elimina totalmente il rischio e l’imprevisto, anche dall’orizzonte artistico e culturale.
La realtà dell’arte è compresente, fatta di ripescaggi, buche, cadute, deviazioni, sovrapposizioni, parallelismi.
L’acqua e lo scoglio – l’errore e l’evento – la figura e lo sfondo – la forma e l’informe – l’io e il mondo – il soggetto e il contesto – l’opera e la vita – l’identità e la nonidentità: l’opera occupa sempre la zona intermedia tra questi due territori.
Il difetto principale è la gratificazione immediata, questo bisogno del tutto artificiale nutrito a sua volta da un ottimismo stupido e fasullo, che impedisce di crescere e di capire.
“Poiché, continuavo a ripetermi, un colpevole che non ha più strumenti per riconoscersi tale intacca l’idea stessa di colpa, di responsabilità, dunque di scelta, che cosa bisognava fare per evitare che questi concetti – disgregandosi per un numero crescente di persone – cominciassero a corrompersi anche in chi li reputava fondamentali? A cosa dovevamo guardare?” (Nicola Lagioia, La città dei vivi, Einaudi 2020, p. 410).
Occorre dunque innanzitutto togliere gli strati, a uno a uno (smettere di fingere), e restituire intatta questa contraddizione solo apparente – che è la vita. Niente consolazione, perché la consolazione (: la gratificazione immediata) è in fondo la malattia, il vero contagio di questa epoca.
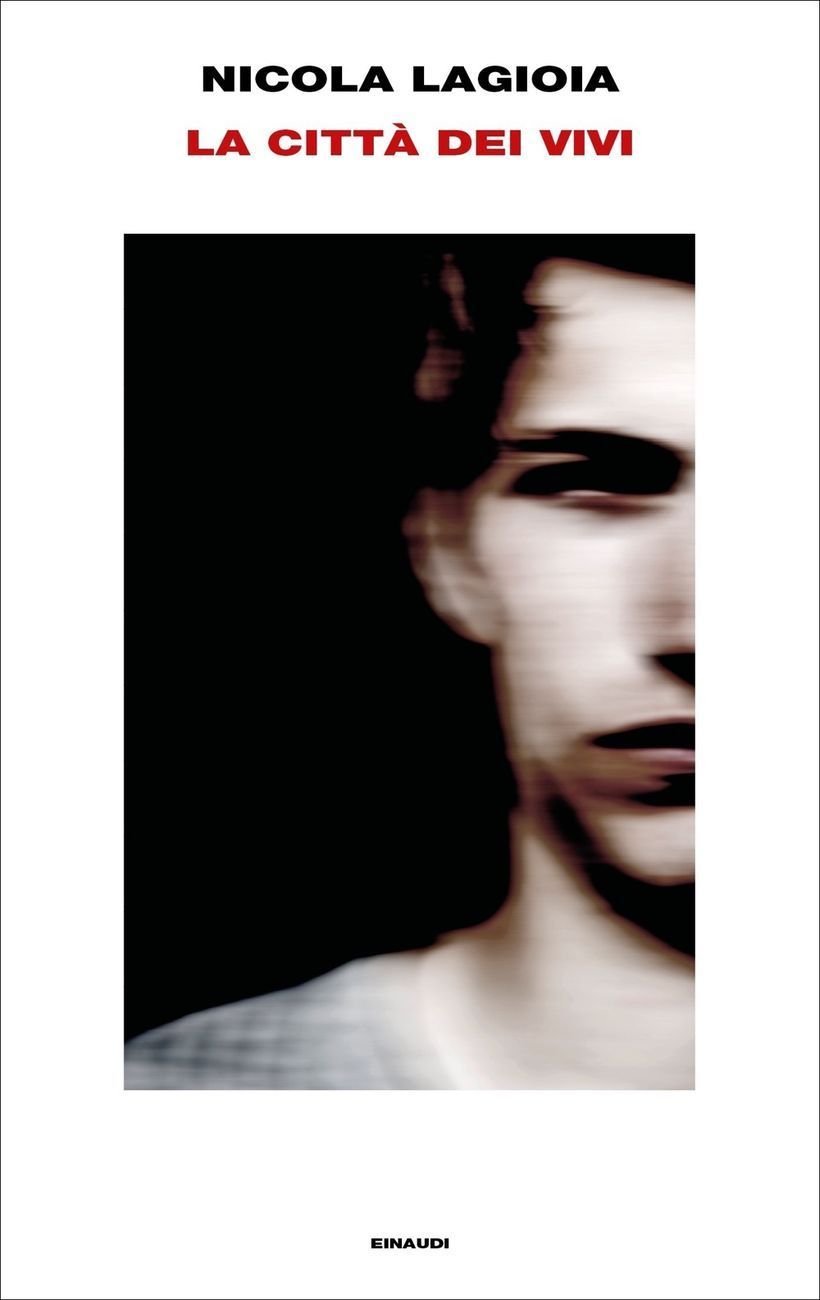
Nicola Lagioia ‒ La città dei vivi (Einaudi, Torino 2020)
Dopo che all’opera sottraiamo tutto, come è di fatto avvenuto in questo periodo e come sta avvenendo in questo periodo (pubblico, mostra, comunicazione, mercato, spazio istituzionale), ciò che rimane e permane è il suo nucleo, il suo centro: e questo centro è la dimensione della responsabilità. La responsabilità dell’opera significa principalmente non rinunciare alla propria verità, a favore dell’immagine che essa – e il suo autore – proiettano verso l’esterno.
In questo conflitto tra verità interna e immagine esterna molte delle opere d’arte degli anni recenti sono probabilmente cadute, implose.
Allora, la sottrazione dolorosa e traumatica di questi dieci mesi ci aiuta forse a vedere e a rivedere ciò che era rimasto nascosto, sommerso dal discorso attorno all’arte, da tutti i livelli e gli strati che la circondano senza lasciarla libera. La storia già scritta, il copione, il format del racconto, la struttura rigida sono le forme della finzione – e della retorica. Il controllo non è attivo solo nella nostra società, ma anche e soprattutto nella cultura. L’opera ha dunque finalmente l’occasione di riflettere la sua verità e quella del suo autore (che è sempre ambigua, contraddittoria, incompleta), abbandonando le pose comode ma finte che governano le narrazioni attraverso cui conosciamo e interpretiamo il mondo.
Di inoltrarsi cioè nella “frantumaglia” di cui parla Elena Ferrante, di essere la frantumaglia: “(…) me la rappresento soprattutto come un ronzio in crescendo e uno sfaldamento a vortice di materia viva e materia morta: uno sciame d’api in avvicinamento oltre le cime immobili degli alberi; il mulinello improvviso di un corso lento d’acqua. Ma è anche la parola adatta a ciò che sono convinta di aver visto da bambina, – o comunque durante quel tempo tutto inventato che da adulti chiamiamo infanzia, – poco prima che la lingua mi entrasse dentro e mi inoculasse un linguaggio: un’esplosione coloratissima di suoni, migliaia e migliaia di farfalle con ali sonore. O è solo un modo mio per dire l’angoscia di morte, il terrore che la capacità di esprimermi si inceppi come per una paralisi degli organi fonatori e tutto quello che ho imparato a governare dal primo anno di vita a oggi fluttui per conto suo, gocciolando via o sibilando da un corpo sempre più cosa, una sacca di cuoio che perde aria e liquidi” (Elena Ferrante, La frantumaglia, edizioni e/o 2016, p. 95).
‒ Christian Caliandro
ACQUISTA QUI il libro di Nicola Lagioia
ACQUISTA QUI il libro di Elena Ferrante
LE PUNTATE PRECEDENTI
Fase Tre (I). L’opera e la realtà
Fase Tre (II). Essere l’altro
Fase Tre (III). La paura e gli interstizi
Fase Tre (IV). Crisi e rinascita
Fase Tre (V). Ricordi e postapocalisse
Fase Tre (VI). Che cosa rimane
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





