Raccontare l’Africa. Intervista ad Adelina von Fürstenberg
Che cosa vedremo alla mostra “AFRICA. Raccontare un mondo” al PAC di Milano? Ecco le anticipazioni nella nostra intervista alla curatrice Adelina von Fürstenberg.

L’Africa è un Paese devastato da guerre sanguinarie, genocidi, omofobia, corruzione politica, tratta di uomini e donne, da Stati in cui pochi potenti detengono il potere e l’economia. Una terra ricca di risorse, tra cui il petrolio, ma di cui la maggior parte della popolazione non usufruisce, anzi muore nella povertà. Ma l’Africa è da secoli anche un Paese ricco di cultura e tradizioni. Ed è intorno alla ricchezza culturale del continente, alla sua fierezza che ruota la mostra AFRICA. Raccontare un mondo, curata da Adelina von Fürstenberg al PAC di Milano, che abbiamo incontrato durante l’allestimento.
Uno sguardo positivo rivolto a un Paese dalle grandi potenzialità creative. Per la mostra, Adelina von Fürstenberg è affiancata da Ginevra Bria che ha curato la sezione video e le performance delle giovani artiste Donna Kukama, Buhlebezwe Siwani e Anne Historical. Inoltre ha seguito l’installazione site specific pensata per lo spazio dell’Edicola Radetzky in Darsena a Milano.
Comincerei da lontano: dalla mostra Magiciens de la Terre, ospitata al Centre Pompidou di Parigi nel 1989 e curata da Jean-Hubert Martin.
Ero all’inaugurazione della mostra. È stata per me una rivelazione incredibile perché tutto a un tratto ho capito che il mondo era enorme. A quel tempo non eravamo ancora in piena globalizzazione. Ma prima di quella mostra c’è n’è stata un’altra che mi ha aperto gli occhi: la documenta 5 di Harald Szeemann. Ero una studentessa e ho capito in quel momento che l’arte faceva parte del mondo. Magiciens de la Terre mi ha invece insegnato che il mondo è arte. Nel 1995 sono stata invitata a preparare il 50esimo delle Nazioni Unite e lì ho cominciato a lavorare con artisti africani.
Il titolo della mostra è Africa. Raccontare un mondo. Da dove sei partita per raccontare il mondo africano?
Prima di tutto sono partita da questi personaggi africani che si chiamano Griot. Sono i famosi cantastorie. Una grande tradizione familiare che si tramanda di padre in figlio. Questi personaggi sono invitati ai matrimoni, ai funerali dove raccontano e trasmettono ai presenti l’evento che loro stessi stanno vivendo. AFRICA. Raccontare un mondo è come se noi e gli artisti fossimo dei Griot che raccontano il mondo.

Romuald Hazoumé, Bagdad City, 1992. Courtesy CAAC-The Pigozzi Collection, Ginevra
In passato ti sei cimentata nella ricognizione dell’arte in Paesi altrettanto complessi. Ricordo la tua mostra dieci anni fa all’HangarBicocca di Milano dal titolo Urban Manners che indagava l’arte indiana contemporanea.
La parola indagare è corretta perché facendo questo tipo di mostre prima di tutto sei tu in prima persona a imparare. È un insegnamento. Devi entrare nella loro cultura, capire, fino a immedesimarti. È importante creare un rapporto che ti permette di fare mostre che non sono legate a una pura estetica, ma al contenuto profondo di queste diverse culture.
Questa volta ti sei focalizzata sull’Africa, in particolare quella subsahariana. Perché meno indagata?
Quando ho fatto la mia prima mostra africana ho lavorato con artisti dell’Africa del Nord. Qui è stata una scelta precisa lavorare con artisti dell’Africa a Sud del Sahara.
Hai individuato quattro sezioni: Dopo l’Indipendenza, l’Introspezione Identitaria, la Generazione Africa e il Corpo e le Politiche della Distanza. Ce ne vuoi parlare dandoci un paio di esempi di artisti che rientrano in quelle macro aree?
Queste sezioni sono state individuate per dare un’indicazione al pubblico. Nella mostra non c’è un’indicazione precisa di ogni singola sezione. Ci sono però dei fili che uniscono gli uni agli altri. Per esempio artisti come Seydou Keïta o Frédéric Bruly Bouabré hanno iniziato a lavorare come fotografi. Sono stati poi scoperti come artisti. Keita addirittura faceva un solo click perché non aveva mezzi per fare più scatti. Oppure Romuald Hazoumé o Georges Adeagbo che invece hanno studiato all’estero e poi son tornati indietro. Loro sono molto impegnati sulle problematiche sociali e politiche dell’Africa.

Billie Zangewa, The rebirth of the black venus, 2010. Courtesy private collection
L’Africa oggi viene “colorata”, sui media occidentali, come un territorio di tendenza. La verità però è che l’Africa ancora oggi è un Paese devastato da guerre sanguinarie, genocidi, omofobia, corruzione politica, tratta di uomini e donne, da Stati in cui poche figure potenti detengono il potere e l’economia, una terra ricca di risorse, tra cui il petrolio, ma di cui la maggior parte della popolazione non usufruisce. Anzi muore nella povertà.
Tutto ciò che dici è vero. Ma l’Africa non è soltanto questo. Un’analisi dell’Economist notava come, qualche anno fa, sei fra le dieci economie più dinamiche al mondo si trovavano nell’Africa subsahariana. L’economia africana è fiorente e gran parte dei Paesi sono in pace. L’Africa è cultura, arte, musica. Rappresenta la fierezza delle diverse comunità e dei Paesi di questo grande continente. Gli artisti africani parlano dell’Africa, delle belle cose e di quelle brutte. L’Africa non è solo miseria: è una ricchezza straordinaria. Gli africani riescono ad andare oltre al post-colonialismo, crescono. La miseria, la corruzione o l’omofobia sono anche da noi. Ormai l’Africa sta raggiungendo il mondo. La cosa più interessante in Africa è il continente perché gli africani si sentono africani, non ghanesi o senegalesi… Vengono da diversi Paesi ma quei territori sono stati divisi dagli occidentali. Nel continente nero si parlano oltre 1300 lingue, e fra queste lo swahili, lo hausa, lo yoruba, lo shabo, l’arabo bantù ma loro si sentono unificati. Attraverso la loro cultura, parlano del loro continente.
Un altro aspetto importante è la coabitazione, spesso travagliata, di più religioni.
Assolutamente sì. Questo è un punto molto interessante. L’Africa ha avuto le sue religioni, ad esempio quella animista. Poi sono arrivate le influenze asiatiche, indiane, arabe, europee… le chiese cristiane. Per loro è importante il culto degli antenati. Non bisogna poi dimenticare che dall’Africa sono arrivati fino a noi ritmi, spezie e diversi prodotti, ma soprattutto la migrazione forzata, frutto della schiavitù. Milioni di uomini e donne hanno costituito la base dello sviluppo agricolo e industriale del nuovo continente. Le ricche industrie occidentali che commerciano in zucchero, tabacco, caffè, cacao e molti altri prodotti sarebbero impensabili senza la manodopera africana. O la musica: pensiamo al blues, jazz e rock‘n’roll negli Stati Uniti, il samba in Brasile, il mambo e il guaguancó a Cuba, il merengue nella Repubblica Dominicana…

Barthélémy Toguo, Road to Exile, 2015. Courtesy l’artista e Galleria Lelong, Parigi
Al PAC saranno anche dislocate alcune sedute realizzate da designer africani contemporanei.
Il design è molto importante e le sedute sono parte della cultura africana. Ad esempio quelle del capo tribù. La moda è altrettanto importante: il fare, i tessuti, i gioielli. In mostra ci sono artisti che hanno portato lavori con ricami. Le donne e gli uomini africani sono sempre molto attenti a come si vestono, con le loro stoffe, i loro colori.
Il mercato dell’arte si è da tempo “buttato” sull’arte contemporanea africana. Che cosa resterà quindi come eredità dell’arte africana di oggi o, sarebbe più opportuno, dell’arte africana filtrata dal sistema del mercato occidentale?
È una situazione globale che abbraccia altri Paesi, come ad esempio la Cina. È dalla mostra Magiciens de la Terre che il mercato ha cominciato a interessarsi all’arte africana contemporanea. Il primo grande collezionista di arte africana è stato Jean Pigozzi, che ha sistematicamente comprato, con il consiglio di Andre Magnin, artisti africani straordinari. Alcuni lavori di questi artisti sono in mostra. Dopo di lui altri occidentali hanno cominciato a collezionare arte africana, ma sempre per loro stessi, per il loro piacere. Poi è cominciata una nuova tendenza con la fiera 1:54 Contemporary African Art Fair a Londra (e a New York) iniziata quattro anni fa e il mercato si è sviluppato enormemente. La Tate di Londra ha creato una sezione dedicata all’Arte africana con collezionisti africani, non più solo occidentali. Quelli con cui ho lavorato non sono mai stati interessati alla speculazione del mercato. Hanno rapporti con gli artisti, li seguono. Fare mostre sull’arte africana oggi da parte delle istituzioni è molto importante per portare a un pubblico vasto, e non di specialisti, che l’Africa non è solo miseria e dolore, ma conoscenza, cultura. L’Arte africana più si vede e meglio è. L’oggetto rituale non è solo feticcio, come è stato interpretato dagli occidentali: è arte.

Adelina von Fürstenberg. Photo Egon von Fürstenberg
A fine luglio inauguri la prima Triennale di arte contemporanea in Armenia che hai intitolato STANDART. Le opere saranno dislocate in luoghi storici e in istituzioni culturali lungo tutta l’Armenia: Yerevan, Byurakan, Gyumri, Erebuni, Sevan e Kapan. Ci puoi anticipare su cosa verterà?
L’idea è nata col Padiglione dell’Armenia alla Biennale di Venezia [che ha vinto il Leone d’oro come miglior padiglione dell’edizione 2015, N. d. R.]. Pur essendo di origini armene, non ero molto familiare con la mia cultura. Sono andata diverse volte in Armenia e sono stata invitata a ideare questa mostra. Mi sono ispirata al libro Il Monte Analogo di René Daumal perché in Armenia c’è questa montagna sublime che si chiama Ararat. La montagna – la leggenda narra –dell’Arca di Noè è di una spiritualità incredibile ma non è in Armenia. È inaccessibile, è dall’altra parte, in Turchia. Nel libro di Daumal le persone cercano di raggiungere il Monte analogo, soltanto che lo scrittore muore all’inizio del viaggio e non arriva a descrivere il seguito della scalata a quel monte simbolico. Non si ha quindi accesso al monte. Allora ti rimane la tua immaginazione che ti aiuta a capire qual è il tuo monte analogo. Qual è il mio monte Ararat? Per questo ho invitato un gruppo di artisti a venire con me a fare questo viaggio e altri artisti del luogo. È una maniera di vedere l’Armenia non soltanto attraverso le tragedie, ma anche attraverso la sua storia. Una storia molto antica.
– Daniele Perra
 1 / 9
1 / 9
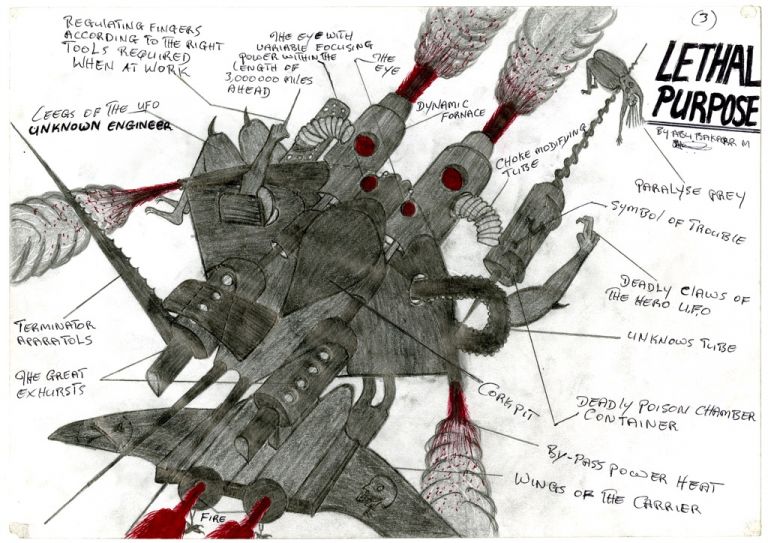 2 / 9
2 / 9
 3 / 9
3 / 9
 4 / 9
4 / 9
 5 / 9
5 / 9
 6 / 9
6 / 9
 7 / 9
7 / 9
 8 / 9
8 / 9
 9 / 9
9 / 9
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati














