In her own words. Il talk di Marina Abramović a Firenze
L’incontro sold out a Firenze con Marina Abramović di fronte a una platea in standing ovation, poche ore prima dell’aggressione a Palazzo Strozzi. Si è parlato di arte, amore, morte e… di chicchi di riso.

“Chi è il più giovane in sala? 15 anni? 12? 10 anni …10 wow, benvenuto a questa lecture”, scherza Marina Abramović di fronte alla platea gremita del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino radunata per questo incontro già sold out dopo pochissimi giorni dal suo annuncio.
Capelli raccolti nella sua inconfondibile treccia corvina, pantaloni neri e camicia stampata, Marina conversa senza alcuna distanza per quasi due ore con il pubblico, accompagnata da Arturo Galansino, curatore di The Cleaner, la grande retrospettiva inaugurata pochi giorni fa a Palazzo Strozzi, che ripercorre più di cinquant’anni di lavoro e di vita della “regina” della performance.
Dalle prime sperimentazioni degli Anni Settanta, realizzate in coppia con Ulay, ai progetti teatrali futuri che la vedranno on stage con Willem Dafoe nel 2020 ‒ “che per me è praticamente domani”, scherza l’artista. Marina parla non senza ironia e leggerezza dei temi cardine della sua esperienza di arte e di vita: la consapevolezza della morte, il superamento del dolore, la ricerca di una connessione profonda con se stessi e con il mondo, la necessità di guardare la realtà da una prospettiva più ampia, che abbraccia noi stessi, la storia e l’universo intero, per un’arte che mira a “elevare lo spirito umano”.
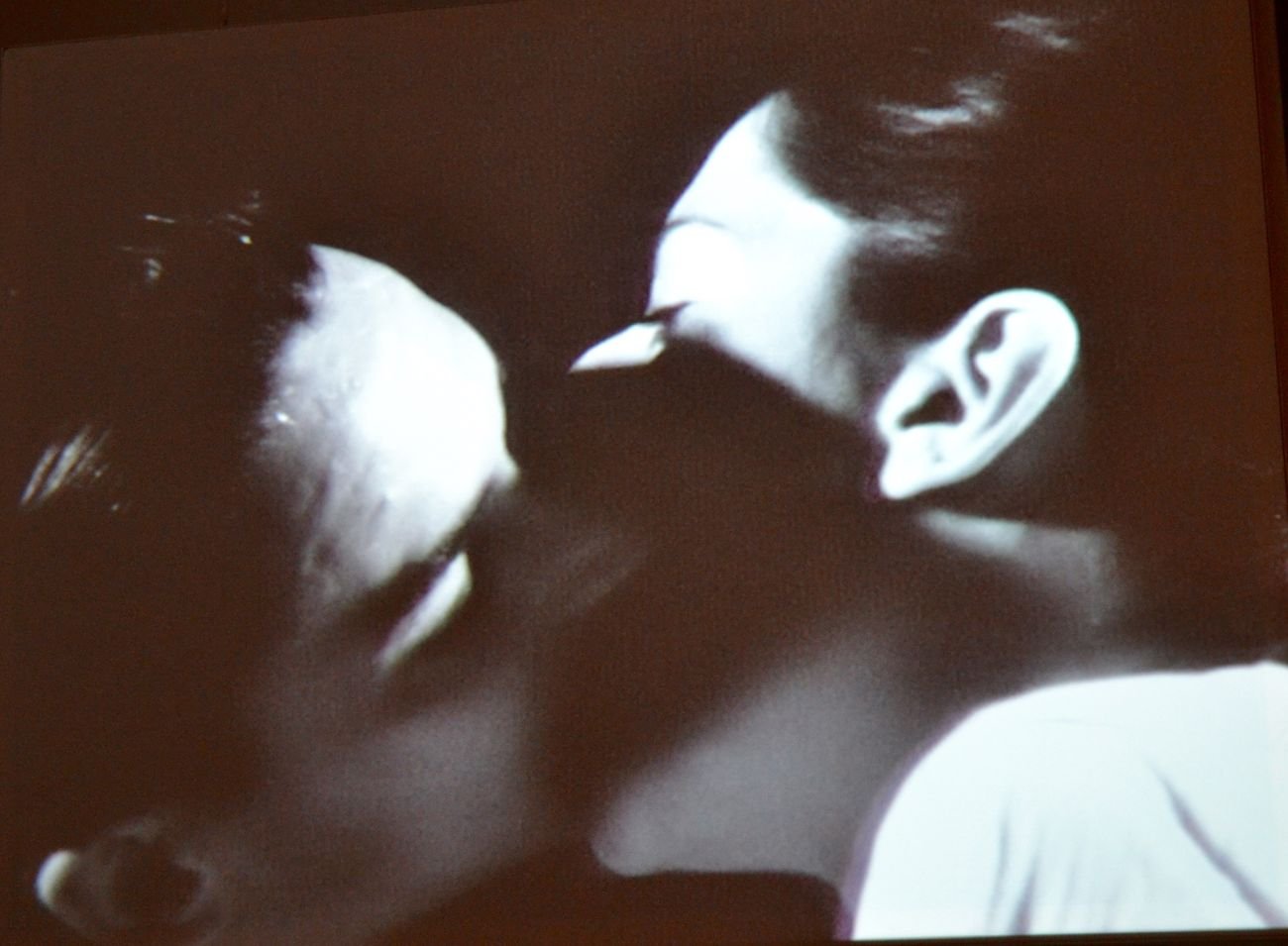
Marina Abramović & Ulay, Breathing in – breathing out, 1977-78, still da video
TRA IERI E OGGI
“We’re all on the same boat”, invoca Marina, aspirando a un’arte universale e per tutti ‒ e scroscia spontaneo un applauso fragoroso nel parterre: il riferimento è all’ultimo lavoro italiano della Abramović, il manifesto commissionatole per la storica regata triestina della Barcolana, che in estate ha di nuovo richiamato su di lei censura e polemiche. Un’artista scomoda, provocatoria, che riesce ancora a non sbagliare un colpo dopo mezzo secolo di carriera, mostrando da sempre senza paura quello che dà più fastidio vedere.
“Non credo che l’arte possa cambiare il mondo”, dice Marina, ma può renderci consapevoli, cambiare noi stessi ed è questo il senso ultimo di ogni lavoro, perché “il pubblico è il mio specchio, il pubblico è il mio lavoro”.
Marina racconta dei primi anni con Ulay, quando non c’erano soldi e insieme vivevano nomadi ‒ “non ci sono mai stati soldi per la performance, non sono certo Jeff Koons” ‒ parla delle nostre paure ‒ “in definitiva abbiamo tutti paura di tre cose, della sofferenza, del dolore e della morte” ‒ e dell’esigenza di ristabilire un contatto profondo con se stessi, che l’ha portata a concepire e diffondere le sue esperienze attraverso un sistema di pratiche possibili a tutti, quello che oggi è l’“Abramović method”. Perché tutti possiamo iniziare, da subito.
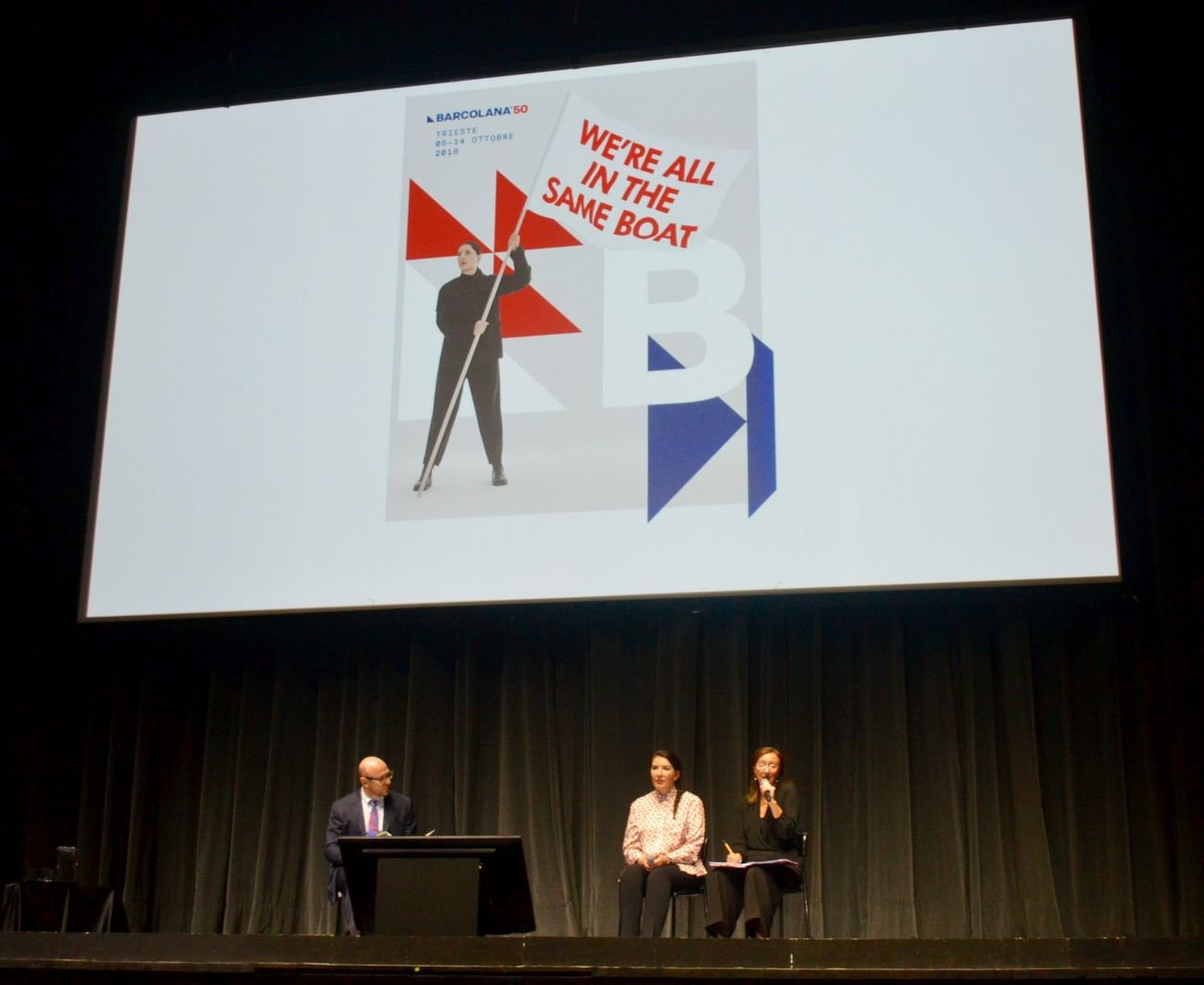
Talk di Marina Abramović a Firenze, 2018. Su We’re all in the same boat
IF YOU CAN’T COUNT RICE…
La conversazione scorre veloce, tra le risate e gli applausi, ci si dimentica quasi che quella signora dai modi gentili sia forse la più nota star del sistema dell’arte, tanto l’atmosfera è intima, il contatto umanissimo. Anzi, “proviamo ora con un piccolo esercizio” ‒ dice al teatro gremito ‒ “alziamoci in piedi, mettiamo un braccio intorno al nostro vicino e chiudiamo gli occhi, restando così, per tre minuti”.
Nessuno si sottrae, la platea si stringe in un abbraccio totale, ognuno col suo sconosciuto vicino, che per un attimo, nel silenzio di un tempo senza durata, smette di essere sconosciuto e diventa parte di un tutto, in una condivisione reale, intima e nello stesso tempo collettiva, universale.
Quando i tre minuti passano la voce della Abramović ci riporta al nostro presente, “thank you”. Riapriamo gli occhi, sciogliamo il contatto, torniamo chi siamo e quasi dispiace.
Nessuna altra spiegazione, razionalizzazione, parola, ma quella sensazione, che è lì e vale per tutti. La stessa sensazione che forse ha portato nel 2010 al MoMA più di 1400 persone per un solo scambio di sguardi per la performance più lunga della storia dell’arte, The Artist is present. Marina, con una presenza disarmante, riesce ad aprirci uno spiraglio verso la più grandi delle rivoluzioni, quella interiore.
Così semplice? Così semplice. Semplice come guardarsi negli occhi o separare una manciata di riso e lenticchie. Semplice, eppure difficilissimo. “Ma lo dico sempre” ‒ afferma Marina con un sorriso ‒, “if you can’t count rice, you can’t make your life either”, se non puoi contare il riso, non puoi neanche farcela nella vita. Provare per credere.
‒ Emilia Jacobacci
 1 / 13
1 / 13
 2 / 13
2 / 13
 3 / 13
3 / 13
 4 / 13
4 / 13
 5 / 13
5 / 13
 6 / 13
6 / 13
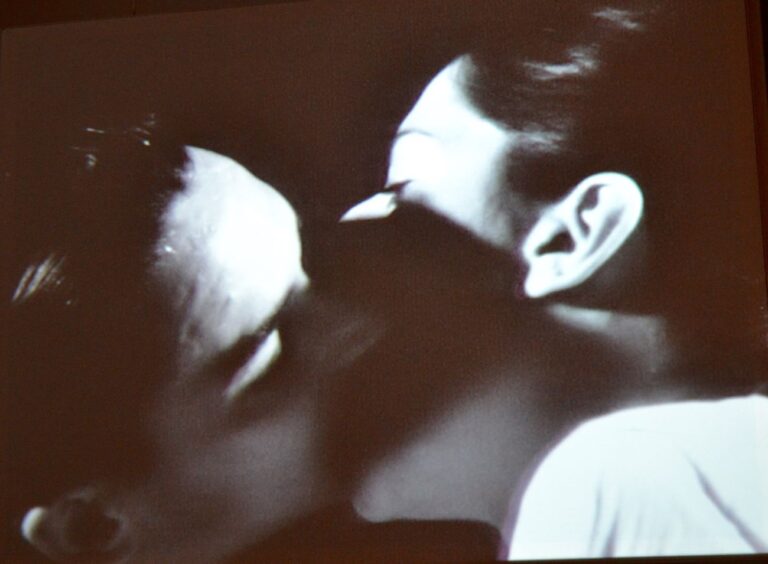 7 / 13
7 / 13
 8 / 13
8 / 13
 9 / 13
9 / 13
 10 / 13
10 / 13
 11 / 13
11 / 13
 12 / 13
12 / 13
 13 / 13
13 / 13
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati


















