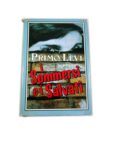A Palermo il collettivo Claire Fontaine apre un ciclo di interventi artistici su democrazie e migrazioni
L’Università di Palermo, con il Dipartimento di Giurisprudenza, porta l’arte contemporanea nei suoi luoghi. Il tema politico, sociale e giuridico delle migrazioni incontra le riflessioni di sei importanti artisti contemporanei nell’arco di tre anni

È un omaggio all’ultimo capolavoro di Primo Levi, I sommersi e i salvati, l’installazione di Claire Fontaine presentata a Palermo lo scorso 26 marzo. Una scritta a neon che segue il loro abituale processo creativo: puntando sulla forza evocativa del titolo, l’opera-citazione funziona come nucleo concettuale e freddo oggetto di contemplazione. Un dispositivo che cattura e riconnette memorie collettive, abitando uno spazio pubblico circoscritto, ma aperto al passo e allo sguardo di ciascuno. Installata in una nicchia, in cima alla grande scalinata in marmo grigio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, la scultura ha dato il via al progetto Crossing Borders. Popoli in movimento, curato da Alessandra Borghese e promosso da UniPa: per tre anni, in diversi punti dell’ateneo, troveranno posto le opere di artisti contemporanei, collegate a un programma di incontri sui temi delle migrazioni, delle democrazie, della convivenza tra popoli.

Claire Fontaine, da Auschwitz al dramma delle migrazioni
In apertura del suo libro, pubblicato nel 1986, Levi trovava frequenze prossime e segrete nella Ballata del vecchio marinaio di Samuel Taylor Coleridge. Un verso che divenne epigrafe efficacissima:
“Da allora, a un’ora incerta,
Quell’agonia mi torna;
E finché la mia storia di orrore non sarà detta
Questo cuore brucia in me”.
Opera profonda e indagatrice, I sommersi e i salvati sviscerava temi cruciali, scomodi, dolorosi, congiungendosi all’altro straordinario documento dell’autore, Se questo è un uomo, scritto quarant’anni prima, resoconto dell’esperienza ai confini dell’umano vissuta in quell’inferno chiamato Auschwitz, dove rimase dal febbraio del 1944 fino al 27 gennaio 1945, quando l’arrivo dell’Armata Rossa segnò la fine all’orrore. Così la scrittura di Coleridge, con la sua potenza icastica, si faceva riflesso, metafora presa in prestito e scintilla al principio del cammino: quel vecchio marinaio dal cuore in fiamme era in fondo qualsiasi uomo in dialogo con le proprie ombre, con le proprie ferite, in cerca di una forma di riscatto che era innanzitutto nel racconto, nel linguaggio. L’affilata lama della parola-pensiero resta dunque strumento per avanzare nel buio, per capire e rimettere ordine, per rivolgersi all’altro e provare a essere comunità.
Claire Fontaine, duo di artisti italo-britannici con base a Palermo, affronta il tema da questa prospettiva universale: il titolo di Levi è icona verbale che qui diventa immagine, riferendosi a ogni uomo oppresso, accolto, graziato o schiacciato dal potere, qualunque pellegrino della storia che abbia vissuto il senso della tragedia, spesso sovrapposto a quello dell’ingiustizia. Un fatto umano e politico. È il reduce dei campi di concentramento, nelle cronache feroci di 70 anni fa, i cui abissi cercano ancora spiegazione, senza la consolazione del cambiamento, senza che il trauma si sia convertito in esempio morale duraturo; ed è il migrante di oggi, in una vicenda scandalosa che fa del Mar Mediterraneo un campo di battaglia, un sepolcro ovattato.
 1 / 8
1 / 8
 2 / 8
2 / 8
 3 / 8
3 / 8
 4 / 8
4 / 8
 5 / 8
5 / 8
 6 / 8
6 / 8
 7 / 8
7 / 8
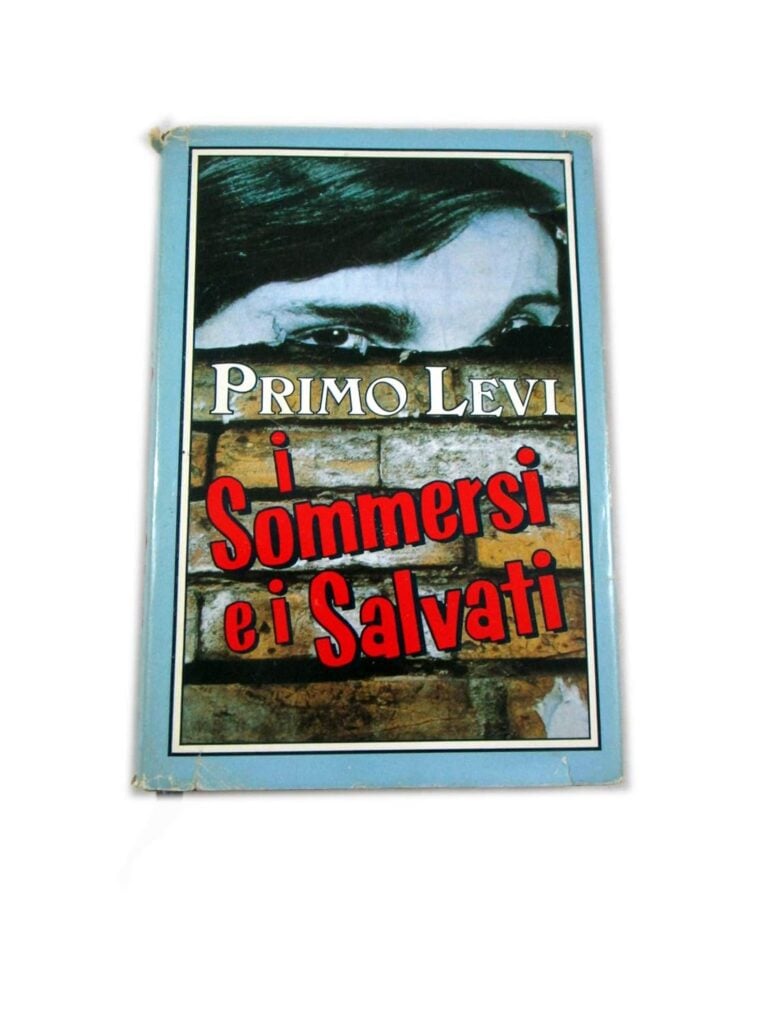 8 / 8
8 / 8
L’impegno sociale di UniPa nel progetto su arte, democrazia e migrazione
“Noi non possiamo e non vogliamo girare le spalle alla verità, e il nostro ruolo, il nostro compito istituzionale, è la trasmissione della memoria della cultura del diritto e della stessa democrazia”, ci spiega il professor Paolo Inglese, delegato del Magnifico Rettore per il coordinamento accademico dell’iniziativa. “Non basta occultare – ha aggiunto – occorre chiarire, fare piazza pulita di ogni possibile ambiguità sulle scelte da compiere, quando si è di fronte a possibili ‘sommersi’ o a chi crea le condizioni perché lo siano. Quest’opera è per noi non solo una condivisione ideale, ma un’attestazione precisa e dirompente di identità. Noi siamo, e non vorremmo essere altrove, con i sommersi e i salvati”. E conclude: “UniPa promuove percorsi di studio dedicati ai corridoi umanitari, oltre a un dottorato e a un Centro di Ateneo dedicato al tema dei diritti e dei Migranti”.
Un impegno che oggi cerca nell’arte l’occasione di una sintesi immediata, provando ad affinare sensibilità, a orientare sguardi, a suggerire simbologie e connessioni. Nell’opera di Claire Fontaine la scelta del colore (dal blu infinito che sommerge e cancella, al rosso del pericolo e del pathos) è tutt’uno con la natura dei segni grafici, secondo un paradigma semiotico: nelle due linee sinuose che incorniciano la frase di Levi sopravvive il ricordo dei binari lungo cui viaggiarono migliaia di prigionieri, diretti verso i campi di concentramento; e così torna alla mente l’inquietante frase “Arbeit macht frei” (Il lavoro rende liberi), posta all’ingresso di Auschiwitz: la scritta in ferro a caratteri cubitali, lasciata al suo posto come monito incancellabile, è racchiusa da lunghe linee ondulate; infine il riferimento è al mare, alle onde che hanno sospinto stuoli di navi e imbarcazioni, accompagnando il libero movimento di uomini e di popoli, talvolta segnandone i destini luttuosi.

Come nasce il progetto Crossing Borders
Sono sei gli artisti selezionati da Alessandra Borghese, scrittrice e organizzatrice culturale, a capo della Fondazione Ghenie Chapels, lanciata del 2022 sulla scorta dei due interventi pittorici permanenti realizzati da Adrian Ghenie nella Chiesa della Madonna della Mazza, a Palermo. “Ho pensato questo progetto due anni fa – ci racconta – perché dopo i due temi laici delle Ghenie Chapels, la giustizia e la pace, desideravo affrontare il tema della migrazione. Ho così pensato di coinvolgere l’Università di Palermo, luogo di conoscenza e di formazione delle nuove generazioni, che a questi temi ha dedicato un dottorato, il Centro Migrare e la Clinica legale Migrazioni e Diritti. Ne ho parlato con l’amico Paolo Inglese e a gennaio 2024 abbiamo firmato un accordo con il Rettore”. Ogni due mesi circa arriverà una nuova opera, fino a compiere il disegno di una mostra collettiva diffusa, della durata di tre anni: opere realizzate ad hoc o preesistenti, comunque cucite su misura per spazi individuati nell’edificio che ospita il Dipartimento di Giurisprudenza, tra la Sala dei Busti e l’Aula Magna. Il programma di lezioni e conferenze, a cura del Dipartimento di Scienze Umanistiche, diretto dalla Prof.ssa Concetta Giliberto, accompagnerà le inaugurazioni, offrendo agli studenti dei momenti di approfondimento.
Le prossime opere di Crossing Borders a Palermo
L’opera di Claire Fontaine è stata prodotta dalla Fondazione, “che con questo progetto apre una piattaforma d’azione con altri artisti e rinsalda l’asse su via Maqueda, con la Chiesa della Madonna della Mazza, la Chiesa di Santa Ninfa ai Crociferi, dove Ghenie nel 2024 ha installato una sua versione di Santa Rosalia, la Patrona di Palermo, e infine con il Palazzo di Giurisprudenza”. Le prossime tappe vedranno nell’ordine Yuri Ancarani, atteso per il 13 maggio, quindi il reporter Paolo Pellegrin, il 10 giugno: “Yuri presenterà uno dei suoi primi lavori rimaneggiato e adattato al progetto”, conclude Borghese, “e incredibilmente attuale. Paolo presenterà tre fotografie su fatti successi a Gaza, che gli hanno fatto avere la copertina del New York Times. A fine settembre sarà la volta di Francesco Vezzoli: stiamo ancora valutando, ma sarà una nuova produzione. Anche per Loredana Longo si tratterà di un’opera che fa parte del suo mondo, ma pensata per l’occasione. E così anche per Adrian Ghenie”.
Grande metafora dell’odierna legge dell’indifferenza e del disamore, la complessa questione delle migrazioni si incaglia nel cinismo di governi e di sistemi sociali inadeguati, mentre altre connesse emergenze, da quelle climatica a quella dei molti teatri di guerra, alimentano fughe, marginalità, squilibri economici. Lo spazio pubblico è allora un piano sensibile, plurale, a cui affidare ulteriori occasioni di ragionamento e in cui la sfida delle immagini e del pensiero sa ancora generare attriti, sintonie, dibattito, sorpresa. Le istituzioni, dai musei ai luoghi di formazione, restano in tal senso – e in teoria – fondamentali territori d’azione, di esercizio critico e di responsabilità.
Helga Marsala
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati