L’arte è cosa nostra
Non è recensibile un Padiglione come quello italiano. Non è un’impresa che si presta alla critica “classicamente” intesa. Meglio tentare di capire cosa significa, letteralmente. Cosa significa, ad esempio, che 200 intellettuali di varia estrazione si siano prestati a una operazione di quel genere. Una riflessione a tutto campo, quella di Adriana Polveroni.

Se non è cosa nostra, di chi è l’arte e a chi interessa? Dovrebbe interessare ai politici, perché anche da qui passa, come dimostrano molti Paesi – Gran Bretagna, Polonia, Stati Uniti, Cina, India -, il prestigio di un Paese. E dovrebbe interessare agli intellettuali, Sgarbi compreso. Mai sentito dire che il futuro economico dell’Italia potrebbe giocarsi molto sulla valorizzazione (vera, non da slogan afasico) del nostro patrimonio artistico e ambientale? Società immateriale, industrie culturali, terziario avanzato è tutta roba che potrebbe essere targato Made in Italy. Purtroppo, l’arte non sembra essere cosa per loro.
A una recente conferenza del Festival dell’arte contemporanea che si svolge a Faenza, il collezionista Giorgio Fasol ha detto una cosa sacrosanta e molto semplice: “Raccontiamo ai politici i numeri che fa la cultura”. Facciamogli vedere, dati alla mano, quando guadagna per esempio una città come Venezia quando c’è la Biennale, al di là delle bestemmie dei veneziani per i vaporetti intasati. Facciamogli vedere quanto sviluppo crea la costruzione di un museo importante, oltre a far aumentare i valori immobiliari. È successo a Londra, con la Tate Modern che ha rilanciato il Southwark: 3 mila nuovi posti di lavoro nei primi 5 anni e beneficio economico per l’intera Londra calcolato dai 75 ai 140 milioni di sterline. È accaduto a Bilbao con il Guggenheim, che mediamente porta in questa città bruttina un milione di turisti all’anno. Era già accaduto 40 anni fa a Soho, a New York, quando ci sono arrivati i primi artisti, e per accaparrarsi i loft qualche anno dopo c’era la fila di negozi e ristoranti. E poi è stata la volta di Chelsea e di Williamsburg. E, in piccolo, è accaduto nel quartiere dove sorge il Macro di Roma. Abito da quelle parti, e negli ultimi anni ho visto nascere ristoranti, wine bar e gallerie d’arte, anche un paio di alberghi. A maggior ragione, quindi, è irrinunciabile che la nomina del nuovo direttore verta su una figura capace di attivare una programmazione di qualità e il consenso necessario perché il museo, meglio la Fondazione Macro, esprima tutte le sue potenzialità.
Portiamoglieli, questi dati; sembrerà banale, ma non ci pensano. Non li conoscono, altrimenti non li farebbero, i tagli lineari. Cantiamoglieli, con tutti gli annessi e connessi delle statistiche economiche sui vari festival, da cui risulta che per ogni euro investito ne ritornano tre sul territorio. So bene che a questo punto Pier Luigi Sacco avrebbe di che ridire: non è questo lo sviluppo che si vuole, e che si può creare, con la cultura. Troppo effimero e troppo predatorio. Mordi, fuggi e non lasci niente. Abbastanza vero. Ma intanto all’orecchio dei politici funziona. È l’unico linguaggio che capiscono, quello delle cifre. Che siano voti o guadagni.
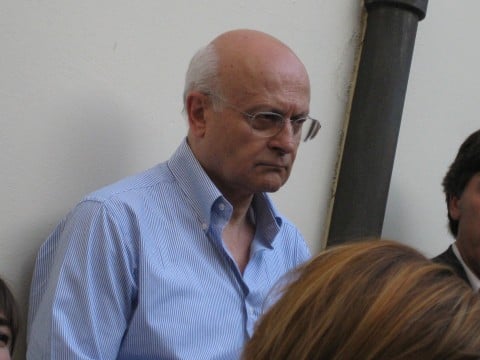
Giorgio Fasol
Se questo è quanto dovremmo comunicare ai politici, agli intellettuali va detto invece che, se non sono informati di quello che avviene nell’arte contemporanea italiana – la quale, poiché viviamo in un mondo globale, non è isolabile da quanto accade nell’arte contemporanea tutta -, non dovrebbero cedere alle lusinghe di inviti che li incorano suggeritori. Non lo sono. E non c’è niente di male. Chi conosce bene il teatro o la linguistica o la filosofia non è tenuto necessariamente a saperne di arte contemporanea, che rimane, a torto o a ragione, un linguaggio complesso che richiede studio e impegno. Perché quello che è accaduto alla Biennale con il Padiglione Italia è che gli intellettuali, coloro che dovrebbero avere a cuore l’idea di puntare sulla cultura per svegliare il nostro Paese dal sonno (o dall’incubo) berlusconiano, per insipienza o arroganza abbiano accettato di sottoscrivere la peggiore operazione di marketing sull’Italia che si sia mai vista.
A Venezia, città che ha inventato la Biennale, diventata un modello imitato in tutto il mondo, siamo riusciti, grazie a Sgarbi e ai 200 intellettuali da lui convocati, a mettere in piedi la peggiore vetrina dell’Italia. Già nella considerazione internazionale il nostro Paese va ben poco oltre l’idea che sia una location ancora piuttosto attraente (ma fino a quando?) per attori e celebrities che ci prendono casa o che ci si sposano. Con il risultato che “il Paese dove fioriscono i limoni” è diventato un set. Un altro film da quel luogo dove secoli fa fu miracolosamente possibile coniugare civiltà e bellezza naturale.

L'Arsenale di Venezia
L’idea che in un’operazione come quella di Sgarbi sia in gioco qualcosa di marginale è un errore. Da sempre, l’arte evoca e rimanda ad altro, altrimenti non sarebbe nemmeno mai nata. La sua capacità di comunicazione non si esaurisce nel segno in cui si presenta. L’arte e la cultura raccontano dell’energia e dell’intelligenza di un Paese e, come tali, sono i biglietti da visita per accreditarsi all’estero. Non è vero? Basta chiederlo a François Pinault, che proprio a Venezia ha aperto ben due sedi della sua fondazione. Provate a chiederlo a Viktor Pinchuk, il magnate del gas ucraino, che da un po’ di anni non manca mai alla Biennale con una mostra da lui prodotta. Il suo Art Pinchuk Center a Kiev svolge un preciso ruolo di public relation presso gli interlocutori stranieri che gli interessano, per se stesso e il suo Paese. Ne sa qualcosa anche Mr. Mori (il miliardario zio di Mariko, l’artista), che quando a Tokyo ha ristrutturato l’area di Rappongi Hills, in cima alla Mori Tower ha piazzato un museo che porta il suo nome. Strano che Berlusconi non ci abbia pensato. E meno male.
Non sono trastulli da tycoon, né l’arte è ruffiana perché si presta a questo; è nella sua natura stare dentro la società, muoverne gli assetti ed esercitare un potere mediatico. Basta guardare alla vicinanza che per secoli c’è stata fra l’arte e la chiesa.

Punta della Dogana
Sgarbi e gli intellettuali, invece, hanno pensato di umiliare la nostra contemporaneità, l’immagine dell’Italia nel mondo come Paese capace di parlare il linguaggio del presente. Come Paese capace di investire sui suoi talenti. Che crede nel suo futuro. Non è una lamentela da anima bella. C’è qualcosa che va oltre l’indignazione, perché quello sgangherato e inguardabile Padiglione sta a dire che noi italiani, le nostre migliori energie sono, al momento, messe molto male. E allora, oltre la vergogna e l’imbarazzo che normalmente si prova quando uno straniero ci chiede “Come fate a tollerare tutto questo?”, e non c’è risposta che giustifichi il fatto e il nostro silenzio, bisogna considerare il danno che tutto questo produrrà da qui a breve, e forse purtroppo anche a lungo, sulla nostra cultura e sul nostro mercato dell’arte.
I nostri artisti sono poco presenti sulla scena internazionale, la scarsità e la debolezza delle istituzioni che anni addietro avrebbero dovuto sostenerli ha fatto sì che progressivamente siano quasi scomparsi dalle grandi manifestazioni internazionali. Eppure ce ne sono di bravi, eccome. Ma chi li inviterà dopo aver visto il nostro Padiglione, alla cui fattura hanno collaborato ben 200 intellettuali? Che credibilità avranno loro, e noi con loro, che ce ne occupiamo? Con chi dialogheranno i nostri musei, già a corto di collezione, per fare delle mostre? Gli crederanno, i musei stranieri, che tutto non finisce con il Padiglione Italia di Venezia dopo aver visto decine, centinaia di cosiddette opere “brutte, kitsch, volgari”, come le hanno bollate i giornali stranieri, alcune peraltro firmate da alcuni nostri famosi artisti: Pistoletto, Kounellis, Paladino, Beecroft, Chia, Accardi, Paolini?

Vanessa Beecroft al Padiglione Italia
Essere presenti all’estero, nelle piazze che contano nel sistema dell’arte, significa non solo avere un buon “look” (che già aiuta), vuol dire anche comunicare che la nostra cultura, merce così appetibile nella società immateriale e globale, è viva. In grado di parlare al mondo. Altro che l’arte non è cosa nostra! L’arte è cosa di tutti, in quanto nessuno si sottrae al parametro di valutazione espresso anche tramite essa. Così come ce ne sono altri, che ci dicono che un Paese è civile o meno: il grado di inquinamento, la mobilità sociale e territoriale, la scolarizzazione, la sanità, la diffusione di Internet, la libertà di stampa. E significherebbe che anche le nostre aziende, se investissero di più nell’arte, avrebbero di che scambiare con i competitor internazionali. Quello che non ha capito (o che finge di ignorare) Sgarbi quando si scaglia contro Prada e Trussardi, facendo la parte del professore isterico di provincia in una presunta e obnubilata difesa dell’arte dalle grinfie dell’industria e del commercio, è che l’arte è sempre stata vicina all’industria e al commercio. Al prestigio e al potere, dai Medici in su e in giù. E proprio lui, qualificato storico dell’arte, non può non saperlo. Il problema non è la contiguità con il potere e il mercato, ma quanto, anche attraverso questi, l’arte è in grado di portare il suo sguardo critico e la sua carica liberatoria nella società in cui prende corpo. La qualità di un artista si giudica da questo, non se è nella collezione Prada.

Un interno di Ca’ Corner della Regina
Ma c’è dell’altro. In Italia abbiamo un mercato debole, penalizzato da un’Iva al 20 per cento che induce anche i nostri collezionisti a comprare spesso fuori e da un diritto di notifica che, se è stato sacrosanto per arginare i traffici di arte antica, rimane inspiegabile se applicato al contemporaneo, le cui opere hanno al massimo 50 anni e vivono quindi ancora una giovinezza commerciale che ne richiede agile mobilità. Dunque, un mercato che, nonostante i vari tentativi di tirarsi su con le fiere, non si presenta propriamente florido. Come ne uscirà da questa Biennale? Chi verrà a comprare nelle nostre gallerie già un po’ in affanno dati i tempi e che però continuano coraggiosamente a nascere e a investire? Comprare che cosa, le croste, gli inutili e orribili faccioni messi in mostra alle Corderie? E se il nostro mondo e mercato dell’arte vanno giù, che ne sarà del famoso indotto? Di quel fragilissimo sistema di occupazione che si sta costruendo intorno all’arte contemporanea? Non solo gli esercizi commerciali, ma le professioni legate alla cultura.

L'opera di Kounellis allestita al Padiglione Italia
Roba delicatissima, che per fortuna affascina non pochi giovani, che preferiscono studiare beni culturali, destinandosi a un futuro di pochi soldi piuttosto che fare i casting per cubisti, tronisti e grandi fratelli. Gente probabilmente destabilizzante per questo governo. Gente che ce la metta tutta, con passione, sapendo che sarà dura. Ne ho conosciuti tanti, insegnando in accademie e università. Sicuro che questi giovani che difficilmente trovano lavoro in Italia, che sono disposti ad andare all’estero, pur non pagati, per fare uno stage in una galleria, in un museo, in una fondazione, saranno presi sul serio dicendo che vengono dal Paese del bunga bunga e dell’arte che non è cosa nostra?
Adriana Polveroni
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





