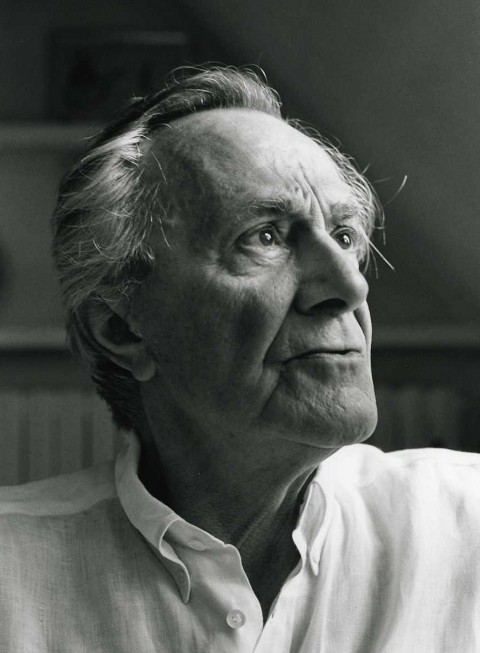Tornando a parlare di anni ‘80: il ritorno all’ordine
Botta e risposta. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato una intervista con Edoardo Di Mauro. Una lettura altra degli Anni Ottanta, “un’altra storia”. Che ha suscitato non poco dibattito fra i commentatori di Artribune. E che ha fatto sollevare un sopracciglio al nostro Marcello Faletra. Qui spiega le sue ragioni.

POSTMODERNISMO E TRANSAVANGUARDIA
Gli Anni Ottanta… gli anni in cui ha imperato, col suo eclettismo retrò, il pastiche in pittura, che avviava il trionfo di un diffuso dilettantismo ispirato al kitsch e al banale e condito socialmente dalla sterile ironia dello spettacolo. Ma anche gli anni dell’edonismo senza frontiere, dello yuppismo arrogante, della frivola apatia, della disaffezione ai grandi temi sociali…
Si è trattato di un pezzo del più ampio scenario storico noto come “postmodernismo”, di cui nel 1986 Derrida dirà che si trattava di “una strategia culturale come sottoprodotto del più antico storicismo”. Come dire: una pagliacciata che giocava con il valore di scambio del linguaggio, che non aveva più nulla a che vedere con i fatti. E i prefissi post, neo, trans non sono stati altro che etichette che diversificavano il prodotto culturale. Guy Debord, nei suoi Commentari alla società dello spettacolo (1988), illustrerà bene questa stagione populista ordinata secondo l’immagine fantasmagorica dello spettacolo: “Un finanziere canta, un avvocato diventa informatore della polizia, un fornaio espone le sue preferenze letterarie, un attore governa [Reagan], un cuoco disserta sui tempi di cottura come momenti essenziali della storia universale. Ognuno può apparire pubblicamente nello spettacolo e darsi pubblicamente”.
Nel 1982 Lyotard, in un intervento su Alfabeta, prendeva le distanze dalla transavanguardia: “Vi è, nei multiformi invii a sospendere la sperimentazione artistica, uno stesso richiamo all’ordine, un desiderio di unità, di identità, di sicurezza, di popolarità (nel senso di trovare un pubblico) […] per tutti questi autori nulla è più urgente del liquidare l’eredità delle avanguardie. È questa, in particolare, l’impazienza del sedicente transavanguardismo”. E anche Baudrillard, in una conversazione privata, mi disse che le sue analisi sulla simulazione non avevano nulla a che vedere “con le succursali transestetiche della reazione postmodernista dove la gente subisce ciò come un rituale devitalizzato, vi assiste, guarda, ma non ci crede, come accade in politica”. Le avanguardie vivevano dell’idea che tutto gli si opponeva; le transavanguardie degli Anni Ottanta, all’opposto, vivevano dell’idea che nulla gli si opponeva, tanto erano conformiste e docili e cosi vicine al potere.
CITAZIONE E RISCRITTURA
Thomas Kuhn ha fatto osservare che una teoria (ammesso che il postmodernismo lo sia stato) per essere accettata deve prima di tutto piacere, presentarsi come migliore delle altre. Si potrebbe vedere in questa osservazione il principio della concorrenza che costituisce la base del commercio che è penetrato fin nelle teorie, modificandone le loro finalità. E il postmodernismo, a cui non è mancata la concorrenzialità, è piaciuto a molti. Senza capire bene cosa sostenesse, se non il rifiuto esplicito della modernità.
Una cosa però l’ha centrata: ha difeso la fine della nozione di ‘superamento’, a vantaggio della nozione di ‘riscrittura’. Si tratta di capire allora come si sono prodotte queste riscritture. (Ma non era stato l’ultramoderno Nietzsche ad affermare questo pensiero?) In effetti, dato che nulla era più da superare, si trattava allora di mescolare, di “pasticciare” gli stili, dove potevano convivere senza conflitti de Chirico, Matisse, Rosai, Pollock, Warhol… “Questo è precisamente il problema”, osservava Bourriaud alla fine degli Anni Novanta tentando un bilancio di quell’esperienza, “dal pennello di Julian Schnabel o di Enzo Cucchi, la storia dell’arte sembra un gigantesco immondezzaio di forme vuote, amputate dei loro significati a vantaggio del culto dell’artista demiurgo e salvatore che opera sotto la figura tutelare di Picasso. Con questa vasta impresa di reificazione delle forme, la metamorfosi degli dei trova una parentela con il museo immaginario. Tale arte della citazione, praticata dai neo-fauvisti, riduce la storia a valore di mercato”.
Dunque, la citazione è stata un elemento decisivo per la formazione di un immaginario populista. Ma occorre pure chiedersi di che natura è stata questa citazione e di quali elementi storici si è fatta portavoce? La fisionomia di un periodo deve essere letta nella specificità delle significazioni immaginarie in cui ha creduto. Proviamo a vederne qualcuna e con gli occhi di un critico come Celant, che nel 1983 scrive: “Oggi l’uditorio per un rimando ideologico e intellettuale agli anni bui della storia europea va sempre più allargandosi e gli ‘arditi’ dell’arte e della critica chiedono ad alta voce il discredito dell’impegno e del concettualismo a favore di un pompierismo e un fauvismo populista […] In Italia, in particolare, le fantastiche figure mitiche dell’antica Roma, che ricorrono in dipinti e sculture dell’onirismo contemporaneo, rivelano profonde correlazioni con l’arte del ‘ritorno all’ordine’”.
Fin qui Celant. L’analogia fra il rigurgito reazionario degli Anni Ottanta e quello del Ventennio fascista intravisto tempestivamente da Celant non deve sorprenderci. Perché se prima si trattava di mettere in forma un immaginario collettivo che celebrava la forza, la tecnica al servizio della patria, i miti della romanità, negli Anni Ottanta, invece, si celebrava l’individualismo, l’ironia cinica, l’indifferenza verso i fatti del mondo, la dittatura del divertimento secondo il modello dell’entertainment, insomma tutti gli ingredienti dell’ideologia neoliberista emergente. Si tratta di vedere adesso quali immagini hanno alimentato questo “ritorno all’ordine”.
L’IO E L’ORDINE
Com’è ormai noto, il punto forte della citazione (almeno in pittura) negli Anni Ottanta del secolo scorso è stato il ritorno a una presunta soggettività. Si è trattato di una specie di melodramma dell’ideologia del soggetto fondata sul primato dell’“emozione”, sul ritorno del mito e sull’imitazione storica centrata sulla figura umana quale portavoce di un torbido intimismo. La morte, l’occulto, il mistero, il mito, ma anche l’ironia goliardica, il culto dei grandi formati (culto dell’impressionevole), insomma un repertorio di immagini “sensitive” che attingevano spesso alle mitologie nazionali, vale a dire all’”originario” di ogni specifica cultura geografica.
In tal senso, è evidente quanto il richiamo all’ordine operato negli anni Ottanta non sia stato altro che un richiamo alle matrici nazionaliste, funzionale alle aziende commerciali (il potere esclusivo di certe gallerie e musei che stabilivano l’ordine del giorno dell’arte) che aspiravano a una “diversificazione del prodotto” artistico in termini di comunicazione, spendibile sul mercato. E non è da trascurare il fatto che spesso le varie “scuole” di pittura venivano declinate non più con l’internazionalismo degli Anni Sessanta e Settanta, ma come vagiti nazionalistici: neo-espressionisti tedeschi, transavarguardisti italiani, graffitisti americani, The School of London…
Per alcuni importanti protagonisti della scena pittorica, questo “ritorno all’ordine” ha assunto contorni eticamente miserabili. In Germania, ad esempio, si assistette a uno spettacolare ritorno della “linea gotica” (neo-espressionismo) basata su un immaginario che in alcuni casi sfociava volentieri nell’ideologia del “suolo”, tanto da far cambiare a qualcuno il proprio nome con quello della terra natia, come ha fatto Baselitz – autentico pittore, non lo neghiamo – il cui vero nome però è Georg Kern, che adotterà quello del suo Paese natio, Deutschbaselitz. Tanto che in un’intervista dichiarerà: “La mia terra d’origine è la Germania e come pittore sono doppiamente tedesco”. In questa lapidaria dichiarazione di Baselitz o Kern (come chiamarlo?) si concentra tutta l’ideologia dell’appartenenza alla “comunità di destino” che fu propria del popolo tedesco negli anni bui del nazismo, con i suoi miti popolati dai Walhalla, dagli Arminius…
Non dico che Baselitz sia un nazista, ma un reazionario nazionalista, questo sì. In lui sopravvive quell’ideologia del “suolo” o “comunità di destino” così significativa durante il nazismo che lo ha portato a scelte come quelle di Documenta del 1981, dove diede libero sfogo al suo delirio nazionalistico protestando contro la presenza di artisti della Germania dell’Est, ritirando le sue opere e trascinando in questa scelta altri artisti. Un episodio taciuto dalle esegesi che coronano l’artista.
Fra gli elementi che hanno caratterizzato questa ideologia nazionalista non sono da trascurare l’immagine del contadino e dell’albero (l’albero che ricorrerà spesso nei quadri di Kiefer non è indenne da questo contagio ideologico) per simboleggiare la forza e la tradizione del Volk, il senso delle radici che affondano nel passato e l’inevitabile pensiero del radicamento. L’affermazione di Baselitz va letta alla luce di questo scenario ideologico, senza il quale rischia di essere letta con quell’ingenuità che storicamente ha ratificato le menzogne più insopportabili.
Com’è noto, l’appartenenza alla “comunità di destino” è la secolare vicenda che ha segnato la rivoluzione conservatrice tedesca tra le due guerre. In tal senso, i grandi quadri di Anselm Kiefer ne sono il sintomo più manifesto, dove autoritratti fotografici col saluto nazista, svastiche e paesaggi di morte si susseguivano come un campionario fino alla confusione ideologica: sono i segni di questo passato catastrofico ad aver vinto o è un modo catartico per liberarsi da esso? Tuttavia, attingendo acriticamente ai miti del passato ratificava il cliché dell’identità tedesca, ma con un linguaggio formale di grande livello, tale da generare un’inversione di tendenza rispetto a Beuys, che nelle sue rievocazioni storiche si poneva l’intento di smascherare questi cliché.
L’ITALIA E IL CONFLITTO
La frangia più estrema e reazionaria di questo rigurgito nazionalista venne presentata a Milano alla Galleria Cannaviello nel 1987 – nel catalogo sono presentati dallo scrittore Giovanni Testori, che li ha chiamati espressamente “Nuovi Ordinatori” capeggiati da Albert. Già, “Nuovi Ordinatori”. Titolo che suonava come un’ingiunzione, un comando, un ordine, appunto. Cosa intendevano ordinare? Ecco allora dei corpi monumentali, imponenti, che sovrastavano paesaggi e storie, corpi che dominavano la scena del mondo; corpi a cavallo come gli imperatori di una volta, corpi muscolosi come i gladiatori romani, corpi indomiti come le tempeste della natura. Nel 1984 l’artista americano Donald Judd criticò duramente questo tratto nazionalistico dei “neoespressionisti” tedeschi, ritenendoli “reazionari” e praticamente “kitsch”.
Fermiamoci qui. L’ordine intravisto da Lyotard, da Debord, da Derrida e da Celant in quegli anni assume adesso una chiara fisionomia ideologica di cui diversi artisti, oggi più che storicizzati, mitizzati, si sono fatti veicolo. Oggi il postmodernismo degli Anni Ottanta ha smesso di essere cool e d’un colpo, come in un brusco risveglio, il postpostmodernismo presenta il saldo delle abbuffate di edonismo, di yuppismo, di narcisismo, di conformismo, di affarismo, tutto un mondo di illusioni perdute e di conti in banca concreti. Il brutale realismo d’oggi non fa sconti a nessuno, e dopo il crollo delle Torri Gemelle e le guerre che hanno segnato questi ultimi dieci anni, anche la parola ‘postmodernismo’ vive la sua agonia. Nessuno ne parla più. Ma i suoi esiti sussistono ancora, coperti da un manto di silenzio. Aveva ragione Lyotard a insistere nel mantenimento in vita del “dissidio” (le différend), dell’intrattabile, insomma del principio di alterità e di negazione di cui oggi se ne rivendicano le virtù contro il crack non soltanto economico, ma anche culturale.
Marcello Faletra
LEGGI ANCHE:
Gli Anni Ottanta secondo Edoardo Di Mauro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati