L’idea del realismo, VIII: Raw Power
Cosa comporta produrre un’arte antistorica, totalmente avulsa dal contesto in cui si trova ad agire? Significa ridursi più o meno consapevolmente all’inazione, all’impossibilità di essere efficaci. Si chiude, per ora, la riflessione di Inpratica sul nuovo realismo.

Se noi agiamo, per quanto nel nostro piccolo, non dovremo
Restare ad aspettare un meraviglioso futuro utopico.
Il futuro è un’infinita successione di presenti, e vivere ora
Come pensiamo che gli esseri umani dovrebbero vivere,
sfidando tutto ciò che c’è di male intorno a noi, è già in sé
una meravigliosa vittoria.
Howard Zinn, You can’t be neutral on a moving train (1994)
Mai dimenticare chi sei, perché di certo il mondo non lo dimenticherà.
Trasforma chi sei nella tua forza, così non potrà mai essere la tua debolezza.
Fanne un’armatura, e non potrà mai essere usata contro di te.
Tyrion Lannister in A song of ice and fire – A game of thrones (George R. R. Martin)
L’arte significativa introduce nell’opera il ‘rumore’ e il disordine della vita: elabora il disordine, senza depotenziarlo. Gli dà una struttura. Controlla per un momento il caos – e il caso – vero dell’esistenza. Gestisce e canalizza la disperazione. (E l’aspetto più interessante di questi oggetti è la loro qualità apparentemente e irresistibilmente extraculturale, antintellettuale; ciò che li fa sembrare perfino inaccettabili alla generazione che li ha prodotti, quando invece la riflettono così fedelmente – esattamente quello che è andato svanendo, evaporando negli ultimi dieci-quindici anni; ciò che spinge la maggior parte, o almeno alcuni, a dire: “questo è oltraggioso… è vergognoso… è nuovo”. Anche se, ovviamente, non tutte le cose oltraggiose e vergognose sono per forza nuove.)

Maurizio Cattelan al Guggenheim di New York
Non esiste invece un’arte che sia una sequenza di declinazioni morte: o meglio, può anche esistere, ma è anti-storica. Generazioni di artisti che escludono il mondo dal proprio sguardo, che lavorano unicamente su una simulazione, che si esercitano all’interno di un recinto strettissimo: qualcosa che solo un’epoca come questa era in grado di produrre.
“Nichilismo e solipsismo letterari sono senza dubbio interdipendenti. Entrambi si basano sull’idea che una rottura radicale separa l’io e il mondo, in altre parole che non esiste un mondo comune. Non posso sostenere che la vita e l’universo sono assolutamente insopportabili se non me ne sono preliminarmente escluso. Viceversa, decido di dedicarmi esclusivamente alla descrizione delle mie esperienze personali solo se ritengo che il resto del mondo non abbia valore e non mi riguardi. Queste due visioni del mondo, dunque, sono altrettanto parziali: il nichilista omette d’includere nel quadro desolato che dipinge un posto per sé e per i suoi simili; il solipsista trascura di rappresentare il quadro umano e materiale che rende possibile la sua stessa esistenza. Piuttosto che rifiutare la scelta formalista, nichilismo e solipsismo la completano: ogni volta, seppure con modalità differenti, è il mondo esterno, il mondo comune a me e agli altri, a essere negato o svalutato” (Tvetan Todorov, La letteratura in pericolo).
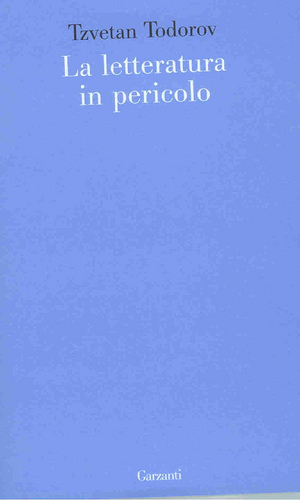
Tvetan Todorov – La letteratura in pericolo
Il non chiedersi mai, neanche per un istante – e se la domanda si affaccia, rimuoverla rapidamente dalla percezione – se le condizioni che si sono trovate fossero o meno plausibili, logiche, giuste. Se, per caso, il gioco non fosse truccato in partenza, e se magari occorresse concentrarsi ossessivamente sui modi (possibili) per ribaltare il tavolo, per far saltare le regole, per sconvolgere convenzioni che si rivelavano stupidissime già al primo sguardo – invece che accettarle passivamente, non discuterle mai.
Tutto ciò ha oggi un prezzo: l’essersi tagliati fuori, consapevolmente o inconsapevolmente, dai processi più significativi che stanno riguardando “un’epoca senza precedenti” (Noam Chomsky). L’essersi privati di una voce, di qualunque possibilità di partecipare al discorso pubblico nel momento stesso in cui paradossalmente il discorso pubblico diventa più cruciale e decisivo che mai (proprio perché le forze che si oppongono ad esso, che lo negano e lo delegittimano, sono più potenti che mai). L’aver rinunciato a riflettere il mondo. Il che non vorrebbe dire, ancora una volta, ricadere nella trappola dell’arte che “recita la parte dell’arte politica” (un recinto altrettanto angusto e astratto rispetto a quello del formalismo): dell’arte che fa finta di essere politica, ma che riesce ad essere solo didascalica, e ancora una volta decorativa.
L’arte (letteratura, arte visiva, cinema) effettivamente politica – e realista – è in grado di trasformare la nostra debolezza nel più grande punto di forza; di rendere ciò che ci paralizza e ci spinge giù il nucleo vero di un’identità stilistica, espressiva, narrativa; di fare del disagio individuale e collettivo il tema potente e pervasivo di oggetti culturali unici – esibendolo e articolandolo con lucidità invece di nasconderlo e rimuoverlo costantemente.
Sganciarsi e dissociarsi dalla realtà non vuol dire, quindi, nient’altro che questo: non essere in grado di intervenire su di essa (su noi stessi), e – dunque – neanche di comprenderla. Di comprendere la nostra posizione e il nostro ruolo nella storia presente, e nell’“infinita successione di presenti” che è il futuro.
Christian Caliandro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





