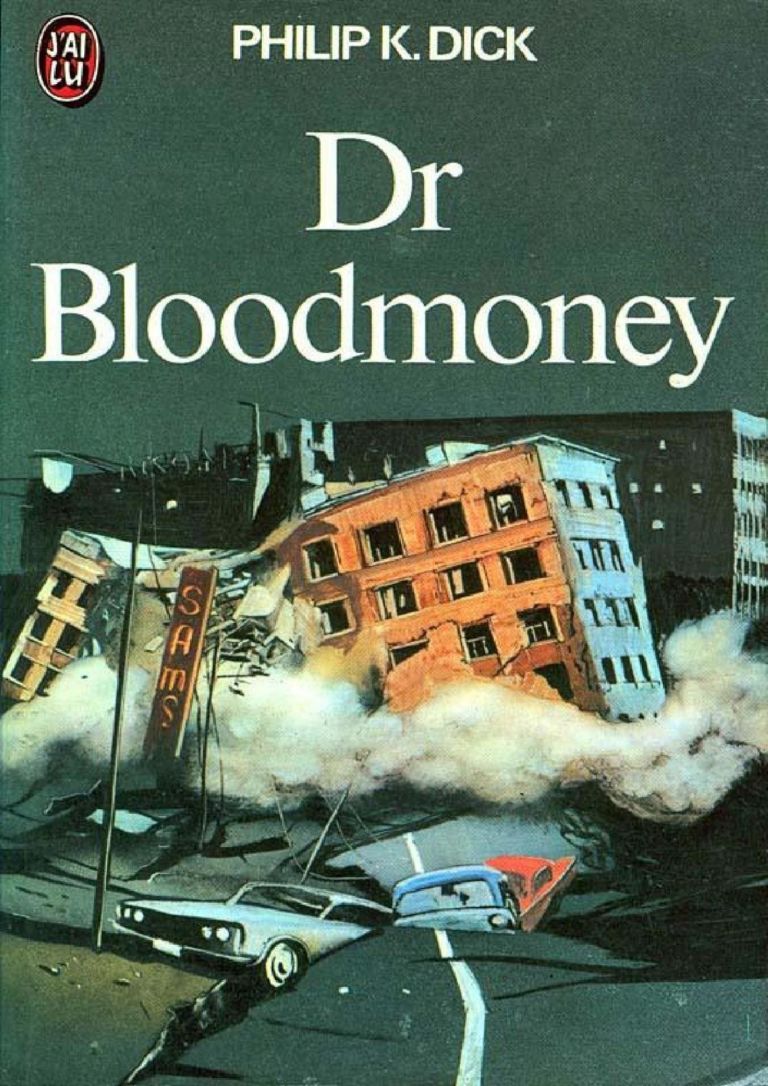L’idea dell’apocalisse (III)
Terza puntata del saggio di Christian Caliandro sul concetto di apocalisse. La fine del mondo può essere raccontata o è per sua natura indescrivibile? E che rapporto c’è tra apocalisse, tensione e nostalgia? Riflessioni sulle macerie del presente e quelle del futuro.

“Al futuro. Che riposi in pace.”
Jericho, serie tv (2006)
L’ossessione nostalgica del passato (anche di quello non vissuto direttamente) assume anche un’ulteriore declinazione, proiettata in avanti. Nel futuro. In particolare, in un futuro-senza-futuro costruito con gli scarti e le rovine di un’epoca morta, adatto perciò a tempi di crisi, di trasformazione e di profonda incertezza come quelli attuali – e come altri precedenti – rispetto a versioni più utopiche e ottimiste.
Il sentimento apocalittico è una tensione, dato che la Fine del Mondo vera e propria, al di là dei riferimenti generici e sbrigativi, sembra in fin dei conti ben poco consona ad un’epoca come la nostra in cui, come scriveva Marco Belpoliti, viviamo costantemente una fine “che non finisce di finire” (Crolli, Einaudi 2005, p. 130). Allora, molto più indicato appare lo spirito della post-apocalisse: ciò che succede, in particolare agli esseri umani e alle loro vite, dopo il disastro. Il fascino di questa proiezione era stato individuato – già ai suoi albori nell’epoca contemporanea, in piena era atomica – da Philip K. Dick: “Invece di scrivere storie sulla catastrofe imminente, forse dovremmo dare la catastrofe per avvenuta e partire da lì…” (Pessimismo e fantascienza, 1955, in Mutazioni. Scritti inediti, filosofici, autobiografici e letterari, Feltrinelli 1997, p. 89).
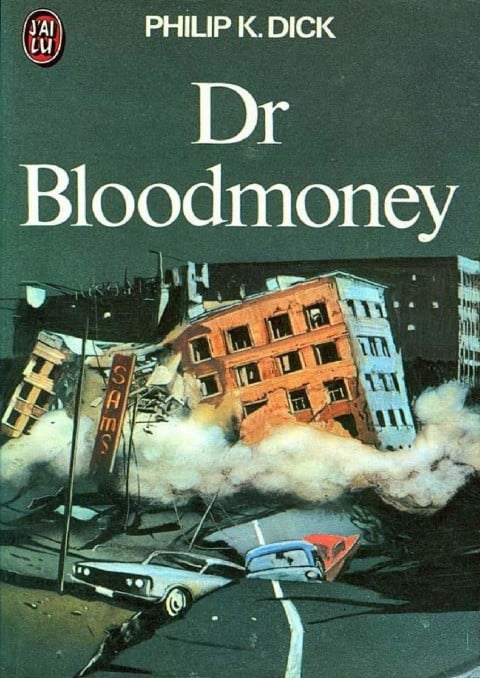
Philip K. Dick, Dr. Bloodmoney (1965)
La post-apocalisse, dunque, come proiezione in avanti. Ma di che cosa? Dei nostri incubi, certo, ma non solo. L’apocalisse vera e propria non può essere raccontata, in definitiva, perché verrebbe meno lo sguardo che possa testimoniare: il postulato di fondo dell’apocalisse è che il genere umano sia estinto, e che il mondo, ammessa e non concessa la sua sopravvivenza, continui senza di noi su scale temporali incommensurabili. L’apocalisse è, per definizione, indescrivibile. Per questo, sono rarissimi i testi – eccezion fatta, e non a caso, per quelli sacri e millenaristici, in cui il punto di vista è contemporaneamente interno ed esterno agli eventi – che ne parlano direttamente; ed ecco anche perché quasi tutti i prodotti culturali contemporanei comunemente e un po’ sbrigativamente indicati come ‘apocalittici’ sono, più precisamente, post-apocalittici. Una letteratura o un cinema compiutamente apocalittici, infatti, non sono esistiti se non in rarissimi casi (almeno fino a questo momento), per il semplice fatto che in essi non esisterebbe più nessuno a portare avanti concretamente il racconto.
Allora, è proprio la nostalgia ad essere declinata al futuro nel sottogenere post-apocalittico: la post-apocalisse è la nostalgia del presente. Questo processo ricorda da vicino la contemplazione malinconica e romantica delle rovine descritta, per esempio, da Christopher Woodward. Egli individua uno dei prototipi di questo genere in un’incisione di Gustave Doré del 1873, che ritrae un neozelandese davanti alle rovine della cattedrale di St. Paul e della stazione di Cannon Street, un vero esempio di proto-fantascienza post-apocalittica: “L’uomo sta disegnando le rovine della cattedrale di St. Paul, esattamente come i vittoriani disegnavano i ruderi dell’antica Roma. L’edificio diroccato simile a una cattedrale vicino al magazzino merci è la stazione di Cannon Street, nuova di zecca nel 1873 ma qui immaginata con i pilastri in ghisa del ponte corrosi dalla ruggine, nella fanghiglia creata dalle maree. Quando contempliamo delle rovine, osserviamo il nostro stesso futuro” (In Ruins, 2001; trad. it. Tra le rovine, Guanda 2008, p. 10).
Così, in quasi tutti i romanzi, i film, i dischi e i video musicali post-apocalittici, uno spazio importante, centrale è dedicato alla considerazione assorta e malinconica degli oggetti, residui e rovine di un mondo perduto per sempre. Un paio di esempi presi a caso: “Scommetto che questa il topo non saprebbe suonarla nemmeno fra mille anni, si disse. Dico, questa è praticamente musica sacra, musica del passato, del nostro sacro passato, che né animali di genio, né gente strampalata può apprezzare. Il passato appartiene soltanto a noi, esseri umani autentici. Come vorrei poter fare come Hoppy… vorrei poter andare in trance, ma non per vedere il futuro, io vorrei tornare nel passato. Quel pensiero lo fece sussultare” (Philip K. Dick, Dr. Bloodmoney, or How We Got Along After the Bomb, 1965; trad. it. Cronache del dopobomba, Einaudi 1997, p. 126).
Oppure: “Quando penso a un mondo senza neppure un essere umano, immagino – e chi non lo fa? – enormi templi e cattedrali, palazzi e castelli che sopravvivono ai secoli deserti, la British Library, aperta poco prima di Omega, con libri e manoscritti conservati con cura che nessuno leggerà mai più. Ma in fondo al cuore mi commuove soltanto il pensiero di Woolcombe, l’odore delle sue stanze umide e vuote, i pannelli che marciranno nella biblioteca, l’edera che si arrampicherà sui muri sgretolati, l’erba che nasconderà la ghiaia, il campo da tennis, il giardino abbandonato; mi commuove il pensiero di quella piccola camera da letto sul retro, che rimarrà immutata e disabitata fino a quando il copriletto finirà per squarciarsi, i libri per sbriciolarsi e anche l’ultimo quadro per staccarsi dalla parete” (P. D. James, The Children of Men, 1992; trad. it. I figli degli uomini, Mondadori 1993, pp. 35-36).
Christian Caliandro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati