
Il punto di partenza obbligato di ogni percorso che si avventuri nel racconto dei vari modi in cui la nostra cultura ha raccontato la fine del mondo è L’ultimo uomo (The Last Man, 1826) di Mary Shelley, che rappresenta il momento fondativo dell’apocalisse moderna, seguito a distanza di settant’anni dalla conclusione de La macchina del tempo (1895) di H. G. Wells, e soprattutto da Il morbo scarlatto (1912) di Jack London, esempi di una civiltà che presagisce la sua fine imminente e violenta. In Italia, l’ultima pagina de La coscienza di Zeno (1923) di Italo Svevo fonda una “tradizione favolistico-catastrofica” (Zinato) che proseguirà nella letteratura italiana, con alterne fortune, lungo tutto il Novecento: “Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie”.

Mary Shelley, The Last Man (L’ultimo uomo, 1826)
Bisogna attendere però il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta, il “decennio atomico”, perché la post-apocalisse assuma i tratti e le caratteristiche formali che ci sono tuttora familiari: la paura della Guerra Nucleare informa così romanzi diversissimi tra loro come Il giorno dei trifidi (The Day of the Triffids, 1951) e The Chrysalids (I trasfigurati, 1955) di John Wyndham, Paria dei cieli (1957) di Isaac Asimov e L’ultima spiaggia (On the Beach, 1957) di Nevil Shute, oltre ovviamente ai film di fantascienza, da Quando i mondi si scontrano (When Worlds Collide, Rudolph Maté 1951) a Ultimatum alla Terra (The Day the Earth Stood Still, Robert Wise 1951), fino a La guerra dei mondi (The War of the Worlds, Byron Askin 1953) e soprattutto alla trasposizione cinematografica de L’ultima spiaggia (Stanley Kramer 1959). Il concetto stesso della fine di tutto arriva a identificarsi potentemente con la Bomba, assumendo un altissimo valore simbolico all’interno della cultura popolare, destinato a durare decenni e ad evolversi.
Io sono leggenda (I Am Legend, 1954) di Richard Matheson costituisce invece un caso a sé, dal momento che aggiorna il mito dell’ultimo uomo sulla terra producendo, da solo, una sequenza intera di altri oggetti narrativi: L’ultimo uomo sulla terra (1964) di Ubaldo Ragona, 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra (The Ωmega Man, 1971) di Boris Sagal, Io sono leggenda (I Am Legend, 2007) di Francis Lawrence. Ma, soprattutto, influenzando enormemente George A. Romero nella costruzione de La notte dei morti viventi (Night of the Living Dead, 1968).
È però con la new wave fantascientifica degli Anni Sessanta e Settanta che il tema post-apocalittico acquista tutte le sue implicazioni sociali e culturali, sganciandosi progressivamente dalla connessione più o meno esplicita con la Guerra Fredda e analizzando l’impatto di un evento catastrofico globale nell’inner space dell’essere umano . Il punto di partenza in questo caso è la quadrilogia composta da James G. Ballard, in cui i quattro elementi disegnano differenti scenari catastrofici: Vento dal nulla (The Wind from Nowhere, 1961), Il mondo sommerso (The Drowned World, 1962), Terra bruciata (The Burning World, 1964) e Foresta di cristallo (The Crystal World, 1966).
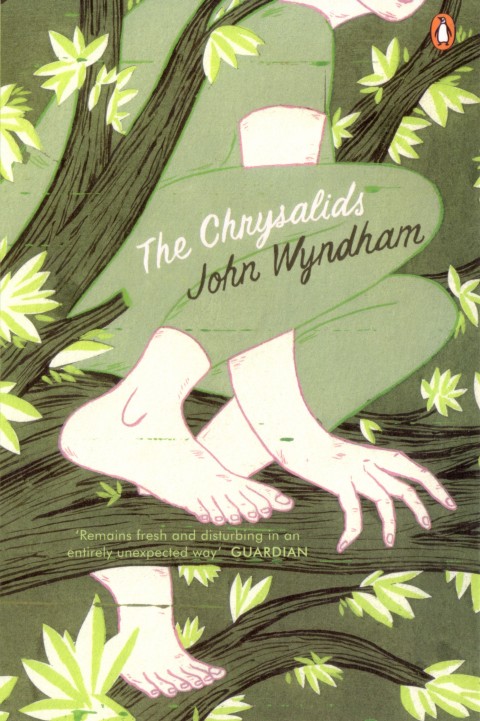
John Wyndham, Chrysalids (I trasfigurati, 1955)
È forse Thomas M. Disch che in Gomorra e dintorni (The Genocides, 1965) riesce ad ottenere, a questa altezza, il più splendido esempio di apocalisse ‘godardiana’. La narrazione si serve infatti di pochi, essenziali elementi (le Piante gigantesche, i paesaggi sempre più desolati, l’atmosfera da racconto biblico) per descrivere la posizione sempre più disperata degli esseri umani, in un contesto che non li prevede più, fino alla scena finale, congelata attraverso l’associazione a un dipinto quattrocentesco: “I superstiti, tra il verde uniforme della pianura, facevano pensare alle tavole in prospettiva dei pittori rinascimentali. Le tre figure più vicine, che si trovavano a metà del quadro, formavano una specie di Sacra Famiglia, ma osservandole attentamente si scopriva che i tre avevano un atteggiamento ben diverso dalla serena felicità di una Sacra Famiglia. La donna, seduta a terra, piangeva disperatamente, e l’uomo, inginocchiato accanto a lei, riusciva a stento a trattenere le lacrime. La loro attenzione era concentrata sul piccolo bambino stretto tra le braccia della madre e che succhiava inutilmente un petto inaridito.
Un po’ più lontano, un’altra figura, che ricordava Niobe, stringeva tra le braccia lo scheletro del figlio, un bambino di una decina d’anni. I capelli rossi della donna formavano uno strano contrasto col mantello verde che copriva la terra intera.
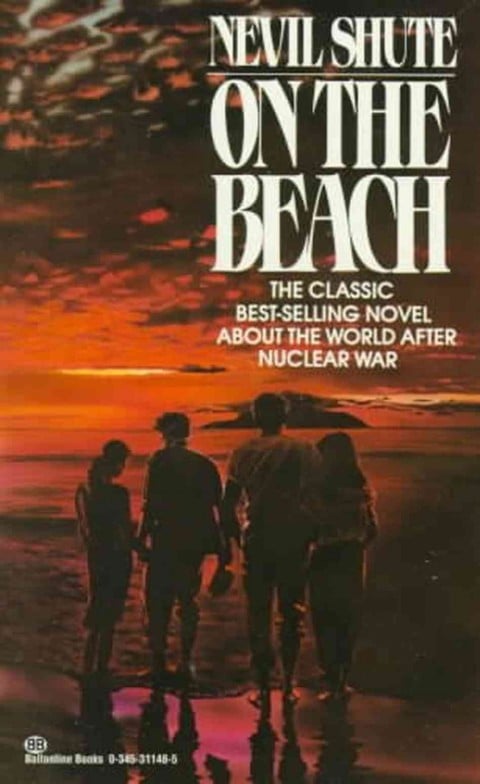
Nevil Shute, On the beach (1957)
Quasi all’orizzonte, avanzavano un uomo e una donna, nudi, tenendosi per mano, sorridendo. I due erano l’immagine di Adamo e di Eva, prima della caduta. Andavano verso sud, e di tanto in tanto parlavano tra loro.
La terra intorno era tutta verde e si stendeva a perdita d’occhio. Su ogni metro quadrato di terreno prosperavano centinaia di Piantine che erano tutte esattamente identiche l’una all’altra.
La natura è prodiga. Su cento semi, uno o due soltanto hanno la probabilità di sopravvivere, e, su centinaia di specie, una o due soltanto si salvano.
Comunque, non l’uomo.
Infine, neppure la luna risplenderà, né le stelle saranno al Suo cospetto.
E cosa dunque ne sarà dell’uomo, che è un verme?
E del figlio dell’uomo, che è un piccolo verme?”.
Christian Caliandro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





