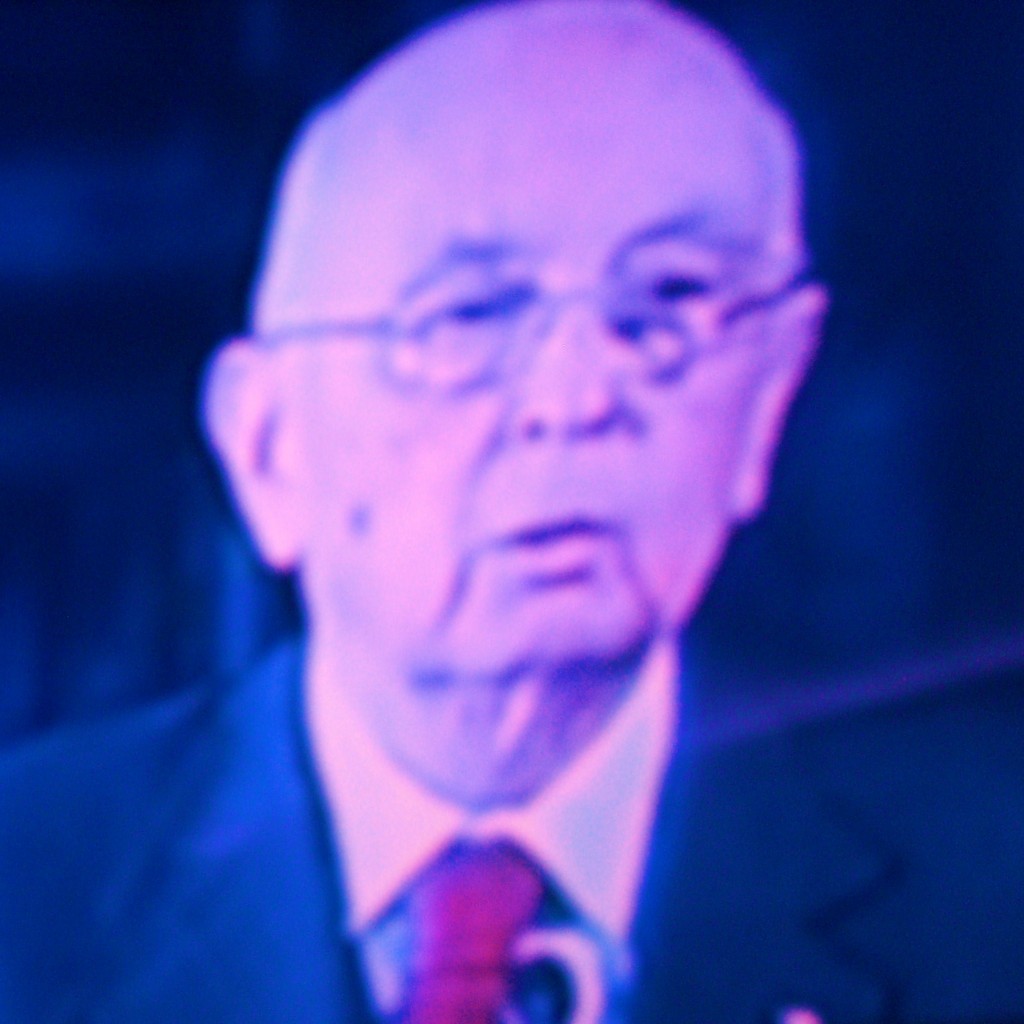
Il nuovo Papa vive con la consapevolezza che, poco distante, risiede e invecchia il suo predecessore: indossa giacche da anziano e avanza a fatica appoggiandosi al suo predecessore, e poche settimane sembrano avere condensato interi anni investendolo in pieno (quasi come accade all’astronauta Bowman alla fine di 2001: Odissea nello spazio). Eppure è sempre lì, come un fantasma bonario e tranquillo. Bianchi entrambi, li abbiamo visti abbracciarsi davanti all’immancabile elicottero, e addirittura inginocchiarsi in preghiera l’uno accanto all’altro.
Anche il Presidente della Repubblica si è sdoppiato: è succeduto a se stesso. Ha dovuto giurare un’altra volta, e – per quanto sobrio ed essenziale fosse il picchetto d’onore – non ha potuto annullare del tutto la qualità surrealmente inedita dell’intera faccenda. Perché questo presente italiano (non certo per colpa di Giorgio Napolitano) ha sviluppato, negli ultimi tre-quattro decenni, una tale patologica avversione al nuovo e al cambiamento, da rivolgersi immancabilmente verso il passato. Anche quello appena trascorso, al quale dunque viene impedito del tutto artificialmente di trascorrere davvero.
Il risultato inevitabile è che il nuovo ottenuto specularmente dal vecchio, replicandolo, pertiene sempre e comunque al territorio della simulazione. Quando non si vuole e/o non si può decidere su qualcosa, scegliere come risolvere una situazione problematica, la si sospende. La si mette in stand-by. Solo che questo stand-by è esso stesso illusorio: è una pratica anche molto sofisticata di auto-persuasione (ottenuta attraverso un lungo allenamento al distacco totale dalla realtà, e in definitiva dalla vita…), che però non intacca minimamente il flusso degli eventi e della Storia – che continua a scorrere, nella maniera tumultuosa di questi ultimi mesi.

Castel Gandolfo, Papa Francesco visita Benedetto
Si genera così una strana dimensione temporale, in cui passato recente, presente e passato remoto si sostengono a vicenda con lo scopo di resistere al futuro, e alla sua intromissione. È, questa, una dimensione abbastanza mefitica, come quella che descriveva Nathaniel Hawthorne a proposito di Roma: “Qui sembra che l’intero Passato, stanco e desolato, si addossi sulle spalle de Presente. Se dovessi provare un qualche abbattimento in questo paese… se dovessi subire qui una sventura terribile… penso che sarebbe impossibile per me reagire con influenze tanto avverse”.
E d’altra parte, questi sdoppiamenti e rispecchiamenti ci dovrebbero essere piuttosto familiari. Senza scomodare per forza il doppelgӓnger ottocentesco e decadente e la sua forza perturbante (tra Dorian Gray, Lui di Guy de Maupassant e Il Sosia di Dostoevskij), un artista come Giulio Paolini con il famoso Autoritratto del 1968, con Proteo (II) (1971) e con le sue Mimesi ci ha insegnato a guardare attraverso il doppio. In particolare, Autoritratto (che a sua volta discende idealmente da Giovane che guarda Lorenzo Lotto dell’anno precedente) “può riferirsi all’autoritratto di Poussin come a un mio autoritratto: la sovrapposizione, in coincidenza, delle due immagini, è come dire che è inutile e vano inventare qualcosa di proprio (è qui che dubito dell’identità, e del linguaggio di conseguenza) se possiamo scoprirlo nel passato”.
Nell’Italia degli anni Settanta terminali, in Anima persa (1977) di Dino Risi ispirato al romanzo omonimo di Giovanni Arpino (1966), l’ingegnere veneziano-asburgico Fabio Stolz che esercita un ferreo controllo sulla vita sua e della moglie ma che al tempo stesso nasconde il segreto terribile e poetico della propria dissociazione psicotica è una metafora potente del disorientamento di un’intera generazione, alle prese con una società divenuta – non improvvisamente – incomprensibile e ostile.

David Lynch, Mulholland Drive (2001)
Sull’altra sponda dell’Atlantico, nel 1988 Dead Ringers (Inseparabili) di David Cronenberg esplora la spirale autodistruttiva dei due gemelli monozigoti Beverly ed Elliot Mantle, ginecologi affermati, abitati da un progressivo distacco dalla realtà. Dieci anni dopo il modello Victor Ward, protagonista di Glamorama (Bret Easton Ellis 1998) affronta nientemeno che la fine dell’Occidente e della sua cultura, tra riflessi/riflessioni e doppi speculari, in cui gli eventi reali coinvolgono costantemente la loro riproduzione spettacolare, e rimangono in essa invischiati.
Questa relazione tra duplicazione e scissione schizofrenica dell’Io è anche il tema della mitologica videoinstallazione through a looking glass, presentata da Douglas Gordon alla Biennale di Venezia del 1999: seguendo lo svolgersi di un paradigma, il Travis Bickle-Robert De Niro di Taxi Driver (Martin Scorsese 1976) nello specchio inizia davvero a rispondere a se stesso, instaurando una conversazione dagli esiti imprevedibili. Lo spettatore si trova intrappolato esattamente nella ‘linea di fuoco’ tra le due metà identitarie.
Anche il migliore David Lynch in Lost Highway (Strade perdute, 1997) proietta sullo schermo il musicista jazz Fred Madison alle prese con il mistero irrisolto e irrisolvibile della sua trasfigurazione nel giovane Pete Dayton, mentre in Mulholland Drive (2001) approfondisce l’idea narrativa delle personalità multiple: Betty e Rita, che assomigliano sempre più l’una all’altra, perdono l’identità nel momento stesso in cui la cercano.
Dunque, Giorgio Napolitano che si guarda allo specchio e succede a se stesso – accedendo al regno pressoché inesplorato del remake temporale e storico – potrebbe rappresentare l’ennesima incarnazione reale degli immaginari Beverly ed Elliot, Fred e Pete, Betty e Rita. Incarnazione adattata, naturalmente, al presente italiano.
Christian Caliandro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





