Le vite enciclopediche di Gioni
Riceviamo e pubblichiamo: è la formula asettica con la quale le testate diffondono contenuti più o meno interessanti. Ma qui si tratta di Tiziano Scarpa che, a caldo, ci regala le sue impressioni sulla Biennale di Gioni. E noi riceviamo e pubblichiamo.

Ho pochissimo tempo, i giorni del vernissage della Biennale sono così, fra poco partirò per un viaggio e potrò tornare a visitarla fra un mese e mezzo. Lo farò volentieri, perché Il Palazzo Enciclopedico, curata da Massimiliano Gioni, è una mostra piena di meraviglie. Ma intanto sono a casa, è notte, butto giù furiosamente le mie impressioni, le strappo alla stanchezza e alla scorpacciata di cose viste. Eccole qui, in forma di appunti sparsi.
L’enciclopedia come destino impossibile (ma certi artisti ce la fanno)
L’enciclopedia che ha in mente Gioni è un progetto, un’aspirazione, e anche una disperazione. Il mondo è sempre più fitto, più largo, l’esistenza sempre più inadeguata. La sua domanda, mi sembra, è: come fa, un individuo, con una sola vita a disposizione, a esaurire il suo cammino, a percorrerlo tutto, a compiere il proprio destino? Come vivere fino in fondo la propria enciclopedia? Dunque, questa è una mostra esistenzialistica.
Persone che facevano tutt’altro
Insieme a grandi nomi e artisti poco noti, Gioni ha dato spazio a molti artisti involontari. Sono persone vissute nel Novecento che facevano tutt’altro, ma, a un certo punto della loro vita, si sono trovate ad avere a che fare con le immagini. Si sono messe a dipingere, disegnare, fotografare, scolpire, costruire feticci set teatrini loro malgrado, per curare un malessere, liberarsi di un incubo, zittire un demone o dargli voce, e lo hanno fatto in maniera furibonda, sistematica, monomaniacale.
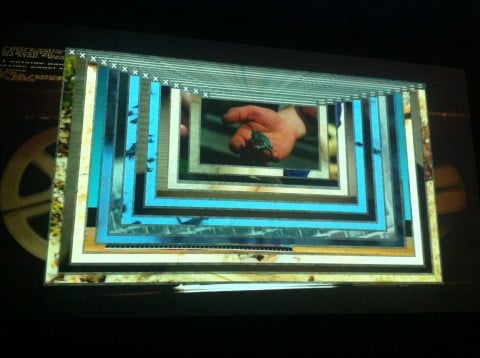
Camille Hernot – Arsenale – Biennale di Venezia 2013
Biografie al posto dell’opera
Visitando Il Palazzo Enciclopedico ci si ritrova a leggere avidamente i testi dei curatori applicati al muro, quasi dei sunti vasariani, per conoscere le vite, sapere la storia di questi artisti per caso (o meglio, artisti per necessità, e perfino artisti per volontà divina). E siccome nella mostra ci sono anche molti artisti professionisti, succede una cosa strana: quando si leggono i testi applicati al muro che presentano le opere degli altri, gli artisti per professione, quasi ci si stupisce che di loro non vengano fornite notizie biografiche, ma solo descrizioni e valutazioni formali delle loro opere: “eh, vedi, questi qui fanno arte per mondane ragioni estetiche, non perché soffrono psichicamente o hanno visioni divine”, non si può fare a meno di pensare con un certo disprezzo. Li si comincia a guardare con diffidenza, come impostori staccati dalla vita, cervellotici, frivoli ricamatori di forme senza fondamento esistenziale.
In due parole (anzi, dodici).
Più che delle opere, Massimiliano Gioni ha messo in mostra degli artisti.
Ancora più in breve
La Biennale di Gioni è l’equivalente delle Vite di Vasari.
Tipi di artisti involontari che si trovano nel Palazzo Enciclopedico
C’è lo psicologo che voleva tenere a bada le sue visioni sconvenienti riempiendo un codice di miniature.
C’è il malato di cancro che pensava di curarsi disegnando.
C’è il filosofo che disegnava con i gessi colorati su fogli neri durante le sue conferenze.
C’è la setta religiosa convinta che i disegni siano un dono divino.
C’è la tradizione secolare di regalare disegni da meditazione.
Ci sono i medium che comunicano con i morti disegnando.
Ci sono artisti che dipingono una tela al giorno come un diario.
Ci sono artisti che disegnano una pagina al giorno come un diario.
Ci sono minatori che un bel giorno ricevono dagli spiriti l’ordine di comprare una tela e riempirla di colori.
Ci sono guaritori che curano con le immagini.
C’è l’antropologo che dà in mano per la prima volta carta e matita a un popolo cosiddetto primitivo.
Ci sono orfani che riproducono alla perfezione bambole iperrealistiche di ragazzine ammiccanti, le tengono nascoste sotto il letto, le tirano fuori per disporle a loro piacimento e fotografarle.
Ci sono fotografi notturni di guardoni nei parchi.
Ci sono odontotecniche depresse che ogni mattina si alzano alle quattro e disegnano per tre ore prima di andare al lavoro.
C’è il ragazzo autistico che dà forma ad animali mostruosi e totem butterati di borchie.
C’è il collezionista caotico di ritagli sfacciati scandalosi bizzarri che li incolla e rilega in volumi spropositati.
Ci sono le mille forme che ha assunto l’iconopatia umana.

Shinici Sawada – Arsenale – Biennale di Venezia 2013
Essere visitati dall’arte (riceverla in regalo)
Ricorre spesso, in queste vite d’artisti senza premeditazione, la situazione di chi ha ricevuto in dono una scatola di colori, una macchina fotografica, un qualche attrezzo da artista, un’ispirazione, una visione, per un intervento esterno, per un suggerimento o invasamento altrui, umano o soprannaturale.
A me però sembrava di sapere una cosa
L’Occidente, tutto sommato, aveva avuto un’idea niente affatto scontata, aveva inventato l’estetica, che è uno spazio dove collocare l’inclassificabile. L’arte è un gesto che non ha motivazioni, che non serve a nulla, almeno per il momento (l’arte è sempre per il momento, se crediamo all’estetica). Non ha fondamento al di fuori di sé, non dà giustificazioni alla sua forma, se non le sue stesse ragioni formali. Qual è lo scopo di un’opera? Qual è lo scopo dell’arte? In questa mostra gli scopi, i motivi, le cause sono tutti spiattellati in primo piano. Qui non si fa arte per motivazioni estetiche (né carrieristiche), ma per dolore, fede, conoscenza, problemi personali, sciagure private.
L’opera sintomo e cura
La mostra di Gioni tende a patologizzare il gesto artistico. L’opera è sintomo e cura dell’artista. L’opera non è più un’espressione che si svincola da chi l’ha fatta, ma resta conficcata nella condizionedell’artista. Le opere, qui, ci parlano innanzitutto della situazione biografica (spesso sofferente) di chi le ha prodotte, e di come hanno tentato di uscirne attraverso le immagini. Oppure di come le immagini hanno stravolto la vita di queste persone. È una mostra di iconopati.
Quando l’arte serviva a non servire a niente (o: che ne è dell’arte senza l’estetica?)
L’arte mostra la condizione di chi la fa, o è un’espressione che trascende chi la fa? L’estetica ha scelto questa seconda via, è lo statuto che si è dato l’Occidente, e di cui l’Occidente sembra non poterne più: ormai ne diffida, ha la tentazione di tornare a usi meno ineffabili, meno estetici, per riprendersi le ragioni pratiche, l’utilità solida, la necessità esistenziale di ogni azione umana.

La maschera di André Breton – Arsenale – Biennale di Venezia 2013
Il surrealismo, infatti
(Infatti in questa mostra fa spesso capolino il surrealismo, che, per quanto ne so io, è l’avanguardia più kitsch, più pompieristica, la più contenutistica: delle avanguardie storiche, è quella che meno di tutte ha messo in questione le forme della tradizione, anzi, le ha utilizzate strumentalmente per agevolare l’eruzione di visioni e detti involontari. Anche gli scrittori surrealisti sono quelli che più di tutti ossequiano la sintassi, lasciandola così com’è per farla attraversare da un brivido semantico: la scrittura automatica surrealista è obbedienza alla sintassi, è uso della sintassi come acquedotto, è il linguaggio come tubo per lasciar passare contenuti involontari. Il postsurrealista Queneau ha raccolto i fous littéraires, megalomani o mattoidi che scrivevano trattati deliranti. Gioni raccoglie artisti involontari che, al di fuori dell’estetica e delle sue regolamentazioni, sono liberi di spaccare forme, o di patirle inconsapevolmente, di reinventare o riscoprire arcinote forme tradizionali, dimenticate, improponibili, affascinanti, commoventi, potenti, fresche, allucinanti, stucchevoli…)
Il sarto del Tennessee (le vere gerarchie celesti, raccontate da chi in paradiso c’è stato)
“Shakespeare era un profeta?”
“Certamente: e così Omero e tanti altri. Ma Shakespeare e tutti i profeti della sua specie devono cedere il passo a un semplice sarto del Tennessee, di nome Billings, e a un veterinario dell’Afghanistan, di nome Sakka. Geremia, Billings e Budda procedono l’uno di fianco all’altro; dietro viene un folto gruppo di persone provenienti da pianeti che non fanno parte del nostro sistema astronomico; seguono, poi, un paio di dozzine di personaggi appartenenti al pianeta Giove e ad altri mondi. Quindi è la volta di Daniele, Sakka, Confucio, Ezechiele, Maometto, Zoroastro e un arrotino dell’antico Egitto. Segue un’altra filza di persone in coda alla quale si trovano Shakespeare, Omero e un calzolaio di una colonia francese, chiamato Marais.”
[…]
“Ma perché collocano Shakespeare tanto in basso, in compagnia di semplici e sconosciuti calzolai, veterinari e arrotini?”
“Effetto della giustizia divina. In terra non hanno avuto una ricompensa adeguata ai loro meriti, ma qui occupano la posizione che loro compete. Billings, il sarto del Tennessee, scrisse poesie che Omero e Shakespeare non avrebbero potuto nemmeno lontanamente uguagliare, ma nessuno volle pubblicarle, nessuno le lesse salvo i suoi vicini di casa, gente ignorante, che ne risero. Ogni volta che nel suo villaggio c’erano simposi e divertimenti, Billings era trascinato nella folla e incoronato di foglie di cavolo, mentre tutti gli facevano, per schernirlo, grandi inchini. Una notte che Billings era malato e quasi morto di fame, lo trascinarono fuori di casa e dopo averlo incoronato lo portarono in trionfo per il villaggio, seguito da tutto il paese che urlava e percuoteva padelle. Morì prima dell’alba. Egli non pensava neppure di salire in cielo, né che l’attendessero grandi onori. Fu molto sorpreso, ricordo, delle accoglienze ricevute.”
Mark Twain, Viaggio in Paradiso, trad. di Maria Celletti Marzano, Passigli.

Fischli & Weiss – Arsenale – Biennale di Venezia 2013
Non mi piace la parola “ossessione”
Ossessione è una parola che non mi piace, la trovo logora e liquidatoria. Più che sull’ossessione, direi che la mostra di Gioni si fonda sulle serie, sui produttori di serie, e la serialità è elegante; la ripetizione lievemente differente, che prende forma via via in ogni serie fatta a mano, crea inevitabilmente una stilizzazione, un’armonia di ritornelli che ritornano e fanno tornare i conti, un’artisticità.
Bau e miao
Gli artisti sono come i cani, e le opere sono come il loro bau. Gli artisti sono come i gatti, e le opere sono come il loro miao. L’espressione (l’opera) non riesce a trascendere chi l’ha fatta, non riesce a dilagare nell’estetico (che altri, un tempo, chiamava ardimentosamente l’universale), e ci parla solo della situazione in cui si trovava chi l’ha fatta. Ma l’estetica aveva provato a considerare i vari bau e miao in sé stessi, ritagliandoli via da chi li emetteva, dimenticando volutamente da quale animale uscissero.
Però
Non è del tutto vero: dicendo così, sto facendo torto a molte opere (tra l’altro splendide, indimenticabili) che Gioni ha scelto. Nonostante siano il frutto di sofferenze psichiche e altre miserie individuali, riescono a toccare zone lontanissime dalla condizione esistenziale di chi le ha fatte, forme svincolate da qualunque riferimento biografico: questa mostra è piena di gattacci randagi che, sorprendentemente, sono stati capaci di tirare fuori da sé il verso di un gallo o il ruggito di una tigre. Cani bastardi e di razza che, a dispetto dei loro mezzi, a dispetto di sé stessi, hanno barrito o cinguettato. Persone sofferenti o coltissime, povere o scaltre che hanno potuto oltrepassare sé stesse e sfociare altrove attraverso le loro opere, nelle loro opere.
E se Gioni li avesse trattati come artisti e basta?
Forse, sarebbe stato opportuno rendere giustizia a quelle opere tacendo la vita di chi le ha fatte? Evidentemente, in questoPalazzo Enciclopedico l’opera consiste nella distanza, e nella misurabilità di questa distanza, che viene messa in mostra attraverso i cartellini biografici incollati ai muri. Si misura la distanza fra il gatto randagio e il suo sontuoso chicchirichì, fra il minatore belga e i suoi prodigiosi exploit pittorici…

Roberto Cuoghi – Arsenale – Biennale di Venezia 2013
Niente da fare, incappo nella solita satira
Cinicamente, si potrebbe dire che anche gli artisti professionisti fanno arte per trascendere la loro condizione, cioè per salire di classe, per passare da poveri a ricchi, da sconosciuti a famosi. Vorrei riuscire a essere più serio, per una volta, vorrei provare a capire, e non fare soltanto satira, come succede sempre con l’arte contemporanea.
Vuoi vedere che anche loro…?
Qui sono messi nello stessa mostra artisti per necessità e artisti per estetica, cioè artisti autentici e artisti professionisti. La controspinta che gli artisti per necessità gettano sugli artisti per estetica è che li fanno apparire velleitari, egoisti, frivoli, ambiziosi. Nei casi migliori, insinuano il sospetto che anche gli artisti professionisti possano essere artisti autentici, necessari, cioè avere una qualche patologia, una sofferenza non dichiarata, altrimenti non si spiegherebbe come possa uno, per quanto strapagato, passare il suo tempo a modellare per tutta la vita centinaia di statuette o a disegnare migliaia di vignette, perché fama e soldi non bastano a giustificare quella fissazione. Ci dev’essere qualche magagna personale, dietro quelle opere. [I due riferimenti sono alle statuette degli svizzeri Fischli & Weiss, e alle tavole originali del libro del Genesi illustrato da Robert Crumb, solo due esempi fra le decine di meraviglie che si possono vedere in mostra].
Il simbolo del Palazzo Enciclopedico
Forse, una piccola opera potrebbe essere il simbolo involontario di questa mostra. È una sculturina di Enrico David: c’è un uomo in piedi, con il torace scavato quasi come una piroga. Dall’inguine gli scende a terra una lama-sesso che, insieme alle gambe, lo regge come un treppiede. Guardando meglio si comprende che quella scultura è una specie di coltello a serramanico antropomorfo. La lama si può far ruotare e richiudere ripiegandola sul torace dell’uomo. E infatti, la prova è che c’è un solco che arriva al mento e alla bocca dell’uomo, per accogliere la punta della lama quando il coltello è chiuso. La mia morale della favola, anzi, la mia favola è che quell’uomo scopre di essere uno strumento. Non è un uomo, è un coltello a serramanico, e la lama del coltello gli ferisce la bocca, che non è più soltanto un solco orizzontale per esprimersi, diventa anche un solco verticale per far funzionare lo strumento. Perciò, stanotte, dopo aver fatto questa prima rapida visita al Palazzo Enciclopedico di Gioni, scelgo quella statuetta come simbolo dell’intera mostra: perché nel Palazzo Enciclopedico sono presentati artisti-strumenti, artisti che vengono utilizzati dalle immagini, che patiscono l’uso delle immagini, le subiscono, ne diventano gli attrezzi, e diventano immagini essi stessi. In un certo senso, Massimiliano Gioni ha fatto una mostra di design, più che di opere d’arte. Non design industriale, ovviamente, ma design individuale di opere-strumenti, serializzate come il design, fatte da artisti-strumenti. Gli artisti hanno prodotto immagini-strumenti per trascendere sé stessi; le immagini hanno fatto irruzione nelle loro vite, rendendo quelle vite funzionali alle immagini stesse, rendendole strumenti delle immagini. Una mostra di immagini seriali, foto seriali, dipinti seriali: una specie di infinito prototipo per dare forma all’attrezzo giusto, che non verrà mai realizzato, perché consiste nell’accumulo della serie, nel proprio destino percorso passo passo, opera dopo opera, fino in fondo.

Paul McCarthy – Arsenale – Biennale di Venezia 2013
Paragrafo che si può saltare perché contiene preconcetti che poi, s’è visto, non c’entravano niente. Anzi, quasi quasi lo metto in fondo, come appendice, non lo butto perché tutto sommato non mi dispiace
Prima di vedere la mostra, immaginavo che il titolo, Il Palazzo Enciclopedico fosse un pretesto per mettere dentro un po’ di tutto. Mi chiedevo come avrebbe fatto Gioni a presentare qualcosa che fosse all’altezza dei nostri tempi, dove l’enciclopedia è in atto (indovinate dove), e si è realizzata nella forma di un continuo doppio fondo; l’essenza dell’enciclopedia contemporanea è il link immediato: è il luogo dove non si può sostare perché rimanda a un altro luogo, che ne rimanda a un altro; è la parola crivellata, sfondata dal link (mentre l’essenza dell’enciclopedia illuminista era il vedi, il cfr., il rimando con l’icona della manina a indice puntato: ma intanto si rimaneva sulla stessa pagina, e il testo proseguiva indisturbato). Ma le stanze dei palazzi, gli interni dei padiglioni e la loro fuga di stanze, non ce la fanno a essere enciclopedici, non hanno link. Le stanze, tuttalpiù, possono mettere insieme alcune opere affini (o contrastanti), per evidenziare l’affinità (o il contrasto) attraverso la compresenza, o l’adiacenza fra stanze. I palazzi, i padiglioni, le stanze, al massimo hanno disposizione delle soglie, che sono pur sempre esperienze spaziali, mentre il link è una catapulta sull’altrove, ti fa schizzare in tutt’altro contesto, in tutt’altro mondo: altro che stanza adiacente. Come farà Gioni a presentare un’enciclopedia veramente contemporanea, con una mostra, non avendo link?, mi chiedevo prima di entrare. Per fare un’enciclopedia ci vorrebbe un’architettura anarchitettonica, dove le opere stesse fossero soglie, fossero link transpaziali ad altre opere. Questo mi dicevo. Poi ho visitato Il Palazzo Enciclopedico e ho visto che le mie erano speculazioni che non c’entravano niente con questa mostra.
Tiziano Scarpa
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati




