L’ossessione per la storia. Fra Teheran e Barcellona
Una riflessione sulle somiglianze tra il Teheran Museum of Contemporary Art e la Fundació Joan Miró. Fatta da un architetto, Francesco Napolitano, che ha visitato entrambi recentemente, e ne ha scoperto affinità e divergenze. E soprattutto un richiamo alla situazione italiana.

Alle persone piacciono i luoghi più diversi: per esempio ci sono quelli che vanno matti per i mercati o i bazar perché gli piace contrattare, altri sono a loro agio nelle biblioteche e altri ancora negli alberghi. Io amo le caffetterie dei musei d’arte contemporanea. Non c’è luogo al mondo in cui sono più contento, specie se si tratta di un’architettura d’autore. Ma più di qualunque altra cosa adoro le persone che ci stanno dentro. Forse è a causa di un recondito senso di inferiorità, però mi appaiono ogni volta bellissime, educate e intelligenti: non parlano mai a voce alta e sembra sempre che non siano lì per caso, ma per discutere di chissà quali importanti argomenti legati al mondo delle immagini e delle idee. La verità è che mi fanno stare bene perché fanno sentire migliore anche me: sono onorato di essere lì con loro. Non è tanto importante che il museo sia famoso, non accade solo nella caffetteria del Palais de Tokyo o della Tate Modern. Ad esempio, è da poco successo in quella del museo d’arte contemporanea di Teheran.
L’edificio è un’opera di un importante architetto, Kamran Diba, uno dei padri del modernismo iraniano prima della rivoluzione e costretto all’esilio dopo di essa. Non conoscevo l’edificio e a dir la verità non riponevo grandi speranze nel museo della capitale iraniana, che invece alla fine mi ha smentito: l’architettura di Diba al Teheran Contemporary mi ha convinto.

Fundació Joan Miró
Così, mentre me ne stavo lì seduto ad ascoltare i miei vicini parlare in farsi e a immaginare in quei suoni sconosciuti un’incredibile discussione tra Aby Warburg ed Erwin Panofsky, mi sono chiesto perché quel museo mi fosse piaciuto. David Hume riteneva che ci siano due costanti nell’apprezzamento di un’opera d’arte: la novelty e la facility. Mentre il meccanismo della novità è facilmente intuibile, la facility corrisponde a quella conoscenza anticipata dell’opera, talvolta anche inconscia, che ci mette nella predisposizione d’animo di poterla apprezzare. Nel mio caso, proprio questo secondo criterio è stato il viatico per avvicinarmi all’opera di Diba, e mentre bevevo il mio caffè ho finalmente messo a fuoco che gli elementi architettonici principali del museo, e cioè: i lucernari curvi a periscopio che caratterizzano tutte le sale sono identici a quelli del Fundació Joan Miró di Barcellona, disegnati da Josep Lluís Sert. L’unica differenza è che, mentre i primi sono orientati tutti a nordest, a Barcellona si affacciano indifferentemente nelle quattro direzioni; per il resto sono praticamente indistinguibili. Ora, la Fundació Joan Miró è del 1975, il Teheran Museum of Contemporary Art del 1977: una somiglianza così spiccata può far pensare a una citazione, per non dire a una copia o a un plagio.
Quando ne ho fatto menzione ai miei colleghi iraniani, hanno invece obiettato ripetendomi lo stesso argomento, come se fosse una comune reminiscenza del loro esame di storia dell’architettura contemporanea: per disegnare quei lucernari Diba si era ispirato alla struttura delle torri del vento, classico elemento dell’architettura vernacolare persiana. In realtà importa poco chi ha copiato chi: è vero che il museo di Barcellona è precedente a quello di Teheran, ma è anche vero che l’idea di Gropius per i lucernari del Bauhaus-Archiv (anch’essi curvi e a periscopio) è precedente a quella di Sert. La cosa veramente interessante è che, nel rispondermi in questo modo, ho notato nelle voci dei miei colleghi una punta di nazionalismo. Il concetto felice al quale in quel momento si aggrappavano non riguardava solo l’originalità dell’opera di Kamran Diba, ma la difesa delle radici della loro architettura moderna, del suo diritto a poter attingere a un repertorio ideativo antichissimo e della sua capacità di farlo senza scadere nello storicismo decorativo.

Hossein Zenderoudi, Numbers
Se l’opera di Sert risponde ai criteri di una internazionale modernità, il museo di Kamran Diba contempla l’utilizzo di diversi riferimenti all’architettura persiana, rivelando un simbolismo dimenticato, come avrebbe detto Robert Venturi. Ad esempio, nel Museo Miró l’orientamento dei lucernari dipende dalla necessità di variare la quantità di luce che piove sulle opere, mentre nel Teheran Contemporary questa luce ha un significato puramente spirituale; la pianta del museo di Barcellona ha uno sviluppo organico, al contrario la struttura planimetrica del museo di Diba, pur conservando il patio, utilizza uno spazio fortemente centrale (come quello di una moschea) collegato a un percorso lineare ruotato di 45 gradi rispetto all’asse del giardino, come nel complesso architettonico della piazza centrale di Isfahan, riferimento prioritario di tutti gli architetti iraniani.
Il discorso è identico per quanto riguarda le opere esposte all’interno, come se ci fosse un’identità assoluta tra contenuto e contenitore. Prendiamo ad esempio Numbers di Hossein Zenderoudi, una delle opere della mostra Saqqakhaneh Movement che il museo ospita in queste settimane. I numeri corrono sulla tela uno dietro l’altro in una serie infinita: potrebbe sembrare un’opera di Roman Opalka alla quale è stato aggiunto un tocco di colore di spezie orientali e di calligrafia.

Teheran Museum of Contemporary Art
L’arte, come l’architettura, abbandona la candida e internazionale austerità del bianco e mette in primo piano alcuni elementi che la rendono inequivocabilmente persiana. Le opere di Sert e Opalka sembrano moderne mentre quelle di Diba e Zenderoudi sembrano mediorientali: questo accade perché nelle seconde i riferimenti alla storia sono diretti.
Eppure non è possibile dire che il museo non sia un bel pezzo d’architettura moderna, e il punto è proprio qui: il movimento moderno stesso fu fondato sulle influenze estremorientali, eppure noi architetti occidentali fatichiamo ad apprezzare un edificio orientale che si riferisca in modo diretto alla propria storia. Nel giudicare questo genere di opere siamo stati in molti casi forse un po’ troppo ortodossi, per rubare ancora un termine a Venturi. Forse il nostro giudizio impietoso dovrebbe applicarsi anche a quelle serie infinita di facciate architettoniche italiane, piene di finestre quadrate ben infilate l’una sull’altra, magari con un infisso cruciforme, disegnate puntigliosamente nella vana speranza di raggiungere la divina proporzione di Leon Battista Alberti. Non ci troviamo anche in questo caso di fronte a un riferimento diretto alla storia? Mi viene in mente il titolo di un famoso libro: Complexity and Contradiction in Architecture.
Mi rendo conto di quanto sia impopolare (e pericoloso) citare oggi il pensiero di Venturi e non è mia intenzione difendere o sposarne le dirette conseguenze in architettura. Dico solo che, a pensarci bene, noi italiani abbiamo fatto della storia l’elemento che “in modo più o meno ambiguo ha caratterizzato il decorso della ricerca italiana” (Tafuri): possiamo davvero permetterci di essere così snob da storcere il naso di fronte a un edificio come quello di Kamran Diba? Prima di lamentarci per gli esiti altalenanti della nostra architettura, abbiamo fatto i conti con la nostra ossessione per la storia?
Francesco Napolitano
 1 / 9
1 / 9
 2 / 9
2 / 9
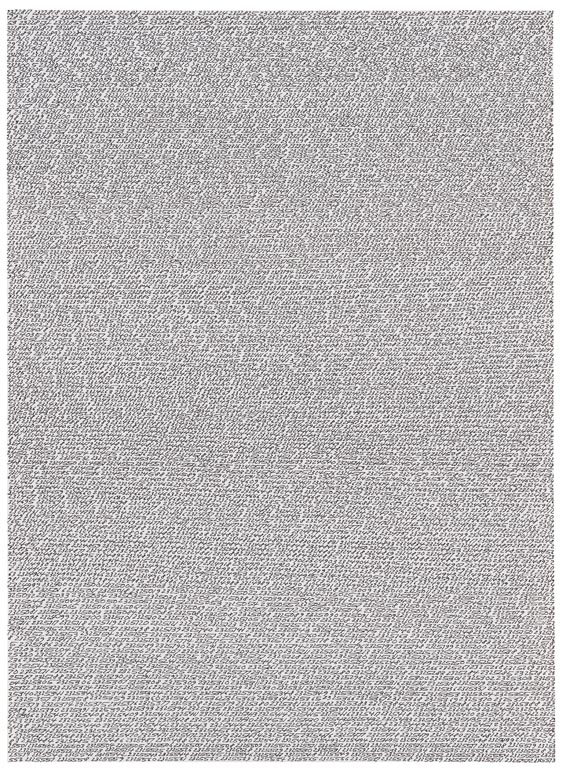 3 / 9
3 / 9
 4 / 9
4 / 9
 5 / 9
5 / 9
 6 / 9
6 / 9
 7 / 9
7 / 9
 8 / 9
8 / 9
 9 / 9
9 / 9
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati














