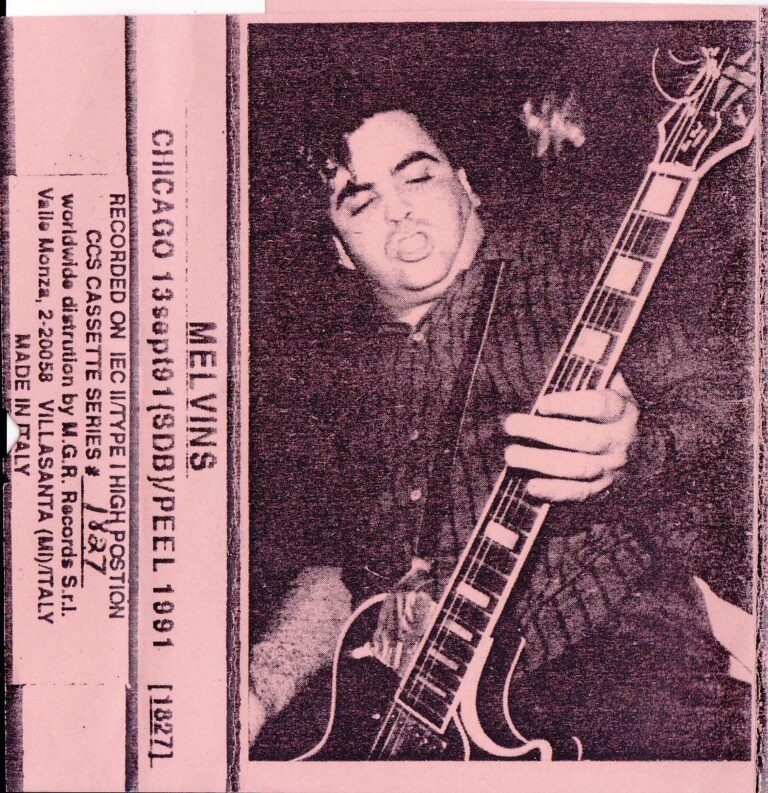Sottoculture esistite & sottoculture abortite
Cosa significa sottocultura? E perché oggi è praticamente impossibile che se ne formino di nuove? Il nuovo scenario culturale è fatto di un proliferare di nicchie, che raramente (se non mai) raggiungono un livello di popolarità tale da farle approdare alla storia della cultura. In Italia, invece è esistita una sottocultura tutta particolare…

I think it’s very sad that in referencing something
that happened 25 years ago, as not as if there’s a revival
of the intellectual concepts, with the visions, or the diversity
or the extremity of that music, but it’s a homogeneization,
it’s gentrification, and it’s a softening. It just feels soft. It feels…
mooshy. There’s nothing… important, that they’re doing.
Lydia Lunch in Kill Your Idols (Scott Crary, 2004)
La sottocultura nel mondo anglosassone viveva su una tensione fondamentale: da una parte essa si opponeva alla cultura mainstream, calata dall’alto, e rappresentava qualcosa di autogenerato, prodotto integralmente dal basso; d’altra parte, ogni sottocultura tendeva naturalmente verso il mainstream, a ciò che in altri ambiti e regimi discorsivi si definirebbe “il successo”.
È lo schema che Tom Wolfe in Come ottenere il successo in arte (The Painted Word, 1975) definiva “danza BoHo”, riferendosi alle avanguardie e alle neoavanguardie artistiche (e il legame è abbastanza naturale e immediato, dal momento che per molti versi le sottoculture sono gli eredi legittime delle avanguardie: l’avanguardia non finisce né muore tra anni Sessanta e Settanta, ma semplicemente salta, esorbita dal territorio di partenza verso la cultura di massa): BoHo deriva dalla fusione di Bohémien e SoHo, e Wolfe voleva dire che l’artista oscilla sempre tra retoriche rivoluzionarie e aspirazioni di altro genere (SoHo era rapidamente diventato, all’epoca, il quartiere newyorkese più alla moda). Inoltre, occorre tenere presente un processo abbastanza ovvio, ma che spesso ci sfugge: nel periodo che le riguarda (cioè tra gli anni Sessanta dei Mod e i primi anni Novanta del grunge, passando per psichedelia, glam rock, punk, post-punk, new wave, hip-hop, techno), le uniche sottoculture che conosciamo sono quelle che hanno compiuto il salto decisivo verso il mainstream, il livello di massa; senza questo passaggio (storico, culturale, economico e biografico), la sottocultura si estingue anche nella percezione collettiva, perché riguarda al massimo il centinaio o il migliaio di persone che ne hanno fatto parte. Nessuno la ricorderà.
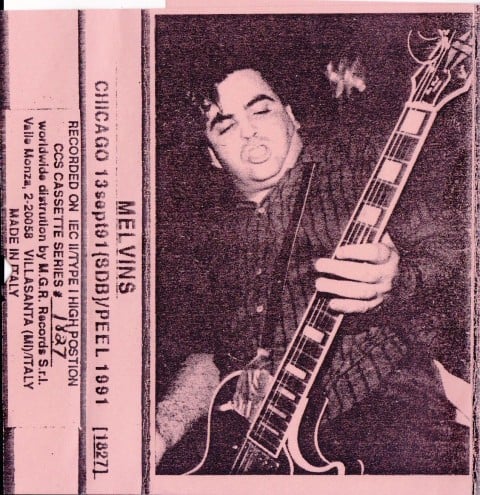
Melvins 1991
E invece è abbastanza magico che, per esempio, un genere musicale nato in pochissimi locali-non locali della città più squallida, desolata e isolata degli anni Ottanta americani (Seattle) e ascoltato dagli stessi che lo praticavano e lo inventavano praticandolo abbia oltrepassato gli angusti confini della penisola di Olimpia e abbia raggiunto adolescenti e preadolescenti di tutto il pianeta (me, per esempio, dodicenne nell’estremo Sud Italia). Grazie all’impatto sulla cultura di massa, la sottocultura non solo oltrepassa i suoi confini spazio-temporali, ma estende la sua stessa percezione, in ampiezza e profondità: così, attraverso i Nirvana posso conoscere e apprezzare i Melvins, gli Screaming Trees, gli Husker Dü, gli Alice in Chains, i Mudhoney, i Tad; oppure passando per i Cure e i Depeche Mode posso raggiungere Joy Division, Siouxsie and the Banshees, Dead Can Dance, Alien Sex Fiend, Wire e Young Marble Giants.
Il vero problema è che dopo la morte del grunge (1994) praticamente non ci sono più state vere e proprie sottoculture. In un bellissimo documentario di Scott Crary del 2004, Kill Your Idols, il musicista Arto Lindsay commentava così il confronto tra la scena musicale newyorkese dei primi anni Duemila e quella tra fine anni Settanta e inizio anni Ottanta: “la questione è che qui c’è una generazione che viene venduta a se stessa”. Dirlo più precisamente di così è quasi impossibile: l’idea che negli ultimi vent’anni non siano riconoscibili forme di produzione culturale ‘resistente’, che non ci sia stato più nessun ‘sotto’ o ‘fuori’ ma solo un gigantesco, unico ‘dentro’ (fatto unicamente di quelle che, con toni entusiastici, nel 2006 Chris Anderson ha definito nicchie…) è abbastanza inquietante. E invece molto pochi sono inquieti e inquietati.
Il nostro Paese non ha prodotto sottoculture per una serie di motivi storici molto profondi. Innanzitutto, la violenza politica degli anni Settanta ha funzionato da gigantesco buco nero, che ha risucchiato anche tutto quanto di buono si è prodotto in quel periodo. Da un certo punto di vista, è come se in quel momento si fosse stabilita una connessione davvero molto pericolosa e perniciosa tra il conflitto fisico e qualunque forma di conflitto culturale, senza il quale non può esistere alcuna reale innovazione: una connessione che si è estesa nei decenni e che perdura ancora oggi, in forme persino più rigide e inespugnabili. Questo è stato ed è il problema principale che abbiamo davanti.

Siouxsie and the Banshees
Mi ha sempre molto stupito, inoltre, il modo in cui i nostri genitori ascoltavano musica: da una parte Gianni Morandi, Mino Reitano, Little Tony; dall’altra, una serie di cantanti e di gruppi che “interpretavano” le canzoni di band inglesi (King Crimson, The Moody Blues, giusto per fare un paio di esempi) rendendole però monche, eliminando e tagliando cioè le parti strumentali progressive, cioè proprio quelle più interessanti. Se ci pensiamo, visto da oggi questo fenomeno è abbastanza incredibile. E però ci dice qualcosa di importante: c’è sempre questa idea che il pubblico italiano non sia adatto all’intelligenza, alla critica, alla complessità. Si è creato così un ritardo mostruoso in termini di idee e di elaborazione culturale.
Persino se indaghiamo, anche solo superficialmente, i dischi e i gruppi che le famose radio libere mandavano in onda attorno al mitologico ‘77, cominciamo a comprendere molto bene questo aspetto: Led Zeppelin, Deep Purple, David Bowie, Pink Floyd per i più raffinati.
Ora, possiamo dire che in altri territori – arte visiva, cinema, letteratura – eravamo più avanzati a quell’altezza temporale, ed è in gran parte vero. In particolare, il cinema della grande commedia italiana, per così dire, terminale, quella compresa tra primi anni Settanta e l’inizio del decennio successivo, ha tutte le caratteristiche di una vera e propria sottocultura, tranne una, quella fondamentale: la gioventù. È l’unica sottocultura, infatti, prodotta da cinquantenni. I registi cinquantenni di allora (Risi, Monicelli, Scola, Fellini, Comencini, ecc.) risultano a quell’altezza molto più abrasivi, affilati, brillanti e crudeli rispetto ai colleghi e agli intellettuali trentenni (i sessantenni di oggi). È qualcosa di molto strano. Che si spiega in gran parte con la natura di quei trentenni, individuata benissimo prima da Pasolini (negli Scritti corsari e nelle Lettere luterane) e poi da Arbasino (in In questo Stato e soprattutto in Un paese senza): una natura che, contrariamente alle retoriche rivoluzionarie e anticonformiste sbandierate e brandite per anni, era fortemente orientata all’omologazione, all’assenza di originalità, accompagnate dalla presunzione e dalla fragilità estrema dei risultati creativi. Tutte queste caratteristiche non sono mai venute meno, ma si sono sviluppate, dando gli effetti che tutti abbiamo sotto gli occhi. Mario Monicelli ha espresso questa condanna senza appello, che mi sembra valida ed efficace ancora oggi perché ispirata a un altissimo senso storico: “Ci ha fregato il benessere. La generazione che l’ha toccato per prima si è illusa che fosse eterno, inalienabile. Invece era stato conquistato dai padri con sofferenza e sacrificio. Così l’ha dissipato senza trovare la formula per rinnovare il miracolo, e gli eredi di quel gruppo umano hanno deluso le aspettative ad ogni livello. Gente senza carattere, priva di ambizioni, sommamente pretenziosa e basta.”
Christian Caliandro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati