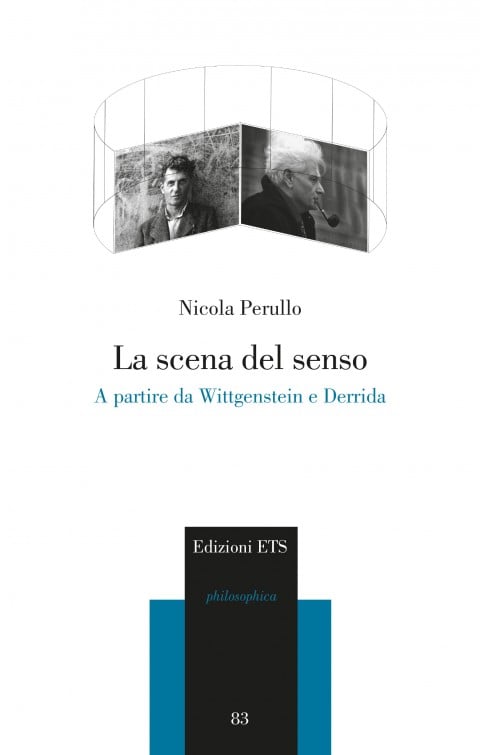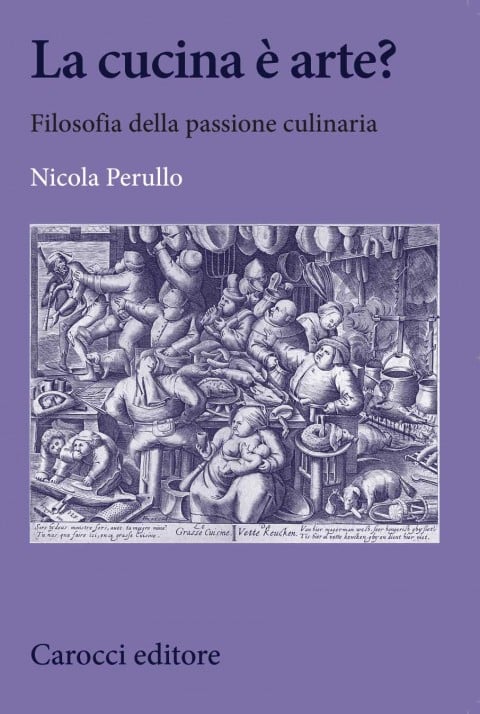Dialoghi di Estetica. Parola a Nicola Perullo
Nicola Perullo insegna Estetica e filosofia del gusto, Etica ed estetica del cibo all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in provincia di Cuneo. Il rapporto tra filosofia e senso, il gusto inteso come esperienza, la cucina come arte: sono i principali temi affrontati in questo nuovo Dialogo di Estetica. All’insegna della riflessione filosofica sul gusto e sul cibo.

Le ricerche di Derrida e Wittgenstein sono all’origine delle tue riflessioni sulla “scena del senso”. Quali sono gli esiti di questa indagine sul rapporto tra filosofia e senso?
Credo che il mio modo di fare filosofia sia l’esito eclettico di un processo che si è mosso principalmente lungo un quadrilatero eccentrico. Al primo angolo si colloca Wittgenstein, forse il mio più profondo amore filosofico non diretto, insieme a Montaigne (io distinguo – lo sottolineo perché per me una distinzione rilevante – tra coloro dai quali ho appreso “in carne” e coloro dai quali ho appreso “in spirito”). È innanzitutto grazie a Wittgenstein che ho elaborato la nozione di “scena del senso” intesa come la costituzione ecologica dei significati, dei concetti, delle idee e delle azioni, insomma dell’esperienza tout court. Da Wittgenstein ho assunto l’idea che, letteralmente, nulla abbia senso fuori dalla scena in cui ciò accade: nessun metalinguaggio, nessuna oggettivazione, nessuna comprensione; e comprendere questo richiede un’adesione complessiva, non solo teoretica ma anche psicologica. Si arriva per questa via al tentativo di descrivere cosa vuole dire comprendere l’esperienza dall’interno, per dir così. In questo senso, nello stesso contesto ho parlato anche di “vedere il tempo” come concrezione iconica dell’esempio. Ed è forse questo il tema filosofico che mi ha più interessato e a cui sono stato più fedele fin dai primi studi universitari.
Al secondo angolo immaginiamo ci sia Derrida…
Sì, Derrida – che insieme a Gargani è stato invece il mio più importante “maestro” diretto – rappresenta il secondo angolo del quadrato. Ho collegato la decostruzione all’idea di “scena del senso” intesa come irriducibilità dell’esperienza, poiché l’ho sempre compresa come una filosofia del “dipende”: per Derrida i testi sono tessuti, processi; dunque tutto è contesto e relazione, e ciò significa impossibilità dell’ultima parola definitiva e della teorizzazione assoluta. A mia volta, ho posto in relazione tale modello filosofico con la nozione appresa da Gargani (quindi un’ulteriore elaborazione da Wittgenstein) di “attrito del pensiero”. Vale a dire: la scena del senso è ciò che impedisce ogni saturazione dell’esperienza da parte del pensiero, e a maggior ragione da parte della filosofia, che diviene così essenzialmente una continua paideia percettiva. Comprendere l’esperienza significa dunque allenarsi a una percezione sdoppiata, al tempo stesso “intenzionante” e referenziale (non si nega la distinzione tra vero e falso, per esempio) ma senza possibilità di alcuna epoché (ogni distinzione ha senso dentro una scena, un’ecologia della percezione e della significazione).
Nelle stesse pagine hai scritto che la filosofia ha senso “se il filosofo fa costantemente aderire le proprie idee allo stato effettivo della sua condizione esistenziale”. Possiamo intendere questa riflessione anche come una delle principali premesse della tua filosofia del cibo?
Da un certo punto di vista sì. Mi sono interessato di cibo per caso, molto prima di avvicinarlo filosoficamente. Per quasi dieci anni sono stato un appassionato e poi un connoisseur, solo dopo è fiorita l’urgenza teorica. D’altra parte, l’adesione a un modello come quello che ho descritto non consente alcuna separazione rigida tra vita e opera, per dirla in modo molto secco. D’altra parte, ciò è stato esplicitamente teorizzato, tra gli altri, sia da Wittgenstein che da Derrida, il quale ha proposto anche di intendere ogni filosofia come una “egodicea”. Questo non significa affatto sminuire il discorso filosofico; ma, certo, scegliere di collocarlo all’interno di una concezione precisa, che è quella, appunto, del valore imprescindibile della storia e dell’esperienza (sia come Erfahrung che come Erlebnis).
Arriviamo allora al terzo angolo del quadrato.
Il terzo angolo del mio “quadrato filosofico” è il pragmatismo, che ho scoperto prima con Rorty, poi con Dewey, Cavell e Shusterman. Al di là di alcuni limiti che intravedo in queste posizioni (tra loro peraltro diverse), il pragmatismo mi è stato, pragmatisticamente, molto utile per il superamento delle opposizioni gerarchiche fondanti di certi modelli filosofici (mente/corpo, natura/cultura, bisogno/desiderio, strumentale/disinteressato ecc.). D’altra parte, Derrida aveva parlato della grammatologia anche nei termini di una “pragmagrammatologia”. Per una buona filosofia del cibo, il superamento di quelle gerarchie è un presupposto architettonico indispensabile.
E infine?
L’ultimo angolo del quadrilatero riguarda il mio interesse per le pratiche empiriche, per la “filologia” in senso vichiano. Sono molto interessato all’antropologia, e in particolare a Tim Ingold, un autore che trovo straordinariamente fecondo e che meriterebbe più attenzione da parte dei filosofi.
Il tuo interesse in direzione di una rivalutazione filosofica dell’ordinario, mi sembra ancor più decisivo per gli sviluppi attuali delle tue ricerche: come si caratterizza la filosofia che, tornando all’ordinario e alla sua esperienza, ha per oggetto d’indagine il cibo?
Ci sono diversi modi in cui la filosofia oggi si occupa di cibo. Io propongo una filosofia che si caratterizza per quella che definisco strategia di abbassamento. Cerco di elaborare non (solo) una filosofia del cibo ma col cibo. Con ciò intendo un pensiero che si ri-disegna e mette in discussione attraverso l’esperienza, specifica e irriducibile, dell’incorporazione fisica. Il cibo è l’unico pezzo di mondo – l’unica porzione di materia – che realmente incorporiamo, secondo ritmi e cadenze quotidiane e ordinarie. Ora, questo lo hanno notato molti filosofi – per limitarci solo ad alcuni tra i più noti: Nietzsche, Feuerbach, Lévinas – ma assai di rado, per motivi storici, si è andati verso una filosofia pensata, fatta e assimilata attraverso il cibo. Oggi, nelle condizioni storiche date che permettono quest’elaborazione, io cerco di prendere sul serio tutto ciò per cominciare a trarne possibili conseguenze. Più vado avanti, più mi accorgo di quanto il cibo – come nutrizione, gastronomia, dietetica, assimilazione, metabolismo – ci offra non soltanto occasioni di riflessione, ma un proprio modello teorico ricco e quasi inesauribile. Per questo penso che occuparsi di cibo nel senso della filosofia “pop”, rivendicando cioè questo studio con l’interesse per il “frivolo”, e trattandolo di conseguenza un po’ distrattamente, trapiantandovi teorie e schemi elaborati altrove (e molto spesso sulla base del paradigma della percezione visiva) sia sbagliato, nel metodo e nella sostanza.
Una filosofia col cibo è dunque una filosofia dell’ordinario, ma un ordinario dinamizzato da una prospettiva diversa. Una prospettiva che si sforza di non pensare attraverso la vista (quasi paradossalmente, essendo “prospettiva” una metafora visiva) o, al limite, l’udito e recupera altre dimensioni percettive.
Dopo la genealogia del nesso tra filosofia moderna e gastronomia hai preso in esame il gusto come esperienza. Quali sono le caratteristiche del gusto inteso come relazione estetica?
Intanto, il suo essere primordiale. Mi sto interessando molto, ultimamente, ai rapporti tra gusto, piacere ed evoluzione a partire dalla relazione madre/infante. Come si sa, l’atto di nutrirsi è un universale della vita sensibile, già nel liquido amniotico. Poi, nelle prime fasi dell’esistenza, l’esperienza del cibo tiene uniti, nell’infante, godimento, affettività, conoscenza del mondo esterno. Per questo, secondo me già qui si può parlare di una protoestetica, analogamente a quanto Ellen Dissanayake e altri teorici contemporanei sostengono per il “baby talk” e per altri vincoli percettivi a funzione estetica.
Successivamente questa unità si sfalda e la percezione si articola in piani distinti e differenziali: il piacere, il sapere, ma anche l’indifferenza gustativa (come ho cercato di mostrare nel libro Il gusto come esperienza) sono gli approcci che costituiscono, talvolta separatamente ma più spesso in compresenza, le nostre relazioni con il cibo. Queste relazioni – distinte per grado, non per genere – sono estetiche, una volta che si pensa all’estetica al di fuori della filosofia dell’arte e della gerarchia dei sensi.
Se la cucina può essere arte, e cucinare è una pratica quotidiana e ordinaria, allora anche l’arte è considerabile in stretto rapporto all’ordinario e alla percezione sensibile del reale. Qual è il tuo pensiero in proposito?
Nel mio ultimo libro sostengo appunto che la cucina può essere arte se guadagniamo l’idea che l’arte sia una cucina. La strategia di abbassamento propone cioè di guardare all’arte come evento che si realizza in scene di senso ecologicamente differenti. Occorre guardare, in sostanza, non tanto agli oggetti quanto ai processi. Dell’arte come performance, per usare il titolo del libro di Davies, la cucina è un caso paradigmatico. Nel mio libro cerco di argomentarlo attraverso nove tesi.
La trave portante dell’edificio, però, se dovessi sintetizzarla al massimo, è il ragionamento seguente: per capire fino in fondo il valore estetico e artistico della cucina (la cucina, per me, è lo spazio dove estetico e artistico si sovrappongono, quindi la limitazione di coloro – come Carolin Kormseyer – che assegnano alla gastronomia e alla cucina valore estetico ma non valore artistico è, nel mio modello, irricevibile) occorre arricchire il nostro sistema di riferimento percettivo. Dalle percezione “laterale” del cibo come oggetto finito – una percezione cristallizzata, che prescinde dal processo che ha reso un materiale edibile l’oggetto che entra nella nostra bocca – si tratta di passare alla percezione “longitudinale”, focalizzata appunto sui materiali, sulla loro crescita che prevede anche l’incontro con vari artefici che li trasformano, interagendo con essi.
Concretamente, tutto ciò cosa significa?
Significa considerare l’arte della cucina a partire dall’appetito; poi, certamente, l’idea e l’immaginazione necessarie per cucinare qualcosa; poi la scelta dei materiali; poi come li si cucina; e infine come lo si consuma. L’arte è tutto questo processo, anche chi consuma (un aspetto che oggi viene promulgato da tanti performer artist). La cucina è un’arte relazionale, ambientale e, più specificamente, conviviale. Come si fa a predisporsi a questo modo di percepire? Depotenziando la gerarchia dei sensi, e provando quotidianamente a sviluppare una relazione non esclusivamente ottica ma anche aptica con il mondo. Se ci si riesce, il gusto, che divora l’oggetto, non è più da considerarsi, come pensava Hegel, un senso non estetico ma proprio il contrario.
Il cibo e la cucina m’interessano perché aiutano molto a dis-cristalizzare gli oggetti. Il cibo è relazione aptica. Il mondo processato, fatto e mangiato. Prima del piatto c’è il processo – l’appetito, l’idea di cucinare, la materia che si sceglie, la sua lavorazione, il suo consumo. Questo processo è quanto m’interessa. Il piatto in sé, e basta, è una fotografia, una reliquia.
Accettiamo che la cucina sia arte. A questo punto potremmo chiederci: nella pratica culinaria – al pari di quella artistica – prevale l’ideazione e la dimensione concettuale o la manualità e l’abilità tecnica?
Entrambe le possibilità sono date. Dipende dagli stili, dalle sensibilità. L’importante è liberarsi dal pregiudizio che ci sia una gerarchia tra idea e pratica, progetto ed esecuzione. Fare è pensare, pensare è fare. Che si possa riconoscere qualcosa come arte dipende da come si fa e si pensa, e questo – aggiungo – anche al di là delle teorie istituzionali o intenzionali dell’arte.
Davide Dal Sasso
 1 / 9
1 / 9
 2 / 9
2 / 9
 3 / 9
3 / 9
 4 / 9
4 / 9
 5 / 9
5 / 9
 6 / 9
6 / 9
 7 / 9
7 / 9
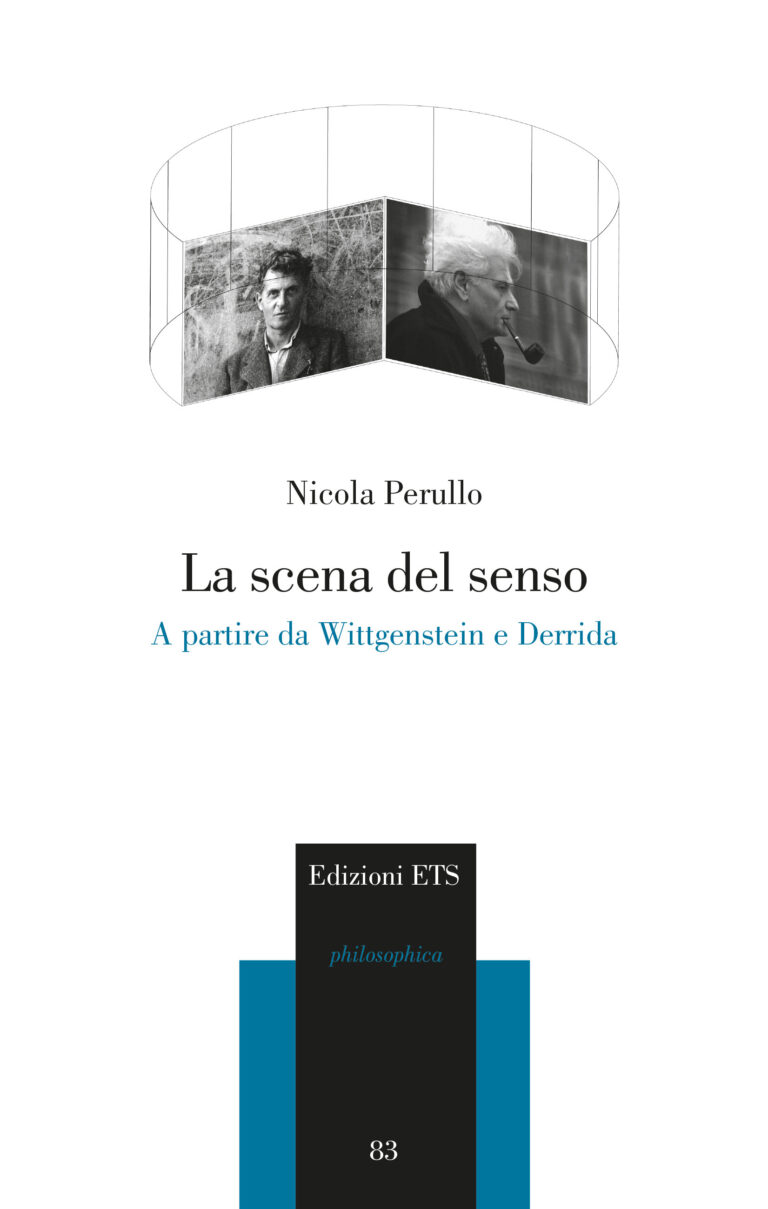 8 / 9
8 / 9
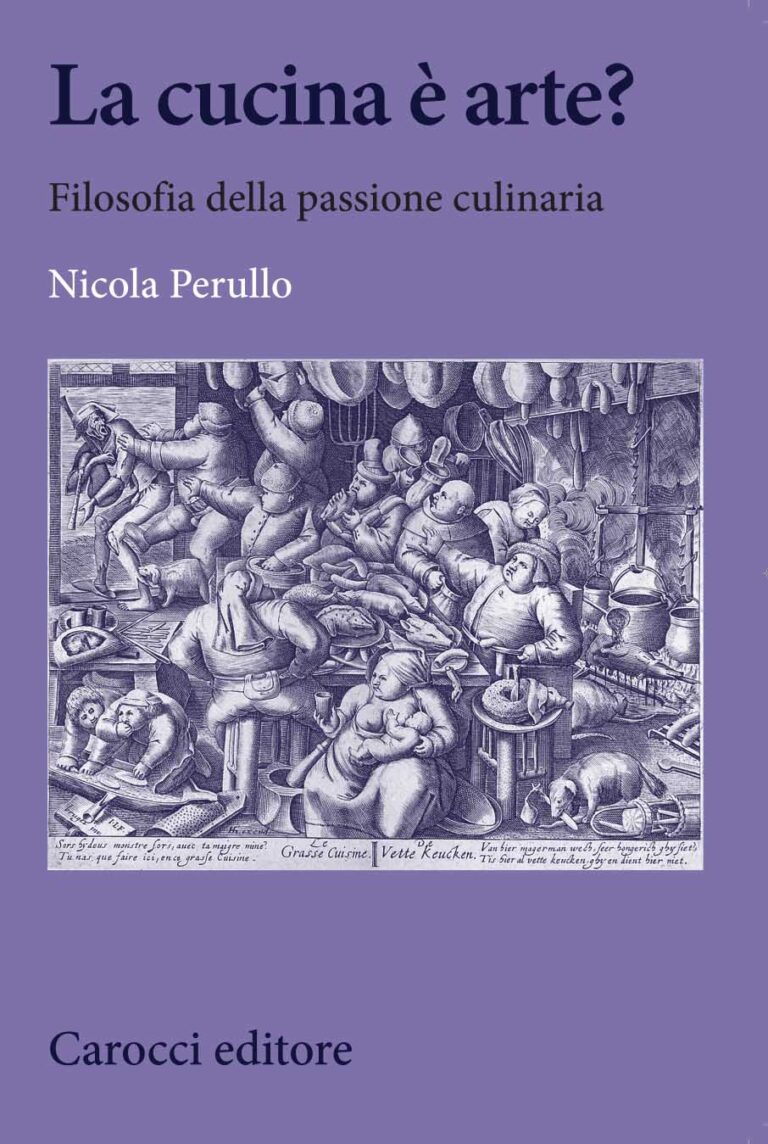 9 / 9
9 / 9
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati