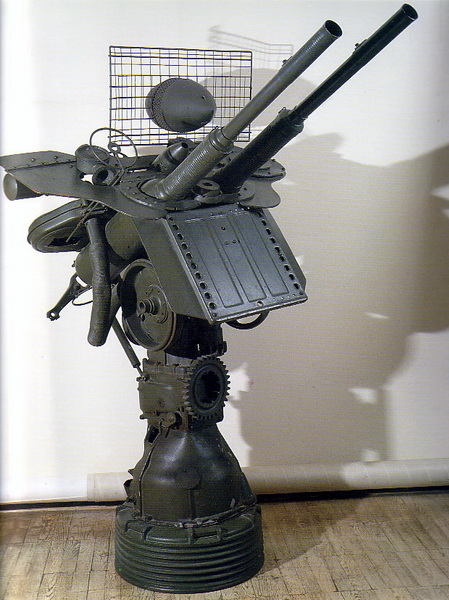Una specie di guerra parte II: racconto del lavoro e presente italiano
Ne parlavamo, sempre su queste pagine, qualche settimana fa. Parlavamo del presente come una “specie di guerra”, un particolare genere di conflitto senza armi ma foriero di altrettanto dolore e distruzione. Il presente dei giovani italiani secondo Christian Caliandro.

Ora finalmente ero solo, padrone di me,
e avevo davanti ai miei occhi la città generosa
che mi aveva subito offerto lavoro.
Goffredo Parise, Il padrone, 1965
(…) in quella piccola città ecclesiastica, in quella
pasticceria molto cittadina, parevano piuttosto che
vestiti, anticipazioni del ballo mascherato della Gorina.
(…) Pareva di spiare in un teatro d’opera
durante la prova generale.
Alberto Moravia, La Mascherata, 1941
Noi non apparteniamo a una generazione che ha vissuto o che ha memoria della ribellione.
Dobbiamo costruire, ricostruire praticamente da zero l’idea stessa – e la pratica – di questa ribellione.
Al contrario dei nostri genitori e dei nostri fratelli maggiori (ma, stranamente, come i nostri nonni), siamo nel deserto e ci troviamo a dover imparare il modo di attraversarlo. Anche dire “noi” non ha molto senso, a questo punto. Noi chi? Siamo soli, siamo sempre stati soli – e stiamo imparando sulla nostra pelle che cosa vuol dire questo “noi”. Noi chi?
Attorno a me continuo a vedere persone che, ognuna nel suo campo specifico e nel proprio contesto di riferimento, conducono una lotta molto dura in condizioni impervie. La maggior parte sta al massimo al galla, resistendo per il momento agli urti: quelli che sono stati e sono in grado di costruirsi una parvenza di “carriera”, lo fanno in realtà accettando tutta intera la situazione data e i suoi presupposti. L’ingiustizia di tutto questo.
Non c’è il minimo addestramento collettivo a resistere a questa ingiustizia, a orientare la propria esistenza verso il rifiuto di queste regole nuovissime eppure così antiche.
Qualche tempo fa, in un pub che incredibilmente era molto anni Novanta (e non una ricostruzione anni Novanta), un mio amico ha posto la questione nei termini più brutalmente semplici e al tempo stesso più lucidi: “Fino a quando potremo menare questa vita?” Esatto. Fino a quando potremo fare finta che questo tutto sommato ci sta bene, che è accettabile, che non ci possiamo fare nulla di nulla?
La solitudine è la chiave di questo momento storico. La percezione desolata – seppure oscura, monca, distratta – che quello che viviamo è un tempo distopico, dotato di colori distopici, di convenzioni distopiche, di una lingua distopica (Neolingua) e – dunque – di una cultura distopica.
(La tristezza di questa percezione.)
Che per resistere all’onda di sdegno e disgusto che monta e che ogni volta viene negata e ricacciata indietro, è stata addirittura allestita una “rivolta generazionale” che annulla il senso stesso della rivolta, una rivolta che rifiuta ogni forma di conflitto e di opposizione e di critica dell’esistente perché né è la conferma precisa e l’ultima validazione – e che altro non è se non una sostituzione su base anagrafica di figure e figurine nello schema, nella commedia, nella scena. Una simulazione, una “mascherata” basata sulla rimozione sistematica di cambiamenti ogni volta annunciati e ogni volta congelati. Rimandati.
E seguitiamo a vivere nella finzione generalizzata: a convivere con essa. La finzione muta, cambia pelle, aspetto. Ma gli italiani rimangono patologicamente affezionati ad essa: tutta intera la struttura psichica del Paese si agita, respira, opera attraverso e dentro questa finzione. Il discorso critico e autocritico non è mai un’opzione vera, reale. Affrontare, esperire, gustare e godere persino l’amarezza e la gloria del fallimento non è – e non è mai stata – una possibilità praticabile a livello diffuso. (Meglio agitare le retoriche del made in Italy, della ripartenza, dell’ottimismo-a-ogni-costo.) Installarsi nella condizione “ulteriore” è un punto di vista scomodo. L’intelligenza non serve dunque più? Persino l’impegno civile, la difesa a oltranza di un determinato sistema di valori, è recitazione, simulazione – l’ennesima parte in commedia. E in questo “fare finta” (fare l’artista, fare lo scrittore, fare il politico, fare il curatore…) si macera la vita individuale e collettiva.
“Che si debba parlare, per essere esatti, di lotta per una ‘nuova cultura’ e non per una ‘nuova arte’ (in senso immediato) pare evidente. Forse non si può neanche dire, per essere esatti, che si lotta per un nuovo contenuto dell’arte, perché questo non può essere pensato astrattamente, separato dalla forma. Lottare per una nuova arte significherebbe lottare per creare nuovi artisti individuali, ciò che è assurdo, poiché non si possono creare artificiosamente gli artisti. Si deve parlare di lotta per una nuova cultura, cioè per una nuova vita morale che non può non essere intimamente legata a una nuova intuizione della vita, fino a che essa diventi un nuovo modo di sentire e di vedere la realtà e quindi mondo intimamente connaturato con gli ‘artisti possibili’ e con le ‘opere d’arte possibili’”
(Antonio Gramsci, Arte e cultura, in Letteratura e vita nazionale)
Christian Caliandro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati