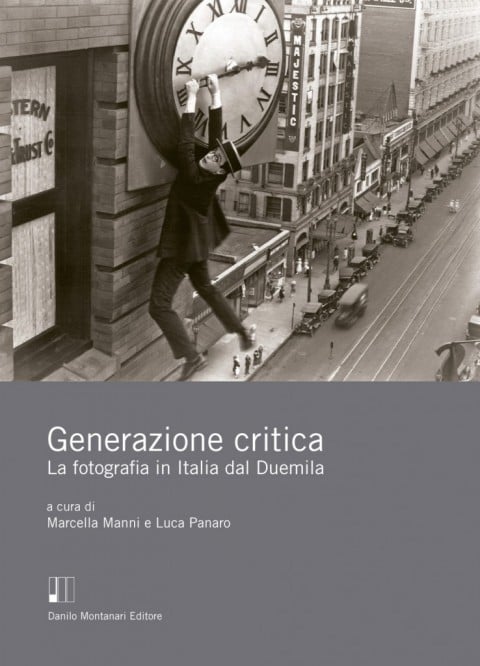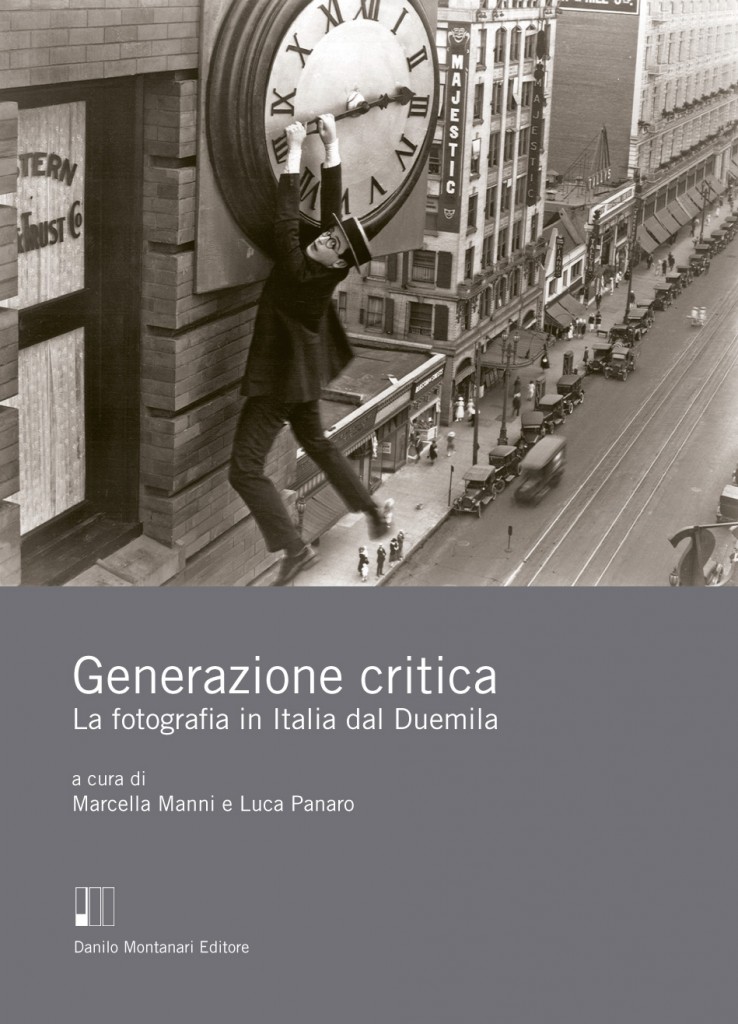Brand New Real
Tre giorni di conversazioni, conferenze, workshop sulla fotografia. È “Generazione critica”, organizzata dalla Galleria Metronom di Modena. La prossima edizione è in programma per il 23-25 ottobre, qui invece pubblichiamo il minisaggio scritto da Daniele De Luigi per l'edizione 2013.

Il rapporto di relazione diretta con il dato reale che caratterizza la natura dell’immagine video e fotografica è un fatto acquisito, tanto quanto il valore che dovremmo attribuirgli è da tempo – e lo sarà ancora per molto – oggetto di accesa discussione. Questa connessione, da un punto di vista tecnico-generativo, è in qualche modo sempre presente in una fotografia e ne costituisce la materia prima, ma quando parliamo della relazione che essa intrattiene con la realtà, siamo soliti riferirci alla sua capacità di fornire un valore documentario rispetto al mondo circostante. Tale valore è una componente variabile di una fotografia che va da un grado prossimo allo zero (quando nell’immagine non distinguiamo nulla della realtà che conosciamo, ad esempio in quelle foto calcolatamente “mosse” il cui risultato ricorda una pittura astratta) a uno piuttosto elevato (quando abbiamo quasi la sensazione di vedere un oggetto nello stesso modo che se lo stessimo guardando coi nostri occhi).
La funzione più diffusa che esercita tuttora la fotografia è comunque quella di procurare, a chi la osserva, una testimonianza visiva (per quanto parziale, menomata, discutibile) di qualcosa che, detto in termini basilari, è esistito realmente e concretamente, che altri avrebbero potuto vedere, che è stato in relazione con altre cose, che ha condiviso la medesima dimensione spazio-temporale. Vorremmo poter aggiungere, qualcosa che è esistito a prescindere dalla fotografia, se non fosse che una simile affermazione appare oggi estremamente problematica. Quando svolge una funzione documentaria – anche qualora non ne sia l’intento principale – provvedendo a creare informazione visiva sulla realtà, la fotografia è in grado di migliorare e incrementare la conoscenza del mondo intorno a noi.
La fotografia come documento ha subito diversi attacchi negli ultimi decenni, e spesso non immeritati. A partire dagli Anni Sessanta del Novecento ne è stata denunciata la capacità connotativa manipolatoria (in parte congenita, in parte intenzionale), l’inconsistenza alla prova del significato del legame con il proprio referente, l’infondatezza del suo carattere di originalità e di autorità, e tutto questo ha contribuito a screditare il rapporto fino ad allora d’acciaio tra fotografia e realtà, mettendo in crisi il valore documentario dell’immagine fotografica all’interno del sistema della comunicazione e dell’informazione. Questa eredità ha fatto in modo che si delineassero due orientamenti molto diversi in materia: da una parte chi operava immerso nel contesto culturale delle arti visive contemporanee e della ricerca intellettuale, sposando questi assunti e sostanzialmente disinteressato al valore documentario dell’immagine, tutt’al più desideroso di esercitare una critica dall’interno volta a demolirlo attraverso i suoi stessi meccanismi linguistici; dall’altra chi, indifferente a quelle critiche, perseverava nella fedeltà alla missione di testimonianza, che costituirebbe per costoro, in fin dei conti, il naturale destino del medium.
Questo atteggiamento è incarnato alla perfezione dal reportage, ancora oggi incardinato su schemi ripetitivi e refrattario a riconoscere i propri limiti. Tutt’altro discorso sarebbe quello dei fotografi che hanno praticato lo stile documentario come analisi critica proprio del rapporto tra immagine e realtà, eppure travolti dal clima del Postmodernismo caddero per un periodo nel dimenticatoio. se guardiamo a come viene utilizzata l’immagine video e fotografica diffusa nei media e al modo in cui indirizza l’opinione pubblica, è fuori di dubbio che sia tuttora viva la necessità di smascherare i meccanismi dominanti di costruzione di significato, di smontarne il funzionamento per risvegliare una coscienza critica nell’audience. Come sottolineano Adam Broomberg e Oliver Chanarin, artisti molto attivi su questo fronte, si tratta di demistificare una catena che non si limita alla produzione delle immagini, ma include anche la loro distribuzione e il loro consumo.
Fa senz’altro pensare che un celebre e colto fotoreporter come James Natchwey possa esaltare la propria missione etica con affermazioni ingenue come “Una volta che hai visto, sai”: cosa sappiamo, esattamente? Vale la pena di riflettere su frasi come questa quando la Casa bianca dichiara di avere la prova irrefutabile dell’uso di armi chimiche da parte del governo siriano perché “lo dice la nostra intelligence, lo dice il buon senso, lo dicono le immagini”: difficile dire quale di questi tre consiglieri sia il più infido servitore della verità. Una volta però che abbiamo provato l’inaffidabilità delle immagini e abbiamo imparato a dubitare di esse, è un motivo sufficientemente buono per esautorarle dal compito di aumentare la nostra conoscenza e la nostra comprensione della realtà? Dobbiamo rassegnarci a non pretendere altro che fotografie che ci appagano dal punto di vista estetico, fotografie che si limitino a fornirci notizie che vanno a incasellarsi in un sistema epistemologico chiuso e predefinito, e operazioni visive volte a decostruire criticamente all’infinito questo sistema e il suo funzionamento?
La domanda è pressante, perché negli ultimi anni abbiamo assistito, è sotto gli occhi di tutti, al riemergere di un’urgenza di realtà. Prima gli effetti della globalizzazione, poi la crisi economica e sociale mondiale hanno provocato un risveglio dal diffuso disinteresse per la ricerca e la comprensione della realtà, e generato un rifiuto ad abdicare dinanzi a qualunque proposizione legata all’idea di vero. In questo contesto, le immagini dovrebbero mostrarsi in grado di smentire il presupposto che non siano altro che una superficie impenetrabile e priva di profondità, costituendo un mondo a se stante incapace di offrire prospettive inattese sulla realtà. non che si senta la nostalgia di un solido concetto di verità, ma l’insicurezza in cui la nostra società è precipitata ha fatto crescere il bisogno di interrogarsi e di sottoporre a verifiche incrociate quello che sappiamo, quello che ci viene raccontato e mostrato, e quello che viviamo quotidianamente, nella consapevolezza di una correlazione tra questi elementi.
In fotografia una pietra miliare di questa tendenza al ritorno alla ribalta della realtà è stata senz’altro la mostra Cruel and Tender, tenutasi alla Tate Modern a Londra nel 2003, che radunando per la prima volta i principali numi tutelari del novecento riportò in piena luce una corrente della fotografia che era scorsa a volte carsicamente, in parallelo a pratiche e teorie critiche. non credo sia un caso che quella mostra fosse stata preceduta dalle prime proteste contro il sistema globale dell’economia e dell’informazione, la mediatizzazione dei conflitti, e dopo l’11 settembre. Per la sua rilevanza, fu l’immediata certificazione di un’esigenza che era nell’aria e della ripresa di un preciso orientamento di ricerca che oggi non possiamo certo dichiarare esaurito. nel frattempo, tuttavia, il nostro modo di produrre, scambiare, fruire le immagini è stato sensibilmente modificato dalle nuove tecnologie, e questo condiziona la nostra percezione della realtà che vediamo nelle immagini. Ma non solo: è anche la realtà che non è più la stessa. La nostra idea di realtà sta vivendo una mutazione, si sta espandendo in una dimensione allargata costituita in parte sempre maggiore di immaterialità ed invisibilità.
Il filosofo John Searle distingue i “fatti bruti” (quelli che esistono indipendentemente dal linguaggio, e potremmo dire indipendentemente dalla loro rappresentazione) da quelli che definisce “fatti istituzionali” (ovvero quelli stabiliti dalle convenzioni umane, dagli accordi che gli uomini in una società prendono tra loro per trasformare un’astrazione in un valore concreto). Si può affermare che i “fatti istituzionali” stiano acquistando un’entità e un’importanza via via crescenti, trasformando e plasmando con efficienza la realtà concreta. Assistiamo poi a una smaterializzazione generalizzata di numerosi beni tangibili, che pure conservano il proprio valore e significato, e a un aumento esponenziale dei dati associati alla realtà e che la definiscono. L’informatica e l’evoluzione delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT) stanno assottigliando sempre più, e tendono a farla scomparire, la barriera che sul finire del secolo scorso separava il reale dal virtuale: sta nascendo un ambiente globale onnipervasivo costituito da tutto ciò che produce, scambia e utilizza informazione.
In quanto individui noi ne siamo parte integrante come agenti che interagiscono permanentemente con un ambiente esteso, modificandolo e venendone modificati, ragion per cui ne siamo e ne saremo sempre meno disconnessi. Questo chiaramente modifica la nostra comprensione del mondo e di noi stessi. Il filosofo italiano Luciano Floridi ha chiamato questo ambiente infosfera. Floridi sostiene che la nostra idea della natura della realtà sarà incentrata sempre meno sugli oggetti materiali e i processi fisici, e che il mondo sarà compreso in maniera crescente in termini informazionali. L’artista Simone Bergantini sembra aver colto la portata di questa rivoluzione e dato ad essa un’efficace forma visiva con le opere della serie che ha intitolato Addiction (2013). Queste immagini rendono improvvisamente visibile, fermandovi il nostro sguardo, la soglia trasparente dove l’inedita relazione tra individuo e infosfera assume sostanza: lo schermo del tablet. Lo spostamento semantico dall’oggetto interagibile alla sua fotografia, che ne rivela la materialità, avviene con la traduzione in una grande superficie nera opaca, macchiata da segni biancastri, che ricorda pitture dell’espressionismo astratto. sono fotografie aniconiche che mostrando il vuoto, occultano, racchiudono ed evocano tutte le immagini presenti nella rete informatica globale. Le tracce organiche depositate sullo schermo diventano la restituzione grafica di un movimento biomeccanico che mappa un processo neurocognitivo, la riattivazione mentale del gesto che ha modificato l’orizzonte di realtà di milioni di individui.
Se lo scenario attuale è dunque quello descritto da Floridi, ovvero una realtà in cui molti elementi decisivi per abbracciare la realtà scompaiono progressivamente alla vista, e dove parallelamente cresce una richiesta di analisi, conoscenza, interpretazione della realtà stessa, la fotografia, chiamata a fare la propria parte, si trova allora a fronteggiare un problema non di poco conto. Di ciò che non si concede alla rappresentazione visiva, è difficile cogliere che sia reale, nonostante contribuisca a modificare valori e relazioni, influenzi le nostre esistenze, indirizzi il nostro modo di pensare. Per la fotografia documentaria, in cui la realtà fenomenica mira a farsi immagine autonoma, la sfida è quella di riuscire a preservare la prerogativa di contribuire alla conoscenza di un mondo la cui intelligibilità ha cambiato parametri.
La questione non è del tutto nuova – basti pensare alle implicazioni presenti nell’opera di Lewis Baltz – ma appare ulteriormente complicata. Quando iniziò a diffondersi la staged/tableau photography, si pensò che la fotografia avesse intrapreso una strada che andava in direzione opposta rispetto a quella del legame con la realtà. Anche le pratiche di appropriazione e riuso di immagini preesistenti, si affermarono sull’onda di proclami secondo cui non si sarebbe più dovuto scattare nuove fotografie. In entrambi i casi, il presupposto era il dichiarato esaurimento della realtà, o comunque la velleitarietà di ogni tentativo per cercare di interpretarla. L’appropriazione tuttavia, tornata negli ultimi anni ad essere usata da molti artisti, ha assunto una nuova dimensione engagé, con il materiale utilizzato che è passato dalle immagini della cultura popolare di massa alle immagini d’archivio, ai documenti, immagini – e non solo – che rimandano a informazioni, alla memoria, a fatti e cose reali.
Questo slittamento sembra poter rievocare il dualismo posto da Hal Foster tra le pratiche che riecheggiano, esasperano e si rendono infine complici della perdita del senso, e quelle che invece lo svelano criticamente in modo costruttivo. Anche la fotografia cinematografica ha dimostrato di saper parlare della realtà con forza anche maggiore di un’istantanea (in cui, come già notava Calvino, non c’è più verità che in un ritratto in posa). Sebbene però accettiamo questo principio per un romanzo o un film, siamo ancora ben lontani dal farlo per una fotografia.
Difficile comunque pensare che la fotografia possa affrontare la realtà del mondo contemporaneo in modo efficace, prescindendo dalla produzione di nuove immagini. David Bate, sostenendo qualche anno fa la necessità di un “nuovo genere di neorealismo” che si preoccupi degli effetti delle immagini sull’audience, ne parlava a partire da un ritorno alla descrizione, all’originalità e all’autenticità. Se la fotografia vuole fare la propria parte nella ricerca di strategie di effrazione della superficie della realtà, riaffermando l’alto valore della sua capacità documentaria, occorre in primo luogo che ripensi preventivamente cosa dobbiamo guardare, cosa abbiamo bisogno di vedere e non riusciamo o ci viene impedito di vedere. Una variazione che implica l’abbandono definitivo della flanerie fotografica intesa come priorità e indipendenza dell’esercizio dello sguardo. Poi bisogna aprirsi quanto più possibile alla contaminazione, non solo con altre forme del visivo, ma anche dell’informazione, della documentazione, e con tutto ciò che può produrre conoscenza. La chiave è da cercare in quella che potremmo chiamare “contaminazione cognitiva”, in cui la forma sia uno strumento e non un obiettivo, che possa risolversi in soluzioni inattese purché al termine del processo vi confluiscano tutti gli ingredienti del corto circuito.
M.E.M. (2013) di Giorgio Barrera, ad esempio, è una ricerca fotografica ad oggi in progress a carattere sperimentale, che a partire dall’oscura vicenda della morte del presidente dell’EnI Enrico Mattei analizza gli intrecci tra concetti quali verità storica, fiction, traccia, rappresentazione, informazione. L’artista muove da una celebre illustrazione apparsa su un rotocalco dell’epoca che accreditò nell’immaginario pubblico una versione falsificata dell’incidente, per costruire un’indagine per immagini che include materiale d’archivio, fotografie e video del luogo, ricostruzioni di finzione. Barrera tiene come guida il romanzo incompiuto Petrolio di Pasolini, definito da Carla Benedetti “un tentativo di rendere visibile tutto il potere, e di renderlo visibile attraverso visioni”. È dunque un tentativo di riappropriarsi criticamente di una realtà la cui decifrabilità è stata compromessa all’origine, deviando dal canone del realismo. E non solo della realtà storica ma anche di quella attuale, perché “l’Italia degli anni settanta si proietta in maniera inquietante sugli anni novanta e nel terzo millennio”.
A un altro mondo sotterraneo, quello della criminalità, è invece dedicata la ricerca dell’italo-olandese Alberto De Michele: un mondo invisibile che però popola l’immaginario dell’uomo comune attraverso i mezzi d’informazione e la finzione letteraria, televisiva e cinematografica. De Michele ha sfruttato l’esperienza diretta avuta con esso fin da bambino mediante il padre, per instaurare rapporti di fiducia che gli hanno permesso di far emergere vicende di traffici illeciti, furti, rapine, clandestinità. Usando il video e la fotografia, l’artista ne offre però una rappresentazione in forme accessibili: come fiction, come spettacolo aperto, come affissione pubblica, come oggetto artistico. non dà mai la sensazione di condividere un segreto e questo ribalta la nostra prospettiva, ponendoci di fronte a una realtà che nel rivelarsi con chiarezza ci costringe a modificarne la lettura. In Indomita Jet vs. Dardus Coca (2010), ad esempio, realizza un’installazione video multicanale di una corsa ippica clandestina nel sud Italia, dandole la forma di un evento mediatico. In Quien lo vive, quien lo goza (2012) ci presenta un mercenario colombiano conosciuto sull’isola di Aruba, mescolando i codici e confondendo i nostri metri di giudizio.
Victor Hugo lo scriveva a proposito del dramma storico e nulla vieta di pensarlo anche per la fotografia: non deve essere lo specchio del reale, ma ambire a essere uno specchio ustorio, facendo convergere in un punto i raggi della realtà prendendoli da un campo molto più ampio del proprio tradizionale campo visivo e restituendoli condensati in un unico potente raggio. superare il proprio campo visivo significa per la fotografia superare i pregiudizi sulla sua natura, riconfigurare lo statuto del rapporto tra fotografia e realtà, partendo non da ciò che la fotografia si ritiene che sia e che dovrebbe essere, ma da ciò che ha in potere di fare per interpretare la realtà a partire dal dato visibile. L’aforisma di Hugo si trova citato in un recente saggio a cui lo scrittore Walter siti affida la sua idea di realismo in letteratura. “Il realismo è l’anti-abitudine: è il leggero strappo, il particolare inaspettato, che apre uno squarcio nella nostra stereotipia mentale”, e che quindi “saranno nemiche del realismo tutte le cadute in una qualunque forma di stereotipia”: ecco perché la maggior parte delle odierne rappresentazioni fotografiche della realtà, soprattutto quelle convinte di spiegarla descrivendola fedelmente come appare, falliscono l’obiettivo. “La rappresentazione della realtà è efficace se sembra nascondere sempre un altro strato della realtà” (Walter Siti): una lezione che torna utile anche alla fotografia.
Daniele De Luigi
Questo saggio (dal quale sono state espunte le note per facilitarne la lettura sul web) è tratto dal volume “Generazione critica.La fotografia in Italia dal Duemila”, a cura di Marcella Manni e Luca Panaro (Danilo Montanari Editore, Ravenna 2014).
http://www.generazionecritica.it/
http://www.danilomontanari.com/
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati