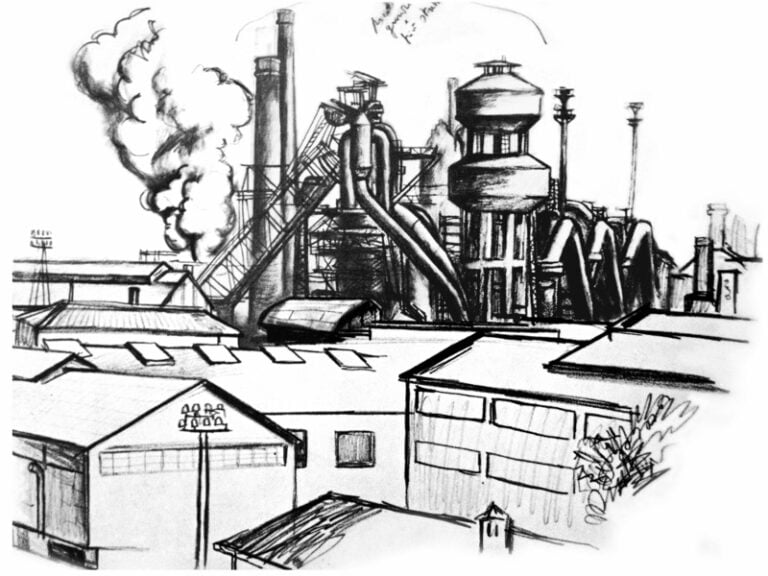Dialoghi di Estetica. Parola a Giovanni Durbiano
Architetto, Giovanni Durbiano è professore ordinario di Progettazione Architettonica al Politecnico di Torino e titolare di uno studio professionale interdisciplinare. Proprio dalla presa d'atto della separatezza esistente tra quanto insegnato a scuola e quanto praticato in studio, è nato il libro “Etiche dell'intenzione. Ideologia e linguaggi nell'architettura italiana”, la cui recente pubblicazione è l’occasione per avviare un nuovo Dialogo di Estetica.
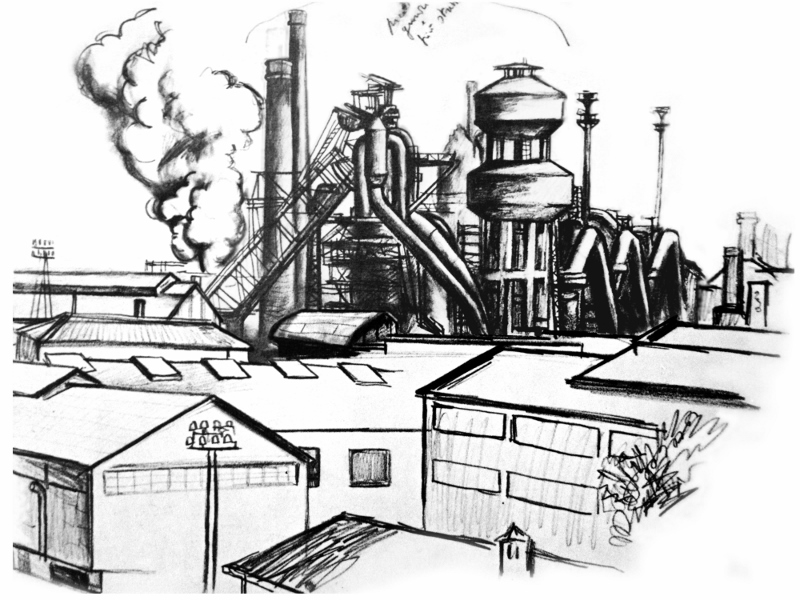
A partire dal libro I Nuovi Maestri (Marsilio 2000) sino a Etiche dell’intenzione (Marinotti 2014), lei tematizza una questione oggettivamente saliente, quella dell’“autorialità” in architettura. Da cosa nasce la sua analisi critica?
Io ci ho creduto. Ci ho davvero creduto. Era bellissimo immaginare, ancora studente, che fosse possibile, una volta acquisiti gli strumenti, essere autori: avere un mondo davanti ed essere in grado di darne un’interpretazione personale. Era quello che facevano – mi sembrava di capire – gli architetti più bravi, quelli che mi piacevano di più. Rossi, Grassi, Gabetti & Isola (perfino Canella, che normalmente non piace a nessuno) facevano tutti cose linguisticamente molto diverse, ma le loro opere apparivano all’interno di un medesimo disegno legittimante: qualcosa che aveva a che fare con il senso. Bisogna riconoscere che l’appello al senso ha fregato intere generazioni di architetti.
Che cosa intende per “appello al senso”? E in che rapporto sta il senso con l’autorialità?
Per un architetto, per una persona cioè che deve porsi il problema della scelta (tra una forma, un materiale, una strategia…), l’appello al senso è una formula magica che delega ad altri discorsi la legittimazione della sua scelta. È il passepartoutche permette di ripetere la propria cifra, perché si suppone che questa cifra sia il prodotto di chissà quale autentica ricerca interiore (e a volte lo è pure). L’autore, tramite la cifra, può affrontare il problema della scelta proponendo un’interpretazione del mondo e garantirsi una salvezza possibile rispetto all’apparente insensatezza delle cose umane.
Ho cominciato a diffidare di tutto questo constatando che, col passare degli anni, questa originaria immaginazione di essere autore non solo era difficile da perseguire professionalmente (e fin qui si potrebbe dire: se non sei capace, lascia fare l’autore a chi lo è davvero), ma era stata costruita a tavolino: era il prodotto di una strategia di comunicazione, per lo più accademica. Era, in altre parole, ideologia: si presentava come un tutto mentre era il prodotto di una parte. Niente di male. Per chi lo ha vissuto credo che sia stato anche bello. Come è bello credere fino in fondo a una favola. Ma oggi mi pare che quella favola non possa più essere raccontata.
La questione del rapporto tra autore e opera, della incombenza/invadenza della cifra autoriale, è un problema che in estetica investe saperi diversi e distanti, come l’arte, la letteratura, la musica e altri ancora. Come mai la critica all’autorialità muove proprio dall’architettura?
Certamente perché faccio l’architetto ed è l’attività che conosco meglio. Ma anche perché l’architettura, indubbiamente più di altre attività umane, è il prodotto di bisogni diversi, alcuni dei quali ben poco autoriali. Gli errori degli architetti, intendo gli errori prodotti dalla distanza tra la società e la cultura architettonica, hanno costi altissimi. L’architettura presenta qualcosa di resistente rispetto alla dinamicità della realtà quotidiana che viviamo. Questa resistenza può essere positiva (la grandiosità del Cupolone, come canta Venditti) ma anche negativa (le difficoltà ad abitare le periferie urbane). Devo ammettere che oggi criticare l’autorialità nell’architettura è piuttosto facile. Sarei stato più bravo se avessi scritto le stesse cose dieci anni fa. Ad esempio prima delle Olimpiadi invernali a Torino, dove invece i discorsi erano tutti pro star.
Leggendo i suoi lavori e ascoltando alcuni suoi interventi mi pare di capire che la questione dell’autorialità emerga in Italia nel secondo dopoguerra ma che abbia generato nel tempo effetti globali…
Effetti globalissimi, direi: che cosa altro non è il vituperato fenomeno delle archistar e del divismo in architettura? Devo ammettere che ci sono segnali di crisi anche in questo settore: nessun primo cittadino di una nazione sviluppata si sogna più di invitare gli architetti stellati per risolvere un problema urbano, e solo nei Paesi davvero poco evoluti atterrano ancora dei dischi volanti di provenienza autoriale… Addirittura l’ultima Biennale di Venezia ha programmaticamente eliminato gli architetti dall’esposizione. Però, se uno ci pensa, abbiamo passato più di trent’anni a delegare ad architetti autori la trasformazione di interi prezzi di città: a Berlino, a Londra, a Parigi. Persino a Roma o a Torino, la mia città (dove però sono arrivate solo le archistar bollite).
Da dove nasce tutta questa voglia di autore, di cifra, di riconoscibilità? Il secondo dopoguerra, e poi gli anni del boom, sono stati in Italia un buon campo di coltura per una posizione che, denunciando le diete del Movimento Moderno, guardava le macerie della storia proponendosi nuovi inizi. Ogni autore – preso dalla fregola dell’angelus benjaminiano – si è costruito la propria genealogia (Gregotti-Perret, Rossi-Piermarini, Canella-De Klerck, Portoghesi-Borromini…) e l’ha tradotta in un proprio gioco linguistico. Da qui all’archistar vede anche lei che il passo è stato breve.
In architettura l’attività accademica e la professione hanno un rapporto controverso, o mi sbaglio?
Lasciamo perdere. Questa risposta si prenderebbe tutto lo spazio del dialogo. In Italia i modelli formativi imperanti sono ancora in buona parte costruiti sullo stampo autoriale. Anzi: spesso la stessa organizzazione geografica delle scuole è costruita sull’insegnamento di quello che, cinquant’anni prima, era stato il locale Nuovo Maestro.
Un passaggio che torna nei suoi scritti e che mi pare rilevante è la relazione tra autorialità, democrazia e argomentazione. Mi spiega?
L’architetto autore, avendo già in tasca una propria visione del mondo, ha il solo problema di trovare un Principe da sedurre, che gli permetta di realizzarla in pietre. Il rapporto con il potere è di tipo autoritativo-individuale. Un architetto che non si ponga programmaticamente il problema della propria autorialità, invece, deve convincere la società dei propri buoni uffizi, e dovrà farlo con gli argomenti, non con la seduzione. Conseguentemente il suo rapporto con il potere sarà – nel migliore dei casi – democratico-consiliare. È una bella differenza, non crede?
Mi sembra che lei pratichi e incoraggi l’incontro dialettico tra saperi e che la “questione autoriale” non vada limitata al solo contesto architettonico. Lei riconosce una possibilità reale, a partire dal “problema dell’autore”, di incontro e dialogo con discipline extra-architettoniche?
Tutte i saperi che hanno a che fare con i bisogni più misurabili dell’uomo hanno a che fare potenzialmente (e concretamente) con i rischi dell’egolatria autoriale. Lo spettro degli scambi possibili è ovviamente molto vasto. Concretamente ho avuto la possibilità di verificare la fecondità delle prospettive di ricerca con certe indagini applicative di tipo ontologico, e soprattutto con gli studi linguistici più attenti a una stilistica performativa. Siamo agli inizi di questi scambi, ma i campi che si aprono sembrano essere amplissimi. Esiste poi, ma siamo in una dimensione di pervicace perversione, una letteratura programmaticamente deautorializzata. Al solo parlarne mi viene la pelle d’oca.
La sua analisi storica e critica dell’autorialità non si ferma alla pars destruens: quale contravveleno propone alla egolatria autoriale e quale prassi va formalizzata per inaugurare una nuova architettura?
Il problema non è l’autorialità, la cui esistenza nessuno ha ovviamente in mente di negare, ma la sopravvalutazione di questa nelle pratiche di legittimazione (professionali, amministrative, accademiche). La soluzione autoriale, quasi sempre, serve a coprire un problema che autoriale non è. Si tratta invece di costruire un quadro di legittimazione al lavoro dell’architetto che, pur tenendo conto delle ineliminabili soggettività della pratica del progetto, sia in grado di rispondere a una serie di istanze sociali più diffuse e articolate. Una teoria del progetto che si occupi non tanto del rapporto tra soggetto e opera, ma degli effetti dell’opera sul mondo. Mi sembra che, viste la condizione di ineffettualità in cui versano i più di 100mila architetti operanti in Italia, ce ne sia bisogno. Ci stiamo lavorando, insieme al collega Alessandro Armando, incrociando gli studi sulle pratiche sociali delle hard sciences con la riflessione sulla performatività linguistica e documentale. In altre parole: ripartendo dalle Science Wars. Ma siamo ancora, per così dire, in mare aperto.
Vincenzo Santarcangelo
Giovanni Durbiano – Etiche dell’intenzione. Ideologia e linguaggi nell’architettura italiana
Christian Marinotti, Milano 2014
Pagg. 176, € 18
ISBN 9788882731465
www.marinotti.com
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati