Opera chiusa. Da Eco & Bourriaud al professor Evans-Pritchard
Vi ricordate del professor Evans-Pritchard nel film “L'attimo fuggente?”. In questo avvio di millennio, il suo “Comprendere la poesia” è forse una bussola più utile di “Opera aperta” e “Radicant”. O almeno così la pensa Roberto Ago. Ipotesi e tesi qui di seguito.
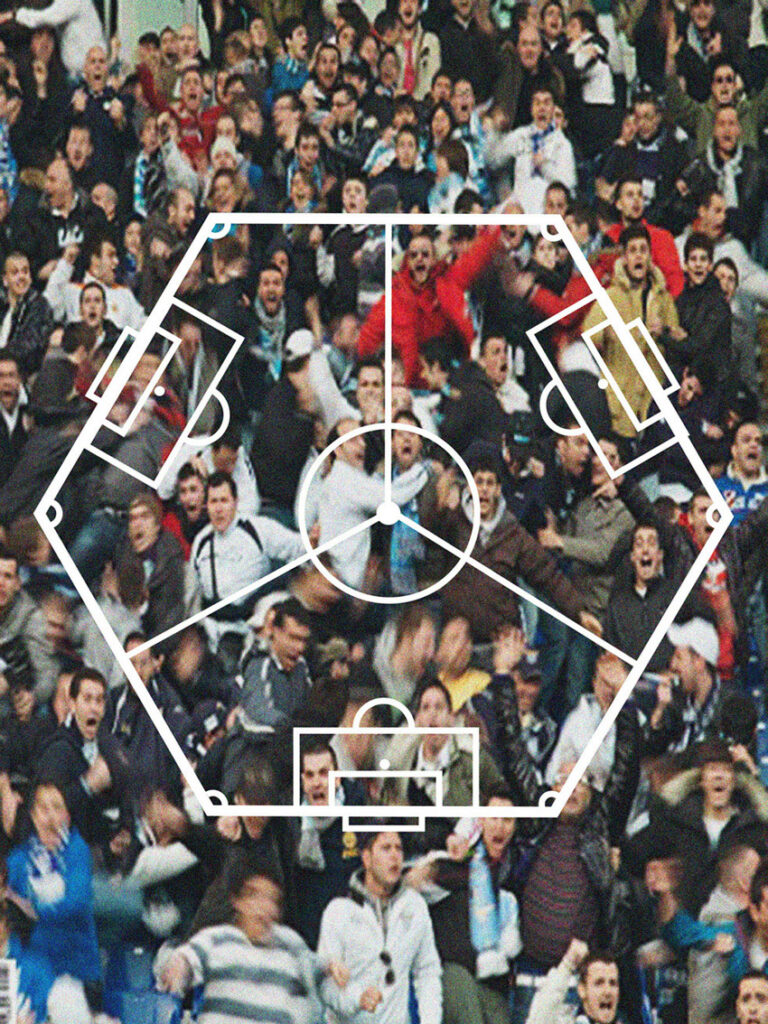
Ne L’attimo fuggente, in apertura del film sembra di assistere alla polemica a distanza mossa da un giovane Umberto Eco a Benedetto Croce su analoghe questioni di estetica, solo a parti invertite. L’irriverente professor John Keating (Robin Williams) sembrerebbe stare al professor Evans-Pritchard (l’autore del manuale di letteratura in dotazione agli studenti) come il semiologo rottamatore al filosofo dei tempi andati. Se non fosse che è Keating ad apparirci come il paladino di un’estetica romantica, sottolineata dalla quasi omonimia con John Keats, mentre il vituperato Evans-Pritchard, esempio di moderna analisi testuale, porta un nome che non a caso rimanda a un’etnologia colpevole quanto la semiotica di colonizzare il genio selvaggio.
Nonostante il comune approccio a questioni estetiche, l’Eco di allora ha poco a che vedere anche con un Evans-Pritchard rivolto ai fasti letterari del passato, il cui trattato tuttavia, per un ciclico vizio dei tempi, meglio di Opera aperta sa rendere conto dell’opera chiusa di oggi. Dove “chiusa” non significa tanto che abbia smarrito le sue aperture e ambiguità, quanto che le modalità delle sue “ouverture” sono state nel frattempo mappate, costringendo gli artisti a pratiche progressivamente illustrative quando non didascaliche nei confronti delle produzioni precedenti e di conseguenza del mondo. Sia chiaro, in ciò nulla di male, è prassi di sempre negoziare tra esigenze di rottura e adesioni a koiné artistiche codificate, e oggi l’epoca delle trattative sembrerebbe sospesa a tempo indeterminato. Ciò non toglie che un’arte canonizzata possa raggiungere vertici straordinari, si pensi solo agli Egizi, a Duccio, a Martin Creed.
Dai lustri sperimentali di Joyce, Berio e Piero Manzoni l’arte è dunque parecchio cambiata, specie dopo il canto del cigno dei Novanta e il giro di boa del millennio, confluita sotto l’egida di un canone occidentale forgiato in gran parte su media che promuovono un’estetica della rappresentazione. Segni e significati, format e contenuti, codici e loro violazioni appaiono divaricabili quanto intercambiabili, una galassia di opzioni ready-made che veicolano altrettanti messaggi ready-made sovente disturbati “come” ai vecchi tempi. Ferri del mestiere e immaginari non possono che darsi su appositi scaffali, realizzare un’opera è diventato un po’ come fare la spesa, si segue la ricetta sulla confezione, chi più consapevolmente chi meno, variandola un poco ma solo perché impossibilitati a deviare troppo dalle indicazioni. Post-produzione, cucina creola, culto “monopoliteistico”: sono questioni note e dibattute. Meno scontato è che possano intercettare un vecchio ricettario quale l’Evans-Pritchard, utile non a risvegliare le coscienze come vorrebbe il Nicolas Bourriaud di un Radicant ancorato agli Anni Novanta, ma a prendere coscienza della situazione con realismo in vista di opere chiuse almeno convincenti.

Luca Trevisani, Physical Examination, 2014 – Museo Marino Marini – photo Dario Lasagni
Cosa ci suggerisce questo volume realmente in dotazione negli Stati Uniti degli anni ’50? Innanzitutto che siamo in regime di arte illustrativa, appunto, quando i valori delle produzioni artistiche possono essere stabiliti con buona approssimazione tracciando un grafico ideale per mezzo di un’ordinata del contenuto (valori del logos) e un’ascissa della forma (valori del pathos). Ricordate? “…un sonetto di Byron può avere valori alti in verticale ma soltanto medi in orizzontale, un sonetto di Shakespeare, d’altro canto, avrà valori alti sia in verticale che in orizzontale...” Quindi che, data l’arte iper-codificata in tutti i suoi rizomi o radicanti che siano emersa dopo l’anno zero, è possibile stabilire i valori suddetti prima ancora di andare a tavola e addirittura già al supermercato, per via di una Legge di Evans-Pritchard che afferma: “Quanto più un’occorrenza estetica mostrerà di possedere valori alti su entrambi gli assi (e tali perché codificati), tanto più sarà prossima al capolavoro; viceversa quanto più apparirà mediocre, tanto più avrà disertato i valori di uno degli assi o peggio di entrambi”. Impara i valori e metti loro gli allori, insomma, il giudizio a posteriori è indistinguibile dalla prescrizione, dal canone, da una rotta tracciabile su coordinate (due) prestabilite, nell’impossibilità apparentemente definitiva di abbandonare un minestrone globalizzato che ha fagocitato ogni sapore alternativo. Colpisce come in Opera aperta l’intento fosse quello di estendere l’analisi ad opere che pur non potendo sottrarvisi, opponevano resistenza, mentre oggi la strada è spianata per un Evans-Pritchard che scriveva di Shakespeare.
Quale inopinato volano della contemporaneità e saggio di marketing è dunque il suo, professore, se non è lecito pretendere che gli studenti di estetica salgano sui banchi di scuola per salutare il suo ritorno in pompa magna, auspicabile sarebbe che gli artisti del nuovo ordine mondiale impugnassero immediatamente il suo manuale. Specie in Italia. Si prenda il caso di Michele Dantini e del suo puntuale rilievo di un’arte tricolore impantanata tra compiacimento artigianale ed engagement pretestuoso (Che fare? Le due metà dell’arte italiana, Artribune #21, settembre 2014), e si veda quanto l’Evans-Pritchard possa dimostrarsi utile per tornare competitivi sul mercato internazionale. Dantini sottolinea, in particolare, come nel Belpaese le due attitudini non solo tendano a divergere, ma finiscano per illudere artisti e curatori che si stia puntando quantomeno al vertice di uno degli assi, quando né campioni di concetto e impegno civile (Y) né di formalismo ed estasi retinica (X) si profilano all’orizzonte. Ne conveniamo, in caso contrario gli allori internazionali, e non solo i passaporti, germoglierebbero via da “terrazze” di casa assolate sempre e solo per noi. La famigerata mancanza di istituzioni è in tal senso una fortuna, oltre che il solito alibi, ché almeno non si intasano i musei italiani di artisti poco o nulla riconosciuti all’estero.

Danilo Correale
Senonché rari acrobati sui trapezi esistono anche qui, così come talenti male indirizzati abbarbicati a un solo asse e per i quali è lecito sperare in un salto di qualità. Siccome a parlare come Evans-Pritchard si rischia di venire cestinati da un clic, proviamo a fornire tre esempi che chiariscano la faccenda, e a farlo servendoci di quelle fastidiose comparazioni tra artisti che giustamente il professore ritiene necessarie per negoziare delle scale valoriali (e con lui il suo discepolo Luca Rossi).
Un buon esempio di “semionauta” a mezz’aria è dato da Pietro Roccasalva, il quale sa mixare ricercatezza formale e sapienza concettuale, tradizione e innovazione, tecnica manuale e maneggevolezza delle nuove tecnologie. Nonostante le sue indubbie qualità, alcuni lo giudicano affetto da genius loci, ma l’esotismo non era un valore e Roccasalva un prodotto “glocal” al pari del Prosciutto di Parma? Siamo sicuri che ci sia differenza di (de)merito tra il suo ritorno all’ordine e quello di un Thomas Houseago o di uno Sterling Ruby? A parità di citazionismi, è metro un poco provinciale quello per cui un neo-primitivismo e un neo-minimalismo valgano più di una neo-metafisica, eppure a Roccasalva continuano ad essere preferiti connazionali diversamente allineati (per esempio da Christov-Bakargiev a Documenta e da Gioni alla Biennale di Venezia) nell’illusione che sfuggano al morbo manierista, quando è vero esattamente il contrario. Solo se assunta consapevolmente una qualsivoglia tradizione artistica può sviluppare gli anticorpi, un principio immunitario che non a caso molti operatori stranieri, a differenza dei nostri più attivi sulla scena internazionale, nel caso di Roccasalva mostrano di apprezzare da tempo.
Veniamo al primo esempio di artista mono-asse. Formalmente ineccepibile in virtù di un “international style” di fondo, concettualmente azzerato, a meno di intendere una poetica della formatività francamente datata, Luca Trevisani mostra di possedere un idioletto estetico coerente e riconoscibile. Di questi tempi è già mezzo successo, occorre dunque che qualcuno lo metta in guardia su una carriera che se non rischia di precipitare, potrebbe non decollare mai. Quel qualcuno naturalmente è Evans-Pritchard (carpe diem?). A titolo esplicativo, un’indicazione da manuale. In un video recente, Trevisani ci mostra un serpente che si inerpica su una struttura rigida stagliata su un fondo verde in chroma key (Physical Examination, 2014). Realizzazione impeccabile, ragioni dell’opera irreperibili se non su un piano morfo-zoo-logico. Ebbene, se solo la griglia si fosse mostrata per quella di Mondrian che pure evoca, il verde dionisiaco espulso dalle tele apollinee del pittore ci sarebbe apparso sullo sfondo di un albero-gabbia nuovamente abitato dal serpente (ricordiamo che la griglia di Mondrian procede per astrazione dall’albero), per un video capace di farci cogliere, a parità di godimento formale, nientemeno che il rimosso mondriano e non solo mondriano. Se tale riformulazione legittimamente non fosse gradita prima di tutto a Trevisani, sarebbe in virtù di coerenza idiolettale e papille gustative, perché dal punto di vista di Evans-Pritchard è inappuntabile. Il punto è evidenziare come si possano riequilibrare i valori percentuali di forma e contenuto nel confezionamento di un’opera chiusa, e come una via privilegiata per farlo in caso di dispotismo formalista sia quella della rappresentazione (più o meno retorica è lo stesso).

Danilo Correale, The Game
È il turno di un artista che, posizionato sull’asse perpendicolare a quello di Trevisani, appare proficuamente impegnato sul fronte del contenuto ma formalmente prossimo allo zero. Danilo Correale ha realizzato lavori dal forte taglio concettuale quali ad esempio i tendaggi esposti da Peep-Hole (The Warp and the Weft, 2012) e la partita di calcio giocata su un campo tripartito (The Game, 2013). Nel primo caso, i colori dei brand di multinazionali, banche e holding finanziarie dei cinque continenti vengono a costituire la trama e l’ordito di austeri vessilli che alludono a un potere finanziario globale; nel secondo, un celeberrimo emblema del duello è sottratto alla competizione dei doppi non solo in vista di una pacificazione, ma anche per essere consegnato a un match potenzialmente virale cha tanto sa di Eurozona. Due statement intelligenti e di gran moda, come si evince, eppure le rispettive illustrazioni appaiono l’una scialba al punto di poter sospettare che trattasi di sovra-interpretazione di normali stoffe, e l’altra tanto anonima che potrebbe essere di chiunque. Se un Bourriaud potrebbe chiudere un occhio, non così un Gagosian. Suggerimenti formali, Prof. Evans-Pritchard? Limitati all’ordine del discorso: se le due allegorie fossero state confezionate non diremmo, rispettivamente, da una Sarah Morris e da un Cyprien Gaillard, ma da un Jonathan Horowitz in grado di veicolarle entrambe, a parità di messaggio starebbero viaggiando molto più lontane.
È chiaro come date le tre casistiche di opera chiusa individuate, certo sovrapponibili ma comunque differenziate, il lettore saprà trovare i nomi alternativi che gli interessano. Ma soprattutto potrà interrogare il proprio operato di artista, critico o curatore che sia, sempre che trovi il coraggio di farlo.
Roberto Ago
Per un fulmineo confronto tra il comune sentire di Evans-Pritchard e Umberto Eco si rimanda, oltre a Youtube (Comprendere la poesia), all’introduzione del saggio in Appendice, “Generazione di messaggi estetici in una lingua edenica”, presente a partire dalla terza edizione di “Opera aperta”.
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





