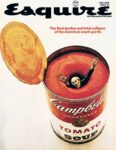Dialoghi di Estetica. Parola ad Andrea Mecacci
Andrea Mecacci insegna Estetica all’Università degli Studi di Firenze. L’estetizzazione della contemporaneità, le sue declinazioni teoriche e operative e l’analisi di alcune categorie (il pop, il kitsch) compongono l’orizzonte delle sue ricerche attuali. Sono dunque la figura di Andy Warhol e le dimensioni estetiche del pop, del design e del kitsch a essere al centro di questo dialogo con Davide Dal Sasso.

Il nome di Andy Warhol viene generalmente associato alla consacrazione del packaging, a una sorta di affezione per le immagini e gli aspetti prevalentemente visivi della cultura. Nella tua rilettura, tuttavia, sottolinei che il suo insegnamento mostra l’amplificazione di un senso di smarrimento che caratterizza la società contemporanea e uno smisurato apprezzamento per gli oggetti. Inizierei da qui: quali sono i tratti essenziali dell’estetica warholiana a tuo parere?
Warhol è una figura decisiva del secondo Novecento. Dalla sua opera è possibile ricavare un’estetica ben definita che va al di là del mondo dell’arte ed è qui che risiede la sua centralità e pervasività. Relegare Warhol nelle rassicuranti sfere della storia dell’arte o del costume è un’operazione purtroppo molto abusata. Warhol ha costruito un sistema che ha al proprio centro la mutazione ontologica dell’arte quando quest’ultima ha dovuto ridefinirsi all’interno del capitalismo industriale. L’insistenza warholiana sulla merce, sulla produzione in serie, sul tecnologico sono le dimostrazioni, più ovvie, non solo delle trasformazioni dell’oggetto novecentesco, ma anche del soggetto contemporaneo.
L’eredità di Warhol non è artistica, è soprattutto antropologica. Ci ha inchiodato al nostro culto della superficialità, alle nostre ipocrisie, alle menzogne, soprattutto culturali, con cui quotidianamente assolviamo noi stessi. Un barattolo di zuppa e un’attrice mal truccata: il nulla nel cuore dell’immagine, come disse un po’ enfaticamente Baudrillard.
La parabola artistica warholiana, tuttavia, è contraddistinta dalla riconsacrazione delle icone mediante l’attribuzione di nuovi significati a qualcosa che c’è già e che, diciamo, brilla sotto nuova luce. Credi sia possibile inquadrare tale strategia in rapporto a una ripresa del classicismo? E, se è così, quali sono le sue ricadute sul versante dell’ontologia dell’arte?
In Warhol tutti i cardini dell’estetica occidentale (mimesis, techne, bellezza) sono rimodulati all’interno delle strategie della cultura industriale. E di questa cultura industriale Warhol offre una versione “classica”, definitiva: rappresentare meccanicamente l’eidos della bellezza e porre questa rappresentazione all’interno dei processi della comunicazione. Qui risiede il mutamento ontologico a cui Warhol sottopone l’opera d’arte del Novecento. Warhol è stato sempre ammaliato da quell’incanto tipicamente classicista che è la contemplazione. L’icona è il mezzo più adatto per realizzare questo nuovo classicismo: all’interno dell’universo della comunicazione e della consumabilità estetica rappresentare il significato con il significante più immediato.
Inoltre in Warhol opera ossessivamente una diffidenza verso il naturale e ciò comporta una visione ideale del bello. Il trucco, l’artificio è il correttivo per fronteggiare la tirannia della natura: il bello è costruibile (make-up). La fascinazione warholiana per i trans documenta propria questa antinaturalità del bello e quindi la sua idealità. La famosa frase “le labbra di Marilyn non erano baciabili, ma erano molto fotografabili” rappresenta la sintesi più efficace di questo culto per una bellezza cosmetica, chirurgica.
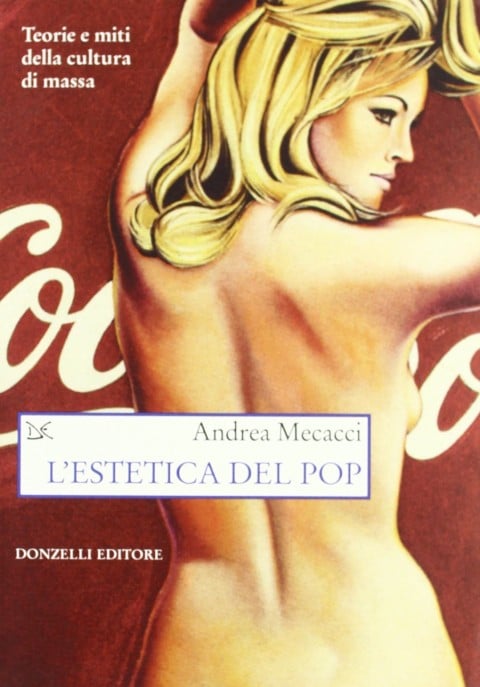
Andrea Mecacci, L’estetica del pop, Donzelli Editore (2011)
Ben prima che Warhol affermasse che “il pop è amare le cose”, nel 1947 Eduardo Paolozzi creava un collage, intitolato I was a Rich Man’s Plaything, in cui compariva per la prima volta la parola “pop”. A che cosa si riferisce questo termine diventato oggi così comune?
Oggi il pop è una formula giornalistica applicabile a ogni fenomeno di moda. Il pop in realtà è una sensibilità estetica che ha avuto una sua evoluzione storica e una sua definizione precisa. Io rimarrei fedele all’impostazione data da Reyner Banham e più in generale dall’Independent Group in Inghilterra a metà degli anni Cinquanta: un fenomeno è pop se raccorda in sé due dimensioni, la consumabilità e l’iconicità, adesione ai ritmi del mercato da una parte e forza simbolica dall’altra. È il consumo simbolico ciò che rende un oggetto potenzialmente pop. Penso, per fare tre esempi, ma ognuno può fare i propri, alle All Star Converse, ai Playmobil, ai gadget di Star Wars. La Pop Art è la metariflessione di questo consumo simbolico. Il pop quindi non è da identificare, come si tende a fare accademicamente, con la Pop Art né è giusto sovrapporlo in toto con la cultura di massa, sebbene questa sia una distinzione più spinosa da argomentare.
Nei tuoi libri descrivi il pop come un fenomeno di emancipazione estetica che ha un precedente nelle riflessioni di Baudelaire e che raggiunge l’apice della sua affermazione culturale in un periodo intermedio, tra moderno e postmoderno. Considerando anche le riflessioni maturate da Adorno e Benjamin, quali sono i principali aspetti del pop che possono essere indagati dall’estetica filosofica contemporanea?
Il pop “classico” è stato un’estetica che ha abbracciato circa un quindicennio (dal 1955 al 1968). Concordo con Hal Foster nell’individuare nella cultura pop una fase estrema del moderno, quel moderno che inizia con Baudelaire e che alla fine degli Anni Sessanta si muta in qualcos’altro (postmoderno?). Ne L’estetica del pop ho ravvisato la difficoltà di indagare filosoficamente il pop in quanto il pop è un fenomeno fortemente alieno al logos.
Quando Danto interpreta Warhol non è interessato al pop, ma a un esponente della filosofia dell’arte del pop. All’opposto, quando Baudrillard esprime la sua ammirazione per Warhol la sua analisi è volta unicamente a intravedere nell’artista americano una nuova forma robotica, postumana di soggettività. Ambedue quindi restringono il pop alla Pop Art e quest’ultima a Warhol.
Si tende poi a ignorare che il pop è una categoria che ormai ha più di cinquant’anni. Molti non sanno neppure che il pop, come concetto estetico, è nato in un’Inghilterra opaca e ferita dalla guerra quando un gruppo di giovani, l’Independent Group, vide nell’America e nei suoi prodotti il sogno, qualcuno potrebbe dire a buon mercato, di un benessere tangibile. Per questo il pop “è amare le cose”.
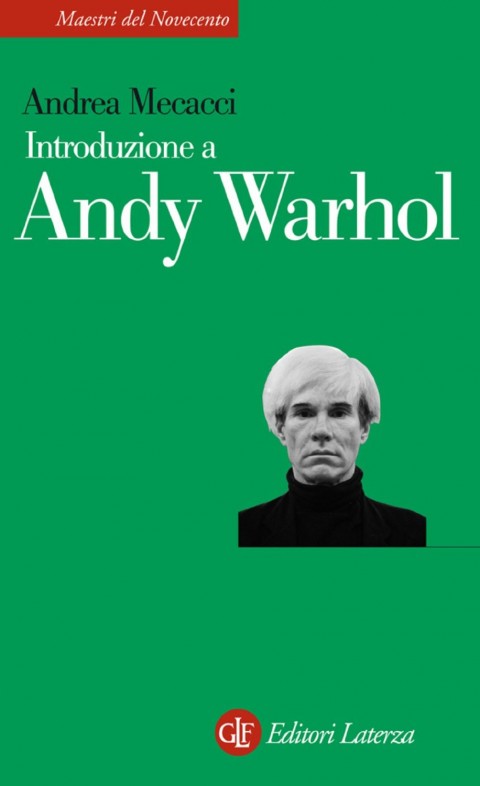
Andrea Mecacci, Introduzione a Andy Warhol, Laterza (2008)
Quale potrebbe essere il nesso tra l’affermazione del pop e quel duplice processo attraverso cui il mondo si de-estetizza nell’arte e si riestetizza negli oggetti in due modi, nelle opere e nei prodotti di design?
Il pop si inserisce in quel profondo processo registrabile a partire da metà Ottocento in cui l’arte cessa di essere l’unico tramite dell’esperienza estetica. Il pop rappresenta l’approdo conclusivo di un’estetica industriale che prima scopre il proprio fulcro negli oggetti (la merce) e poi nel superamento stesso di questa oggettività materiale (la comunicazione). Ritornano i due principi operativi della consumabilità e dell’iconicità.
Non è casuale che il design nasca a metà Ottocento, pochi anni dopo che Hegel aveva profetizzato il “carattere passato dell’arte”. La morte dell’arte è anche la rimodulazione dell’estetico in altre forme materiali. La merce, come insegna Marx, ha un fascino che l’arte è incapace di produrre. E se lo produce vuol dire che è anch’essa feticcio.
Alla luce del processo di reificazione che investe la società moderna e dell’autonomia progressivamente acquisita dall’arte, il design rimane comunque un problema ancora da affrontare in ambito filosofico. Quali obiettivi si pone una indagine estetica del design?
Il design non ha mai goduto di grande fortuna nell’estetica italiana, a parte qualche eccezione. Storicamente ha pesato l’eredità crociana, ma anche la sua relativa breve vita. Il design consente di ritornare a un’indagine della techne e soprattutto di rimettere la quotidianità al centro della riflessione estetica: un’estetica costantemente applicata alla vita, per richiamare una frase di Baudelaire.
Il design, in primo luogo il funzionalismo tedesco, è stato la grande utopia novecentesca per elaborare un gusto condiviso al di là di differenze sociali ed economiche. Pochissime cose come un giocattolo – penso a uno degli oggetti più belli mai progettati, il Bauspiel di Alma Siedhoff-Buscher, progettista del Bauhaus morta in un bombardamento nel 1944 – ci dicono in quale mondo stiamo vivendo e soprattutto in quale mondo vorremmo vivere. Dar forma al possibile, a quel possibile che ognuno di noi riconosce negli oggetti di ogni giorno, la costruzione operativa della nostra polis comune. Forse un’utopia novecentesca.
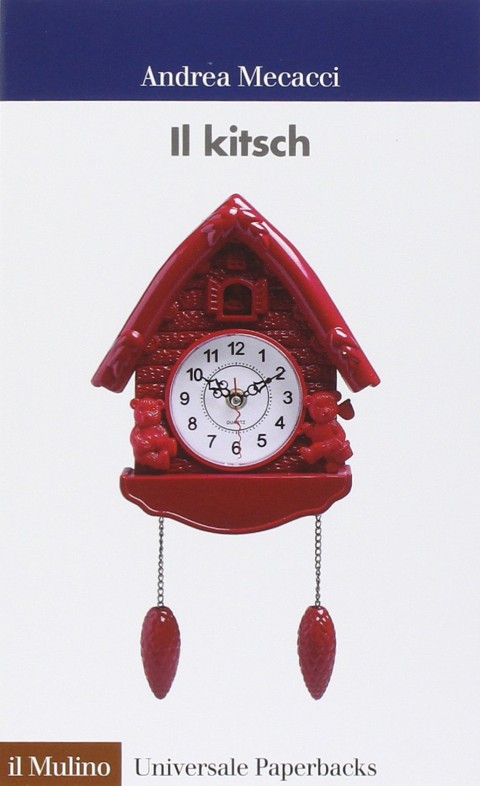
Andrea Mecacci, Il Kitsch, Il Mulino (2014)
Taluni esiti conseguiti nelle arti moderne e contemporanee, comprese diverse opere pop, motivano spesso anche una indagine del kitsch, in gran parte inteso come appariscente deriva formale emersa nella tarda modernità. Insieme al nesso con il cattivo gusto, quanto conta ai fini dell’esame del kitsch il suo rapporto con una continua oscillazione tra piacere e disgusto?
Una scorciatoia per indagare il kitsch è stata quella di riferire questo fenomeno quasi esclusivamente agli oggetti. Un’operazione legittima e utile, ma non del tutto sufficiente a comprendere questa categoria così sfuggente. Il kitsch sta all’estetica come la stupidità sta alla vita, e poiché nella vita tutti noi facciamo azioni o scelte stupide, si potrebbe dire che nessuno di noi è immune dal kitsch.
Si tende ad avere un’idea cristallizzata del kitsch. Ma il kitsch che veniva additato da Hermann Broch non è il kitsch praticato da Jeff Koons. Sono cose completamente diverse. Il kitsch è un falso sinonimo di cattivo gusto. Non tutto ciò che è di cattivo gusto è necessariamente kitsch. Il kitsch non è negli oggetti, ma nella bêtise, nell’ottusità che Kundera leggeva in Madame Bovary di Flaubert o nella pošlost, la volgarità compiaciuta che Nabokov vedeva dipinta ne Le anime morte di Gogol’. Il kitsch è nelle persone: per questo alla banalità del gusto si accompagna spesso anche la banalità del male.
Supponiamo che le dimensioni del pop, del design e del kitsch attestino il conseguimento della previsione hegeliana. Ossia, nel corso di un secolo, l’arte non coincide più con la produzione della bellezza. Questo, tuttavia, potrebbe anche coincidere con una emancipazione dell’arte, che oggi ha la possibilità di offrirci ben altro rispetto al passato. Qual è la tua opinione in proposito?
Noi siamo abituati a pensare che l’arte sia una costante della storia dell’uomo. Ma ci sono epoche che mettono in crisi questo assioma. Quando Hölderlin si chiede “perché poeti nel tempo di povertà?”, ci mostra che si danno epoche, mondi, culture in cui l’arte, la poesia sono esperienze se non assenti, almeno marginali. Non c’è niente al mondo che garantisca qualcosa come l’arte. L’estetica di Hegel è un grande affresco di questo progressivo congedo ed esilio dal bello (ossia dall’artistico). Il vero tema è la non centralità dell’arte, l’assunzione di questa consapevolezza, al di là dei singoli interessi che ognuno di noi può coltivare.
Conseguentemente il problema non è l’arte contemporanea, al di là dei giudizi che se ne possono dare, ma è l’arte. Ma forse è meglio rifarsi a qualcuno che più che parlare, agiva. Come diceva Picasso: “Che cos’è l’arte? Se lo sapessi, mi guarderei bene dal rivelarlo”.
Davide Dal Sasso
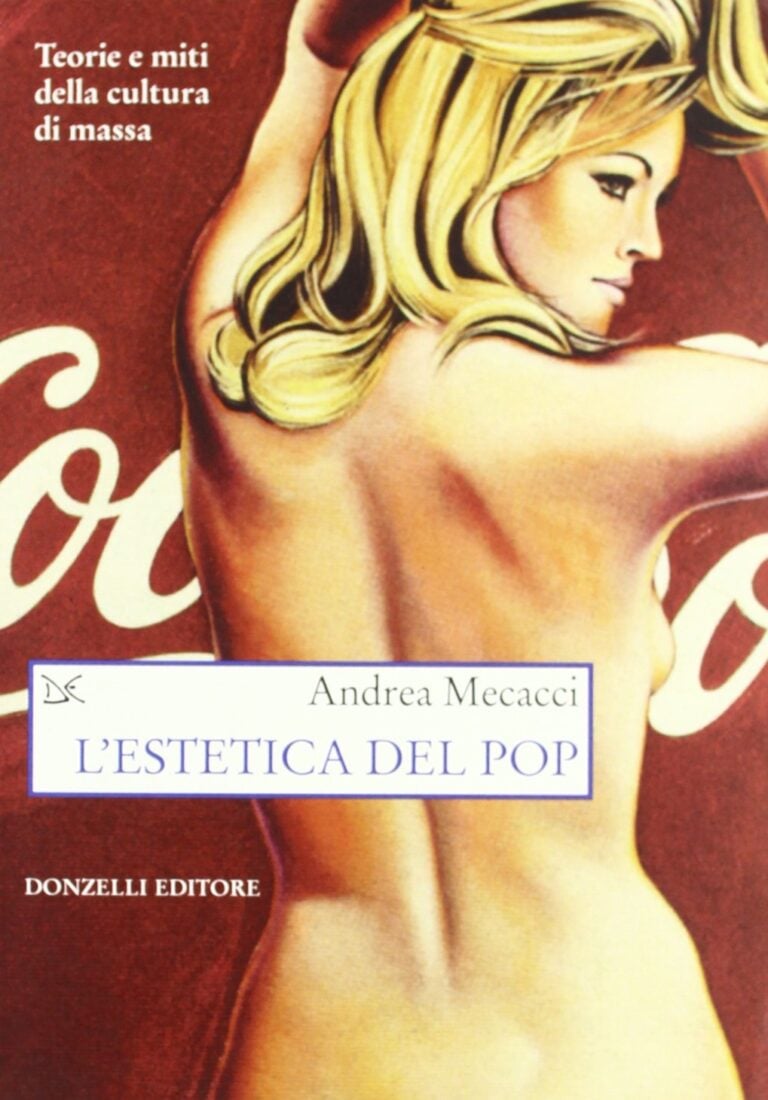 1 / 8
1 / 8
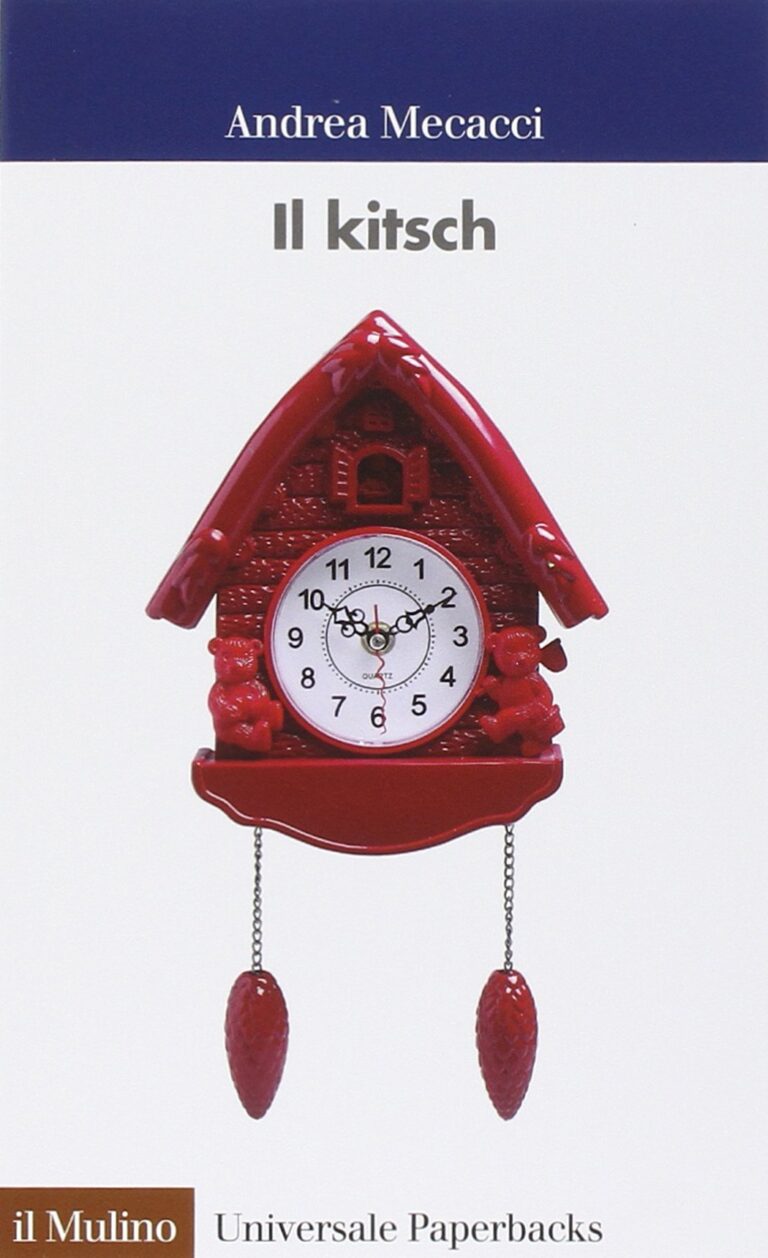 2 / 8
2 / 8
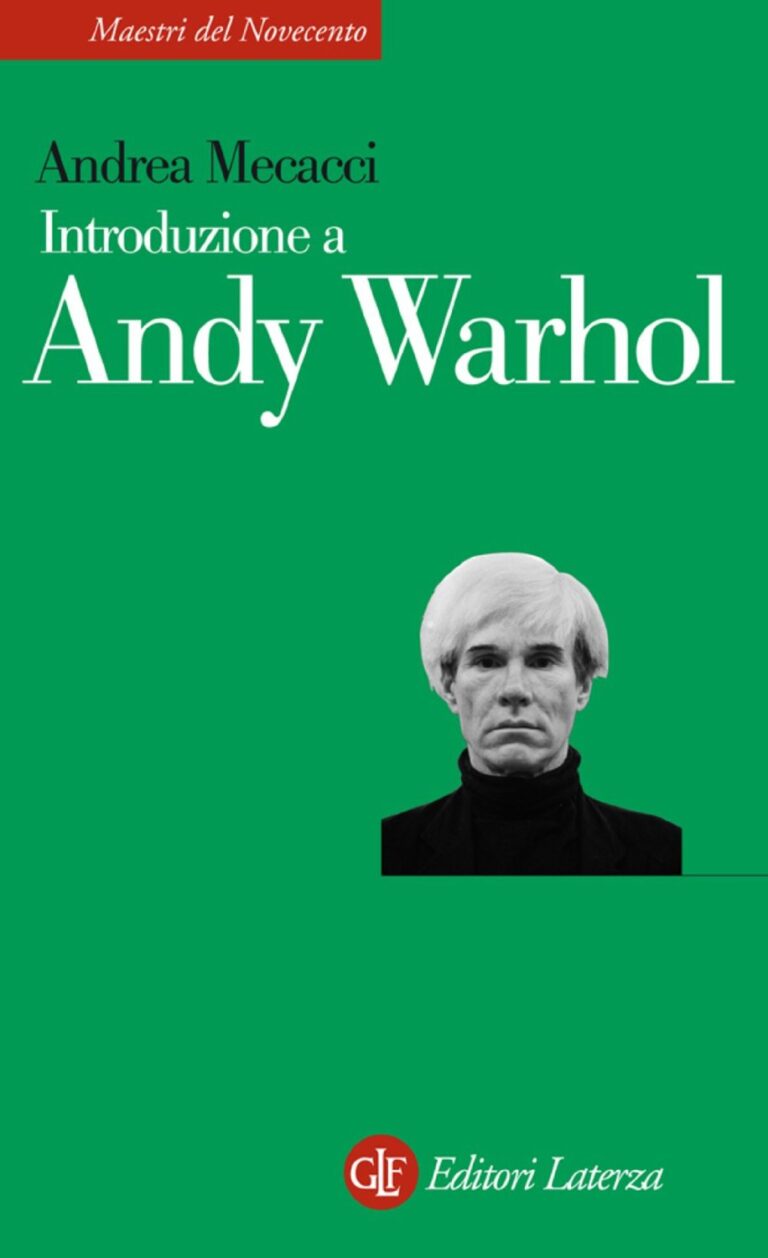 3 / 8
3 / 8
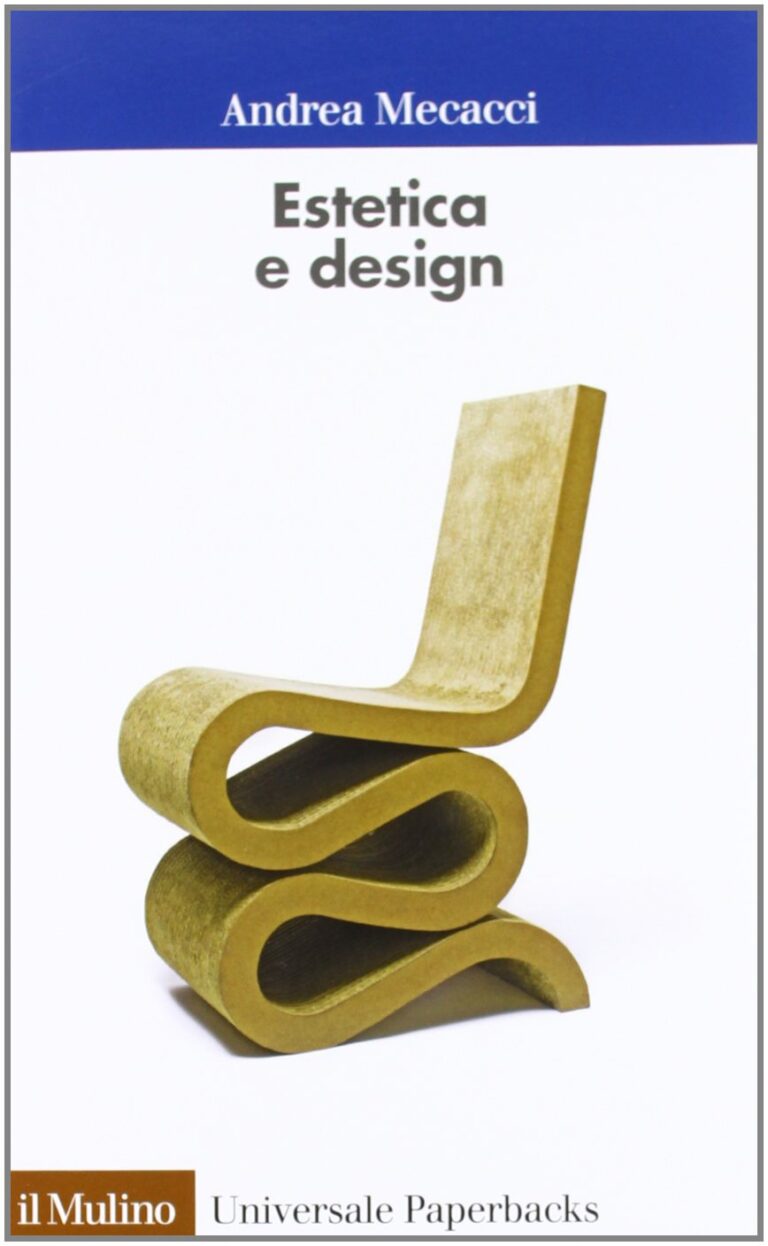 4 / 8
4 / 8
 5 / 8
5 / 8
 6 / 8
6 / 8
 7 / 8
7 / 8
 8 / 8
8 / 8
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati