Macchine americane e sigari? Hamlet Lavastida racconta l’altra Cuba
Ha girato mezzo mondo, ma di tornare a Cuba per ora non se ne parla. Eh sì, perché sull’isola non hanno gradito alcune dichiarazioni di Hamlet Lavastida. E probabilmente non gradiranno nemmeno quello che racconta in questa intervista…

Sei nato ad Avana nel 1983, hai frequentato la scuola d’arte più importante di Cuba, l’Instituto Superior de Arte di Avana, e poi sei partito per alcune esperienze all’estero. Dopo esser stato in Giappone, Corea e Inghilterra, nel 2012 sei arrivato in Polonia, per una residenza presso gli spazi del Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle e una mostra personale nella Project Room della Zacheta National Gallery di Varsavia. Fin qui tutto bene, se non fosse che, al momento del tuo rientro a Cuba, ti è stato proibito il ritorno all’isola. Cos’è successo?
Dopo le esperienze in Asia ho passato un breve periodo di tempo in Inghilterra e in Austria. Da qui sono partito per gli Stati Uniti, dove ho vissuto dal 2011. In questo stesso anno ho deciso di voler rientrare a Cuba, ma la cosa che mi è stata impedita dalle autorità. È difficile dire il motivo di questa decisione da parte del governo nei miei confronti. Posso immaginare che la causa sia stata una mia intervista rilasciata in quei mesi a un portale d’arte americano, intervista che ovviamente deve esser risultata poco gradita ai servizi cubani. Quando accadono cose simili il governo cubano non spiega mai il motivo vero dietro tali decisioni. Loro giustificano il tutto parlando di “normative”. Da chi siano decise e per quali ragioni siano messe in atto queste “normative” nei tuoi confronti, nessuno lo sa.
Per questo ho continuato la mia attività negli Stati Uniti, fino alla proposta di una residenza a Varsavia. In questi cinque anni ovviamente ho provato a tornare a Cuba, ma senza soluzione. Solo negli ultimi mesi qualcosa sta cambiando e, anche grazie alle richieste dei miei colleghi cubani, il mio caso è stato rivisto.
Prima di lasciare Avana, e conoscendo le asperità del sistema cubano, ti aspettavi una possibilità simile?
Certo, perché il mio lavoro è apertamente critico verso alcuni eventi storici accaduti a Cuba e correlati alla Rivoluzione. Sono tematiche intellettuali che analizzo e che per la loro crucialità spesso vengono accantonate dai miei colleghi, proprio per paura di ripercussioni da parte del sistema di controllo. Se in generale hai una visione controversa della politica cubana, hai molte possibilità che il governo adotti delle misure di precauzione verso di te. Devi capire che il nemico principale di Cuba non sono gli stranieri, ma i cubani stessi. Tutto quello che entra ed esce dall’isola deve essere ispezionato, per non danneggiare l’immagine della nazione all’estero.
Come vivono gli artisti cubani e che tipo di posizioni prendono nei confronti del contesto politico?
La maggior parte degli artisti cubani cerca di tenersi il più lontano possibile dalle controversie politiche. Come detto, se il tuo lavoro viene considerato dalle autorità di controllo in qualche modo scomodo, puoi aspettarti che prima o dopo il governo farà di tutto per distruggerti. Questo è, per esempio, ciò che sta succedendo a Tania Bruguera, da mesi costretta a uno stato di arresto nella sua abitazione per aver deciso di realizzare una performance collettiva nella Plaza de la Revolution di Avana. Quelli messi in atto dal governo sono metodi stalinisti che da sempre fanno parte della nostra cultura. Per questo gli artisti, in generale, preferiscono tenersi lontano da ogni tipo di posizione politica compromettente.
Per questo lasciano l’isola?
Ovviamente, perché fuori dall’isola riconquisti quello che dovrebbe essere un tuo diritto: dire ciò che pensi. Ma lì, dentro quel sistema, non ci sono le condizioni per esprimere le tue idee. Questa è la cosa terribile: manca un dibattito culturale. I servizi di controllo hanno una strategia per tutto. L’operazione è da sempre la stessa: creare un apparente clima di democrazia, dove tutti conoscono le problematiche e tutti hanno il diritto di dire, ma nessuno dice nulla, per paura.
Nel momento in cui accade che un artista, un intellettuale, o chiunque si faccia portavoce di istanze libertarie, decida di dire qualcosa, ecco che viene circondato, soffocato dal sistema, screditato, definito come “opportunista”, come qualcuno che vuole reinventare la storia, un bugiardo. È una metodologia stalinista di repressione molto sofisticata, che punta a demolire la tua personalità, a farti rimanere solo, chiuso in un circuito ristretto di persone intellettualmente menomate.
A qualunque medium tu sia ricorso, dal disegno alla pittura, dal video alla performance, la tua ricerca artistica è stata sempre il risultato di un pensiero politico ben definito. Quali sono le intenzioni teoriche dietro il tuo percorso artistico?
La mia ricerca si basa sull’immaginario creato dalla rivoluzione cubana, che è in qualche modo l’immaginario esportato da Cuba all’estero. Cerco di parlare delle contraddizioni presenti dietro di esso, le cose nascoste, gli eventi coperti o falsificati.
La storia di Cuba è piena di vuoti, soprattutto a partire dal 1959, anno di inizio della Rivoluzione. In questi decenni la memoria collettiva cubana è stata piegata, l’opinione pubblica distorta dagli organi di propaganda. La mia ricerca si basa su questi “vuoti”, situazioni storiche che non tutti conoscono o di cui il governo cubano non ama parlare. È dunque un lavoro storiografico, “archeologico” per certi versi, perché scava nel passato e riconsidera gli eventi, portando all’attenzione quelli più nascosti.
Da un’ottica europea, richiamare a un’arte “politica” porta con sé inevitabili fastidi, motivati forse dalla incapacità di dare oggi un senso ampio e puro al termine. Cosa vuol dire per te arte “politica”?
Io non credo in un’arte politica. Il punto è che forse non esiste un’arte politica, ma solo un’arte che parla di politica. Così come esiste un’arte che parla di religione, o di certi eventi storici, ma non ha bisogno di essere classificata. Preferisco vedere il mio lavoro come un’indagine nei confronti di determinate situazioni capitate nel passato e per forza di cose avvenute in un contesto politico. Parlo del background storico del mio Paese, con la volontà di creare un dibattito sui nostri eventi e su cosa la nostra rivoluzione abbia creato davvero. Ma non so esattamente cosa voglia dire “arte politica”, forse sono ancora troppo giovane per dare una risposta a questo.
Vivi in Europa ormai da diversi anni. Viste le restrizioni e i limiti strutturali del sistema cubano, quanta buona arte cubana pensi riesca ad arrivare fin qui?
Penso che solo il 2% dell’arte che arriva fin qui sia buona arte. La gente deve accettarla perché sembra non esserci altro. Ma ci sono eccellenti artisti cubani, soprattutto giovanissimi, impegnati in diverse discipline, ma non conosciuti o non considerati perché politicamente scorretti, dissidenti verso quel mondo.
La maggior parte degli artisti cubani che arriva fin qui è fatta da artisti in grado di riflettere le esigenze del mercato. La società cubana ha molti problemi, non sono politici. C’è un’assenza di connessione quasi totale col mondo, e dunque una mancanza di conoscenza verso gli eventi, interni ed esterni all’isola. Solo pochi artisti sono davvero in grado di parlare di questi problemi: sono loro quelli che io ritengo validi artisti, e raramente riescono a essere apprezzati fuori.
Quanto, più in generale, l’Europa conosce di ciò che avviene laggiù?
Credo che la conoscenza dell’Europa verso Cuba sia limitata perché relativa solo agli ultimi dieci anni. Cuba è una sorta di museo per le persone, proprio in seguito a questo immaginario collettivo creato dalla Rivoluzione: le macchine americane, la musica cubana, i sigari e tutte queste stronzate mainstream. Ma Cuba è molto più complessa. Dall’Europa tutto sembra un po’ distorto, la visione di Cuba è molto edulcorata, non controversa. È una conoscenza mediocre, perché ferma all’immaginario collettivo offerto da Castro.
Negli ultimi mesi, in seguito al passaggio politico da Fidel a Raul Castro e alla conseguente apertura dei mercati e delle ambasciate, si è parlato molto di Cuba, auspicando una nuova ventata di cambiamenti. Come vivi questo periodo da cittadino cubano?
È una fase di transizione, tutto sta capitando ora, difficile immaginare. Certo è che le cose stanno mutando, il governo sta provando a lasciare più autonomia al mercato, offrendo piccole opportunità per essere meno dipendenti dalla struttura monolitica dello stato. Per questo la gente è ottimista. Le parole di Obama hanno riacceso l’animo dei cubani.
L’arte cubana è davvero sotto i riflettori, come molti tuoi connazionali oggi sostengono?
In parte sì, nel senso che galleristi e operatori stanno esplorando con più interesse le circostanze cubane. Ma penso anche che ci sia molta speculazione a riguardo, soprattutto da parte delle gallerie americane. Quello che mi sembra è che molti collezionisti vogliano accaparrarsi delle opere di artisti cubani prima che il sistema comunista collassi, ammesso che succeda. Come dire: “Guarda, quando Cuba era ancora comunista io ho comprato questo”. È una specie di caccia all’oro forse solo fasulla, e che ritorna ancora una volta a questo immaginario “exotic” che caratterizza il nostro sistema: tutti ora vogliono un dipinto comunista prima che il comunismo venga archiviato per lasciar spazio alla democrazia.
Tra pochi mesi sarà il turno della Biennale di Avana, che quest’anno festeggerà i trent’anni. Sarà un importante appuntamento per fare il punto sulla situazione sui cambiamenti sociali in atto, o solo un’altra occasione per dimostrare l’asfissiante concentrazione politica all’interno del sistema culturale cubano?
Tutto quello che la Biennale farà sarà assolutamente controllato dall’apparato culturale del governo cubano. Io credo che sarà una Biennale molto cinica perché giocherà sugli standard occidentali, e su una visione molto pop delle cose. La Biennale d’altronde negli ultimi anni ha assunto sempre più le sembianze di una fiera artistica. Ma al momento della sua creazione, nel 1984, aveva un ruolo molto forte, era forse il primo evento artistico con intenzioni così decise: promuovere un punto di vista decentralizzato dal sistema culturale dominante nel mondo, sostenendo molta arte africana, asiatica, latino-americana. Era un punto di vista molto interessante, che cercava di dar voce agli outsider del mondo.
Ma dopo il collasso economico degli Anni Novanta il governo ha deciso di capitalizzare molto l’evento. In questo senso la Biennale oggi ha un carattere molto schizofrenico, perché da una parte prova a preservare questo immaginario originario, col tentativo di dar voce agli “esclusi” della cultura mondiale, ma dall’altro sta sposando una logica liberista che di trova esattamente agli antipodi. È solo una delle tante contraddizioni della mia terra.
Alex Urso
 1 / 8
1 / 8
 2 / 8
2 / 8
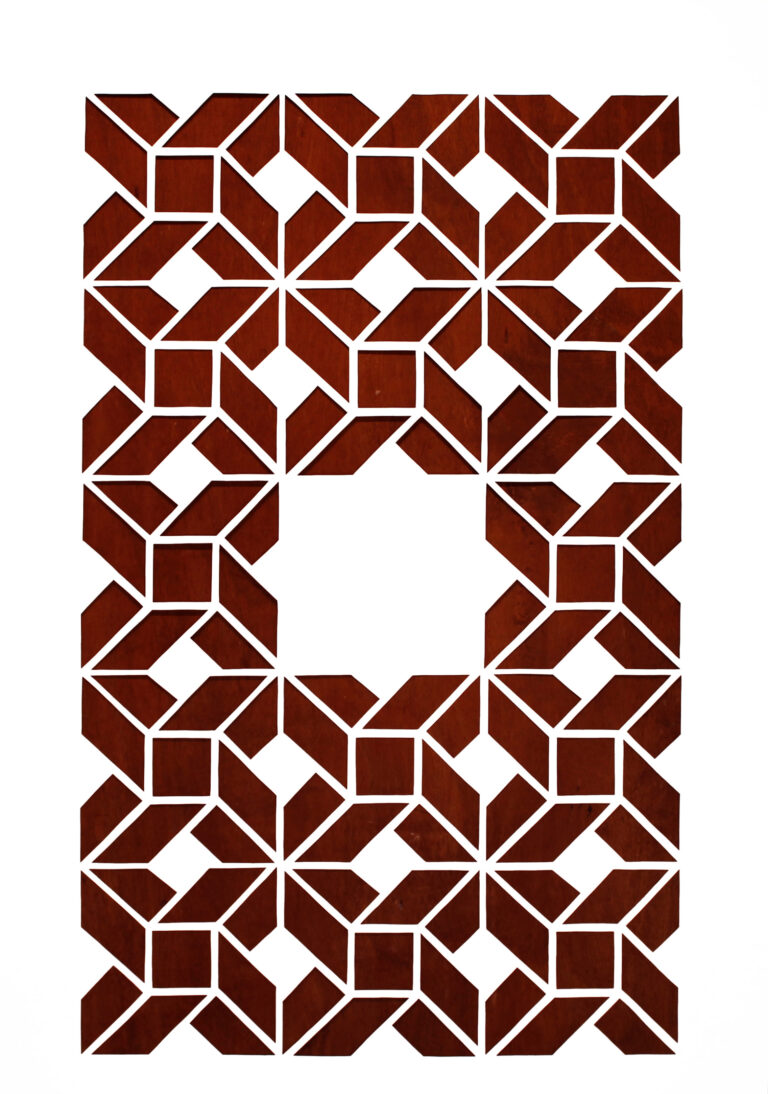 3 / 8
3 / 8
 4 / 8
4 / 8
 5 / 8
5 / 8
 6 / 8
6 / 8
 7 / 8
7 / 8
 8 / 8
8 / 8
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

















