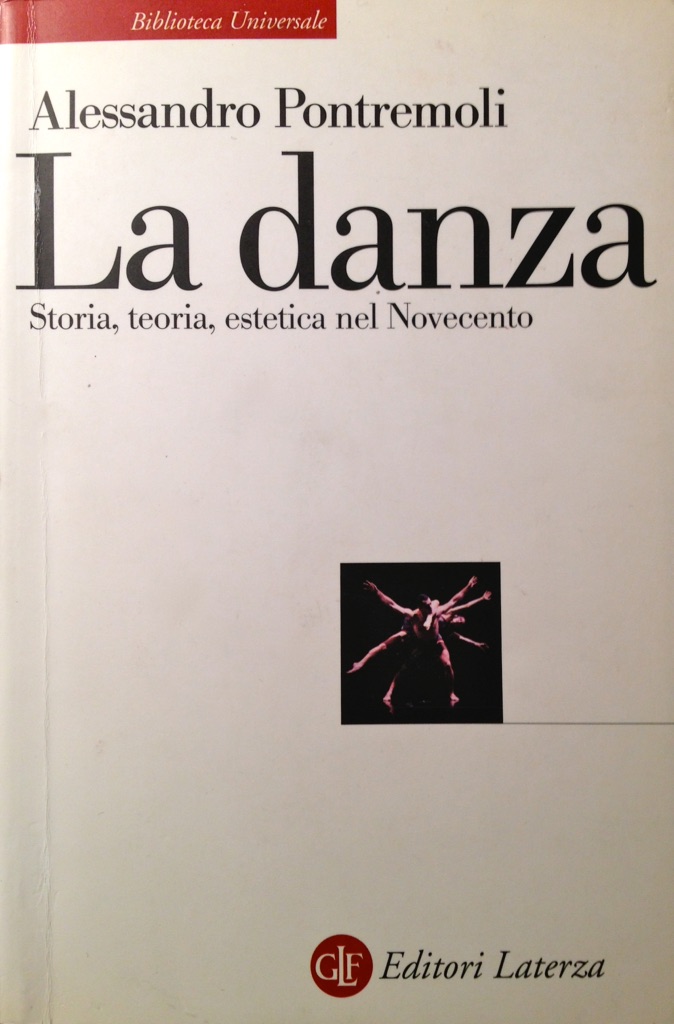Dialoghi di Estetica. Parola ad Alessandro Pontremoli
Alessandro Pontremoli insegna Storia della danza all’Università di Torino. È autore di numerosi saggi sulle forme e le estetiche coreiche e sugli scambi tra le aree di ricerca del teatro, la danza e le arti visive. Tra le sue ultime pubblicazioni, “Elementi di teatro educativo, sociale e di comunità” (Utet, 2014), “La danza. Storia, teoria, estetica nel Novecento” (Laterza, 2015) e “Storia della danza in occidente. Tra Novecento e Nuovo Millennio” (Gremese, 2015). Questo dialogo offre un’istantanea della dimensione contemporanea della danza, ponendo particolare attenzione al rapporto tra tecnica e forma, alle possibilità e ai limiti offerti dal corpo, al legame tra danza e memoria.

Consideriamo la dimensione contemporanea della danza: quali sono i tratti di continuità e quali i cambiamenti più importanti tra la danza di ieri e quella di oggi?
Provo a risponderti presentando una tassonomia cui sto lavorando, che potrebbe offrire un iniziale chiarimento. Penso alla dimensione contemporanea della danza in rapporto a tre ambiti o, come vorrei chiamarli, tre “paesaggi” di riferimento: il paesaggio museale, la terra di mezzo e gli sconfinamenti.
Nel primo caso è possibile rintracciare diversi modelli di produzione coreica in cui la danza è pensata come il prodotto di un portato tradizionale. In questo primo paesaggio emerge il tentativo di conservare alcuni tratti distintivi della danza, servendosi comunque di un corpo contemporaneo, ossia un corpo rinnovato e soprattutto socio-culturalmente costruito e relazionato in modo diverso dal passato. Per fare un esempio, possiamo pensare ad alcune opere contemporanee che riportano alla luce i tratti distintivi (la verticalità, la dimensione atletica del corpo, il virtuosismo e la competenza tecnica…) della danza classico-accademica, che nasce in epoca barocca. Il corpo contemporaneo tenta così di conservare e rimettere in atto dei prodotti che sono essenzialmente storici. Prodotti che mirano a riattivare e a rimettere in atto strategie artistiche e forme della danza del passato. È per questo che penso a una danza che chiamerei museale, proprio perché rimette in atto forme nate in un’altra epoca, e che sono comunque ben riconoscibili nel tempo.
Immagino che questa tua riflessione sul primo paesaggio presupponga anche una presa di posizione in merito al rapporto e ai ruoli della tecnica e della forma nell’opera coreica.
Assolutamente. A mio modo di vedere, tecnica e forma sono certamente legate, ma devono essere considerate singolarmente. Le tecniche non sono neutre, poiché nascono per ottenere risultati estetico-formali. Tuttavia non possono essere sovrapposte alle forme, agli esiti estetici.
Facciamo un esempio tratto dalle arti figurative. Pensiamo all’incisione di una lastra: l’artista usa le mani in un certo modo, predispone il proprio corpo così da servirsene al meglio per raggiungere il suo scopo. L’esito formale è però la lastra incisa e in seguito inchiostrata. Con l’incisione, così come con altre forme d’arte visiva, questa distinzione è più evidente. Mentre nella danza non riusciamo a coglierla così nettamente: la tecnica agisce sullo stesso strumento che è necessario per l’esito formale, ossia il corpo. Questa sovrapposizione crea non poca confusione quando si ragiona sulla danza. Il punto è che si può benissimo lavorare sul corpo utilizzando una tecnica accademica, riuscendo a ottenere un risultato del tutto moderno. È in virtù della tecnica che è possibile preparare il corpo, predisporlo al fine di raggiungere un determinato risultato estetico. E, in un certo senso, questo esito esprimerà certamente nuove possibilità stilistiche ma senza tuttavia potersi sottrarre dalla dimensione biologica del corpo. Quest’ultima impone di valutare come raggiungere quegli esiti formali facendo i conti necessariamente con le possibilità e i limiti imposti dal corpo. È in virtù della distinzione tra tecnica e forma che si potrebbe spiegare una produzione coreica che, pur appartenendo alla contemporaneità, chiamo appunto museale perché non mira a creare qualcosa di nuovo.
Che cosa intendi con “qualcosa di nuovo”?
Facciamo un esempio. Prendiamo l’opera di Martha Graham Acts of Light del 1981. Oggi può essere eseguita dalla sua compagnia o da altre che hanno acquistato il copyright di quel balletto. Rifarla vuol dire offrirla nei termini di una ricostruzione. Il suo balletto viene rimesso in atto riattivando tutto il processo che ha portato dalla tecnica alla realizzazione di quell’opera, per essere nuovamente esposto. Proprio come se fosse un’opera nuovamente esibita in un museo. La tecnica può anche essere quella classica, mentre il risultato può essere una forma tradizionale (chiusa) oppure una forma innovativa (aperta).
Il “paesaggio museale” rivela anche il legame tra danza e memoria. Eppure, solitamente, la danza è pensata come una pratica artistica effimera…
Per niente! Si tratta di un luogo comune, un errore frutto della retorica e fin troppo diffuso. Se consideriamo la grande quantità di tracce lasciate dalla danza, ci accorgiamo che essa è tutt’altro che effimera. Quando un balletto viene rimesso in atto, si parte dalle sue tracce al fine di poterlo nuovamente esporre. La danza ha una modalità propria di lasciare memoria di sé. Una modalità di produzione delle tracce che la rende diversa da quelle di altre pratiche artistiche.
Questa specificità – che, insisto, è propria della danza – ci permette di comprendere come il primo paesaggio si basi su due fattori principali: l’esposizione (i corpi che danzano sono guardati da qualcuno) e la conservazione (ossia la possibilità di avere memoria della danza proprio al rinvenimento delle sue tracce).
Torniamo alla tua tassonomia. Come si caratterizza invece il secondo paesaggio, la “terra di mezzo”?
Possiamo pensarlo come un paesaggio in cui avvengono dei cambiamenti, che tuttavia sono metabolizzati dai principali attori che supportano le produzioni coreiche. Nella terra di mezzo, il cambiamento nella danza è metabolizzato dai produttori, i coreografi, i danzatori. Persino dal suo pubblico. A caratterizzare questo paesaggio è l’eclettismo di stili e tecniche ma in virtù del rispetto dei linguaggi e dei sistemi di movimento che provengono dal primo paesaggio, dalla tradizione storica della danza.
Sono dell’idea che sia stato Maurice Béjart ad aver aperto gli orizzonti per questa terra di mezzo. Lui è il primo che ha messo in discussione una formazione accademica attraverso l’introduzione di tecniche extra-coreutiche. Questi elementi (per esempio taluni gesti provenienti dal Tai Chi o da altre discipline sportive) vengono inglobati nel balletto, lasciando però che possano essere altrettanto riconosciuti i suoi elementi più tradizionali. Una parte di pubblico è capace di individuare questi tratti, anche perché in gran parte appartengono già al patrimonio culturale del pubblico della danza del primo paesaggio.
Le opere che appartengono alla “terra di mezzo” possono allora essere pensate come i risultati di un processo di ibridazione che andrà comunque a modificarsi nel corso del tempo?
La terra di mezzo nella danza contemporanea offre un paesaggio molto variegato. Al suo interno possiamo trovare opere neo-classiche o post-classiche, autori che non sempre conservano gli elementi tipici della tradizione, che lavorano appunto sulle ibridazioni come suggerisci tu.
Ho in mente Merce Cunningham. Il suo corpo di ballo e le sue produzioni sono convinto che appartengano al primo paesaggio (museale). Mentre Cunningham che balla da solo, proprio perché invece riesce a conservare e rendere visibili quei tratti tradizionali pienamente riconoscibili, credo possa stare senza dubbio nella terra di mezzo.
Prendiamo invece William Forsythe, alcune sue opere degli Anni Ottanta e Novanta sono state efficacemente considerate opere post-classiche. Nonostante Forsythe sia totalmente rispettoso della tecnica classico-accademica, il suo obiettivo è di “stressarla” così da portarla fino alle estreme conseguenze. Ma quando arriva all’apice della drammaturgia, raggiunge in realtà un esito che, potremmo dire, è in gran parte convenzionale. La quiete viene sottratta, il rischio e la velocità determinano che la drammaturgia sia alterata. E questo è possibile trasfigurando la tecnica. Nonostante il virtuosismo sia portato agli estremi, non ci saranno comunque rischi o conseguenze negative. Tutto si risolverà in un lieto fine.
In questo caso, nelle opere che appartengono alla terra di mezzo, che relazione si crea tra tecnica e forma?
Torno ancora un momento sul lavoro di Forsythe. Prima ti dicevo che possiamo individuare il post-classicismo anche in rapporto alla sua scelta di stressare la tecnica fino a trasfigurarla. Su questo vorrei adesso chiarire alcuni aspetti che riguardano proprio il nesso tecnica-forma. Sono tre i fattori principali in base ai quali Forsythe riesce nel suo intento di stressare la tecnica e dunque di alterare la forma. Il tempo (la velocità determina il rischio); lo spazio (è il suo uso della luce che contribuisce a destrutturare lo spazio e a renderlo irriconoscibile); infine, l’equilibrio (la drammaturgia viene fortemente compromessa dall’ansia in modo da essere privata del suo equilibrio). Questi fattori rivelano una sorta di scambio tra tecnica e forma, mostrando l’adozione di un principio molto semplice: stressando l’una si otterrà l’alterazione dell’altra.
Passiamo adesso agli “sconfinamenti”, al terzo paesaggio.
Anche in questo caso dobbiamo fare i conti con una molteplicità di risultati diversi. Inizio dagli estremi, ossia dalla dissoluzione delle estetiche. Voglio subito chiarire che non si tratta però di individuare una pars destruens. Al contrario, penso a questa dissoluzione nei termini di un’assunzione di una nuova responsabilità che si è verificata nel mondo della danza. Le dissoluzioni estetiche coincidono infatti con la negazione della forma, degli stili, e persino delle tecniche.
Procedendo a ritroso, nella terra degli sconfinamenti, troviamo la danza concettuale – detta anche non-danza – e quella che potremmo intendere come una variante del post-modernismo, la danza trans-moderna. In qualche modo queste dissoluzioni rivelano una condizione subculturale che è decisiva per tutti gli sconfinamenti.
È davvero difficile non pensare a tutto questo nei termini di una pars destruens che caratterizza la dimensione contemporanea della danza.
Si tratta di cogliere l’aspetto centrale della dissoluzione come consistente nella sostituzione di qualcosa con qualcos’altro che non è ancora definito. Nel terzo paesaggio, la danza mostra solo in minima parte a quali esiti giungerà poiché le sue trasformazioni sono tuttora in corso. Si coglie qualcosa che sta mutando, ma non si capisce esattamente di che cosa si tratti. Per questo, sono dell’idea che in generale vi siano almeno tre tipi di sconfinamento in questo paesaggio: metodologico, concettualista e transmodernista.
Fermiamoci un momento sulla non-danza: come operano i concettualisti?
Mirano soprattutto a mettere in discussione alcuni concetti chiave della danza. Per esempio, si potrebbe sostenere che sia un dato acquisito che la danza è movimento. E se non fosse così? Se la danza non è movimento, allora che cos’è? Jérôme Bel con Shirtology (2012), la sua pièce in cui si toglie circa quaranta magliette, agisce in modo da sostenere che togliere una maglietta è danzare. Perché non dovrebbe esserlo?
Rimettere in discussione queste idee di base non vuol dire per forza sottrarsi alla danza. Numerosi concettualisti oggi rivendicano la loro natura di coreografi, ossia di autori che hanno scritto la danza in un modo diverso dalla tradizione. In questo modo essi riescono, allo stesso tempo, a mettere in crisi il concetto di “danza” e a mostrarne le strutture profonde della pratica, rivelando anche i suoi tratti compositivi e processuali.
E come si completa la mappa di questo terzo paesaggio?
Con altri due sconfinamenti, quello transmoderno e quello metodologico. Nel primo caso, gli artisti riprendono i canoni introdotti nel postmodernismo, per esempio riprendendo l’idea di servirsi di un corpo naturale. Un’idea utopica. I corpi della danza contemporanea sono tutt’altro che naturali, sono evidentemente più che preparati al fine di poter fare quasi tutto. L’idea, per capirci, è però di preparare e di mostrare dei corpi che non sono canonici, ma che anzi possono essere il corpo di chiunque. Qualsiasi corpo, pensato utopisticamente come naturale, può essere funzionale al raggiungimento di determinati risultati. Senza escludere nessuna riflessione sul corpo, senza rinunciare alla centralità dei processi e della metodologia.
Il rigore coreografico e metodologico caratterizza perciò anche alcune opere transmoderne pensabili come reazioni al concettualismo. Possiamo prendere come esempio i Dieci miniballetti di Francesca Pennini di Collettivo cinetico (2015). In circa quaranta minuti, si passa da momenti in cui Pennini conta i suoi respiri e quelli di alcuni spettatori sui quali si siede, all’entrata in scena di un drone che riesce a far danzare una montagna di piume, arrivando ai miniballetti in cui Pennini si serve della tecnica e della preparazione del corpo per fare danza in modo più tradizionale.
Che differenza c’è tra questo atteggiamento rigoroso, e al contempo di rivelazione della struttura dell’opera, da quello più seccamente concettualista?
Possiamo pensarlo proprio come una reazione al concettualismo, che per certi versi lo riprende ma in fondo lo critica arrivando anche, in taluni casi, a ridicolizzarlo. Questo atteggiamento apre a quegli approcci che prevedono lo scambio relazionale e partecipativo, anche senza dover produrre opere che siano incentrate in prevalenza solo sull’analisi o la critica. Le opere coreiche, in questo caso, sono il risultato della sempre più evidente fusione tra danza e teatro.
Provo a introdurre questo scenario portando subito un esempio: in occasione del Festival di Santarcangelo è stata presentata La piattaforma della danza balinese. Anziché essere un’opera costruita su riferimenti antropologici e culturali ecc., come lascerebbe appunto supporre il suo titolo, è invece un contenitore giocato anzitutto sull’idea di “piattaforma”. Il progetto si chiama così perché nasce come forma di contestazione delle piattaforme ministeriali attraverso le quali vengono mostrate le produzioni italiane agli osservatori che potenzialmente le compreranno. L’obiettivo è perciò la sottrazione dalle condizioni del mercato della danza. L’aspetto più importante da considerare è che all’interno di quel contenitore può succedere qualsiasi cosa. Le pièce possono essere di qualsiasi durata, eseguite tecnicamente avvalendosi di qualsiasi stile. Taluni artisti sono presenti appositamente per suscitare un dibattito. Si tratta pertanto di uno spazio, di uno sconfinamento della danza nello spazio degli scambi e delle relazioni in cui possono accadere cose molto diverse.
La dimensione relazionale e partecipativa contraddistingue ormai numerose pratiche artistiche contemporanee. Pensi che gli sconfinamenti della danza possano essere considerati rapportandoli anche a questo più generale tratto distintivo dell’arte odierna?
Sì, certo. Lo sconfinamento rivela questa dominante etica, che nella ricerca contemporanea produce i suoi più alti risultati soprattutto nella danza di comunità. Il primato della partecipazione, della relazione con l’altro e dallo scambio che può essere istituito tra chi è parte della pièce sono oggi elementi decisivi per la dimensione contemporanea della danza. Senza dimenticare che vi è anche un primato della trasmissione di un sapere, quello dell’artista, che viene offerto a chi partecipa alla sua pièce. La qualità di queste attività è alta, e i risultati che possono essere raggiunti sono davvero imprevedibili. Talune pièce non diventano neppure opere d’arte in senso stretto. Rimangono piuttosto dei processi aperti dato che sono soggetti a continua modifica. In questo caso si tratta di una trasformazione della danza in eventi che si collocano a metà tra la vita, la loro produzione e le numerose possibilità esperienziali che offrono.
Penso per esempio al Vangelo secondo Matteo di Virgilio Sieni, in cui prevale proprio la dimensione partecipativa della comunità: dopo un anno intero di lavoro, quasi duecento non professionisti di tutte le età hanno messo in scena alla Biennale Danza di Venezia, nell’estate del 2014, ventisette quadri del Vangelo, in una composizione costruita dal coreografo a partire da gesti semplici e “naturali”, ma efficaci e carichi di senso, delle persone comuni coinvolte nel processo di comunità.
Davide Dal Sasso
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati