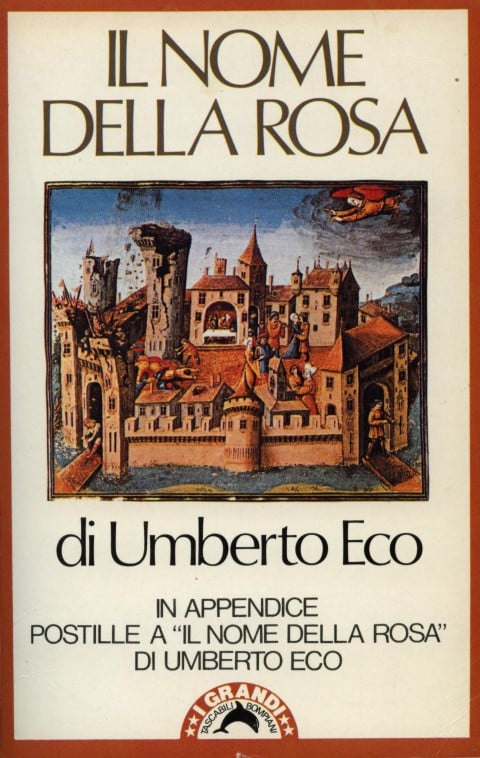In memoria di Umberto Eco. L’editoriale di Michele Dantini
Proseguiamo la serie di omaggi, ricordi e riflessioni a seguito della morte di Umberto Eco. Dopo l’intervista che Obrist ha realizzato l’anno scorso con il professore, ora è il turno di Michele Dantini. Che legge la svolta narrativa di Eco come un “esilio interno”.

FINE DI UN’EPOCA
Non sono né sono mai stato un incondizionato ammiratore di Umberto Eco, al contrario. Ma sono colpito dalla notizia della sua scomparsa, così inattesa e – vogliamo dirlo? – allegorica sotto aspetti determinati. È un’intera stagione della storia culturale italiana recente che ci lascia con Eco, la stagione dei “novissimi”, della vorace acculturazione, dei propositi (tutt’altro che peregrini) di “civiltà industriale” e di un’avanguardia giocata su piani di “ordinarietà” istituzionale.
Il rifiuto dell’istrionismo vieux jeu; l’attenzione sempre desta per la congiuntura storica, senza velleità di evasione; l’ampiezza di interessi, giunta più di recente a includere l’arcano, l’ipererudito, il bizzarro. La chiarezza di scrittura, che ha reso Eco uno tra i rari public intellectual italiani, capaci di variare dal trattato teorico, che forse oggi ci interessa meno, all’editoriale o al pezzo di costume concepito pur sempre come microsaggio storico-antropologico. Infine l’attitudine all’asciuttezza – quell’asciuttezza che nella prefazione a una delle tante serie di saggi Eco riconduceva a un “afascismo” antropologico di Alessandria, sua città natale, e della provincia piemontese; e che talvolta poteva persino confinare nell’avarizia di coinvolgimento e di emozione.
Tutto questo ci mancherà, come pure l’orgoglio a suo modo regale dell’uomo di lettere di fama internazionale, giunto per merito d’ingegno ai vertici della società, umanista e scienziato insieme; pronto a portare coraggiosamente in piazza gli stracci del potere politico e a rivendicare alla cultura una giurisdizione autonoma.
IL ROMANZO COME ESILIO
Ammetto di non avere mai avvertito la necessità di approfondire la conoscenza di Eco romanziere, disinteressato come sono ai giochi celibatari dell’intelligenza combinatoria. Se d’altra parte Eco è sempre rimasto un fine storico e allegorista del tempo presente, questo non è accaduto invece agli emuli ed epigoni, sin troppo versati nell’arte dell’omaggio, persi tra cruciverba e bibliofilie da caminetto invernale.
Tuttavia, vorrei ribadire, questo “ritiro di interesse” in cui oggi si attarda l’ala più mediatizzata della scuola semiologica per più versi tradisce l’insegnamento di Eco: che ancora con il Nome della rosa, dunque alle origini della svolta narrativa, ci ha lasciato il romanzo storico dell’Italia contemporanea. Lo ha sigillato nell’enigma medievale, è vero, o nella convenzione del giallo archeologico: ma questo che importa? Vale invece la pena osservare che proprio la migrazione dal saggio (o dal trattato) al romanzo implica al tempo per Eco una scelta di esilio interno, di silenzio metaforico dell’intellettuale e abbandono – per impossibilità e scacco sopraggiunti – della propensione “militante”.
LE CONSEGUENZE DI UNA SCELTA
Credo dobbiamo ancora misurarci affermativamente con l’impasse descritta da Eco, trarne conseguenze e implicazioni. L’”esilio interno” è diventato un po’ il destino delle generazioni successive: azzardato per loro confidare nell’attenzione di istituzioni politiche e sociali. D’altra parte ricerca e movimenti possono cooperare reciprocamente: occorre però comprendere in che termini e a quali condizioni.
Michele Dantini
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati