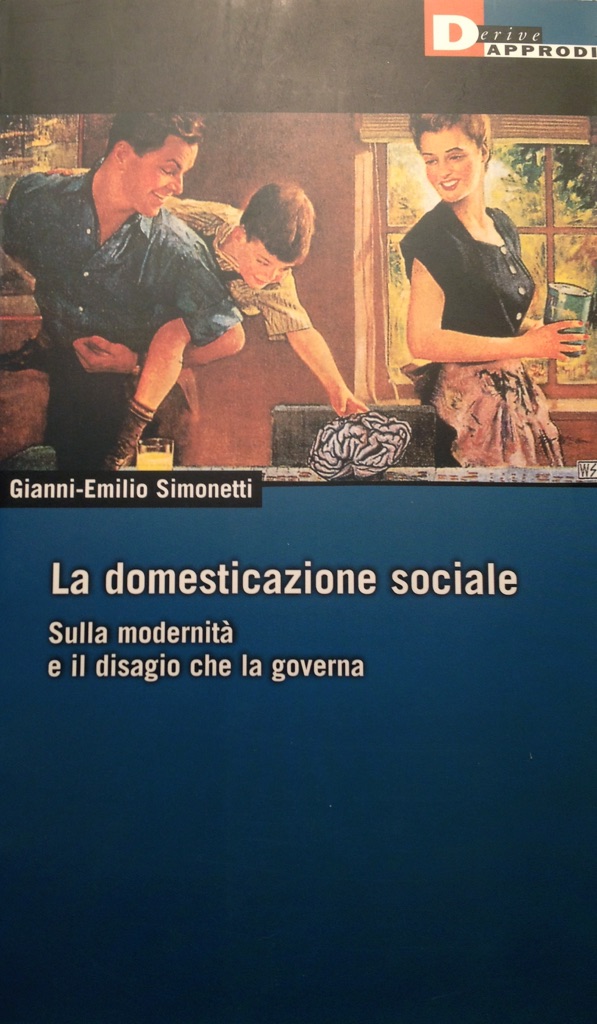Dialoghi di Estetica. Parola a Gianni Emilio Simonetti
La sintomatologia dell’arte è il tema centrale di questo dialogo con Gianni Emilio Simonetti. Quella che doveva essere una riflessione sulla funzione dell’arte si trasforma in una conversazione incentrata sui problemi della forma, sull’artificazione e l’autoreferenzialità come eredità dell’avanguardia. E ancora, sulle illusioni dell’arte concettuale e sulla natura di Fluxus.

La storia di Gianni Emilio Simonetti affonda le radici nelle esperienze avanguardistiche della metà del secolo scorso. Esponente del Situazionismo italiano e tra i partecipanti al movimento Fluxus, l’artista e teorico è anche curatore di rassegne spesso incentrate su ambiti e tematiche alla base della propria formazione – dal concettuale alla performance al valore del linguaggio –alcuni dei quali affrontati anche in questa intervista.
Proviamo a pensare all’arte e – uso una parola probabilmente inadeguata – alla sua funzione. Penso sia una questione che in fondo riguarda il fare o, meglio, la possibilità di creare arte. Che cosa ne pensi?
La parola creare è sospetta. È infetta, perché si tende facilmente a ideologizzare il concetto di creatività… tuttavia, provo lo stesso a seguire il tuo spunto. Partiamo da lontano, lasciando però a margine la lettura funzionalista. Fino alle avanguardie, l’arte è stata rappresentazione del Lebenswelt (il mondo della vita, secondo Husserl tanto il mondo concreto quanto la relazione che l’uomo ha con esso).
Su questo, è importante fare subito un inciso: è da qui che deriveranno poi quelle bizzarre associazioni tra arte e vita, diffuse durante lo scorso secolo e che credo siano davvero sospette. Nel periodo delle avanguardie, gli artisti si rendono conto che l’arte intesa come rappresentazione era diventata un guscio vuoto. Ho l’impressione che il loro intervento sia consistito nello sfasciare questo guscio, ossia nel banalizzare l’arte.
In che modo è stato sfasciato il guscio e che cosa è successo dopo?
Prendi Hugo Ball, artista dada e cofondatore con Hemmy Hennings del Cabaret Voltaire: si veste di cartone e recita poesie senza senso… Il risultato di questa banalizzazione è stato che l’arte è diventata autoreferenziale. E, diventando autoreferenziale, ha iniziato a rispondere alle istituzioni.
Non sono d’accordo, penso che questa tua idea sia discutibile. Voglio dire, in che modo l’arte, che per sua natura è legata alla relazionalità sociale e allo scambio tra chi la crea e chi ne potrà fare esperienza, può essere altrettanto autoreferenziale?
Va bene, discutiamone. Provo a spiegarmi così: che cosa sono la cosa, l’oggetto e l’opera? La cosa è l’indistinto, l’indeterminato. L’oggetto è invece ciò che ha un fine, uno scopo. L’opera è l’oggetto in cui è preminente, diciamo così, l’imprinting della condizione umana. Tant’è vero che un oggetto lesionato non serve più a nessuno. Ma se tu quest’estate trovi per caso al mare un’antica statua greca tra la sabbia, anche se le mancassero le braccia o il capo, questa conserverebbe comunque l’imprinting della condizione umana essendo un’opera.
Torno allora di nuovo alle avanguardie: quando Duchamp inventa i ready made, abbiamo la regressione dell’opera all’oggetto. Non è un caso che da quel momento, per giustificare questa regressione, vengono introdotte diverse teorie concettualiste. È così che si arriva dritti all’autoreferenzialità e al nuovo rapporto con l’istituzione. Questa aveva una funzione amorfa fino al momento in cui si è diffusa quella che, con un neologismo, possiamo chiamare artificazione. Vale a dire la capacità di costruire una confabulazione retorica al fine di trasformare qualunque cosa in arte. In fin dei conti, l’artificazione dipende dal potere – nelle sue diverse forme (economico, politico, ideologico…) – che possiedono le istituzioni pubbliche e private di rendere arte quel che vogliono. Ma, e questo è cruciale, in fin dei conti l’artificazione serve a rianimare l’ordine simbolico.
Approfondiamo questo nesso tra ordine simbolico e artificazione.
Subito: l’ordine simbolico rimanda immancabilmente all’incontro con l’altro.
Sì però, se l’artificazione rianima l’ordine simbolico che appunto potremmo intendere anche come incontro con l’altro, non pensi che l’autoreferenzialità di cui stiamo parlando venga meno?
No. Perché, non dimentichiamolo, è la forma a dominare sul significato. Che cosa vuol dire questo? Forse che alla fine il significato affonda poiché – come sostiene l’antropologo James Clifford – la cultura è essenzialmente percorso. Anche l’arte possiamo pensarla come insieme di percorsi. E quando la intendiamo in questo modo, stiamo ragionando su ciò che chiamiamo performance. Quel che conta nella performance sono le intenzioni e non gli oggetti. Ma qui ci troviamo di fronte al massimo fallimento delle illusioni dell’arte che voleva essere concettuale e non ci è riuscita proprio per via dell’artificazione.
Perché?
Beh, perché l’artificazione mira al controllo delle strutture simboliche e, contraddicendo le ultime illusioni dell’arte concettuale, favorisce l’introduzione della performance.
Quali sarebbero le ultime illusioni dell’arte concettuale?
Tra queste, per esempio, abbiamo la scelta di fare non-arte dando però l’impressione di fare arte. Una pura illusione, perché alla fine si torna sempre alla forma e quindi all’autoreferenzialità.
Possiamo fare a meno della forma?
La forma permette di classificare i sintomi. Il problema è che, d’altra parte, il significato si adegua alle illusioni della storia. Che cosa sia la storia, non lo sappiamo con certezza. A me piace pensarla come una previsione sul passato. Ma, andando per parallelismi, la sintomatologia appare e scompare nella storia e altrettanto nell’arte proprio grazie alle forme che può assumere.
E come la mettiamo con l’autoreferenzialità? Anche perché gli oggetti, con le loro forme, non sono mai del tutto spariti in arte…
Qualche anno fa mi è capitato di andare al Museo d’arte moderna di Nizza perché volevo vedere una performance di un artista Fluxus che mi interessava. Per vederla bisognava andare su una terrazza e per arrivarci si passava da una sala piuttosto grande, apparentemente vuota. Quando sono entrato in questa sala, la mia attenzione è stata subito catturata da una mamma che insisteva a chiamare la sua flglioletta, che però non la ascoltava perché era tutta presa dai suoi giochi. Sulle prime, mentre passavo, non avevo notato un dettaglio. Poi mi sono fermato e, quando sono tornato indietro, mi sono accorto che la bimba era davvero felice perché si divertiva a saltare su un lamiera quadrata, divisa in quattro parti quadrate poggiate a terra: la bimba si divertiva perché saltava sulla forma!
Lasciamo un attimo da parte i problemi della forma. Proviamo invece a concentrarci sulla performance. C’è un punto che mi interessa in particolare: la questione del concetto è strettamente legata all’azione. Allo stesso tempo esso sottostà alla casualità, al flusso degli eventi. Gran parte di questo profondo legame è già presente in Fluxus, non credi?
L’eversione non può essere mai concettuale. In fondo in Fluxus si tratta di qualcosa di eversivo ma non di rivoluzionario. La rivoluzione implica una coscienza storica, mentre l’eversione è piuttosto un capovolgimento meccanico.
Però, arrivare al capovolgimento non esclude di avere delle premesse progettuali. In fondo, gli artisti di Fluxus hanno mostrato anche questa possibilità: a forza di procedere con delle inversioni, dobbiamo continuamente rivedere la nostra idea di arte.
Bene, Fluxus. C’è un meraviglioso racconto di Franz Kafka, Josephine la cantante o il popolo dei topi (1924), con cui possiamo affrontare la questione che poni. Insieme a presentare il problema socio-politico della cantante che non sa cantare come potrebbe capitare a chiunque di noi, Kafka descrive anche un problema che non possiamo trascurare: se io salgo su un palcoscenico per schiacciare una noce, non è che voglio mostrarti come si schiacciano le noci perché, in fondo, tutti sanno schiacciare una noce. Evidentemente, voglio dirti qualcos’altro. Ma, se uno sale su un palcoscenico e si mette a schiacciare le noci, vuol dire solo due cose: o ha inventato una nuova arte nello schiacciare le noci, oppure per dirci quello che vuole dire deve essere meno abile degli altri a schiacciare le noci. Questo è Fluxus!
Si tratta di saper vedere e di non stare a confabulare convinti che l’arte sia sempre la stessa cosa.
Qui emerge un problema concettuale che riguarda soprattutto la critica d’arte. Quando ero studente, spesso rimanevo esterrefatto quando mi capitava di assistere a una lezione in cui si presentavano delle critiche al lavoro di un artista sulla base di minuziose descrizioni delle diapositive delle sue opere. Il punto è che forse, come a suo tempo avevo avuto l’occasione di imparare da Enzo Paci nelle sue lezioni su Merleau-Ponty, l’importante è essere capaci di distinguere il visivo dal visuale. Nella critica, questa rimane una lacuna.
Guardare qualcuno che schiaccia le noci e accettare che quel che fa sia anzitutto schiacciare le noci, però può sembrare fin troppo semplice. Che fine fa la performance in tutto questo?
La performance nasce da due cose. Da una parte essa proviene dalla pulsione della forma merce verso l’immateriale. Oggi quello che conta è il brand non l’oggetto! Non c’è dubbio che oggi il dominio del manifatturiero è sempre più presente, ma la tendenza generale è rivolta verso i valori dell’immaterialità. Dall’altra parte, troviamo invece l’estetizzazione della vita corrente.
Sono d’accordo sull’attrazione esercitata dall’immaterialità. Tuttavia, se dici estetizzazione della vita corrente, viene da pensare alla possibilità che hanno gli artisti di restituircela attraverso qualche soluzione formale.
Sto parlando di estetizzazione e penso all’aisthesis. Il problema dell’estetizzazione è estremamente importante perché permette di bypassare il sintomo e di riconciliarci con i processi di simbolizzazione. Dentro alla performance si banalizzano i significati, si uniforma a una dòxa impossibile il senso e si annulla la distanza tra spettatore e opera. Questo annullamento infatti è decisivo, nella performance lo spettatore non è più un testimone ma un complice.
Davide Dal Sasso
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati