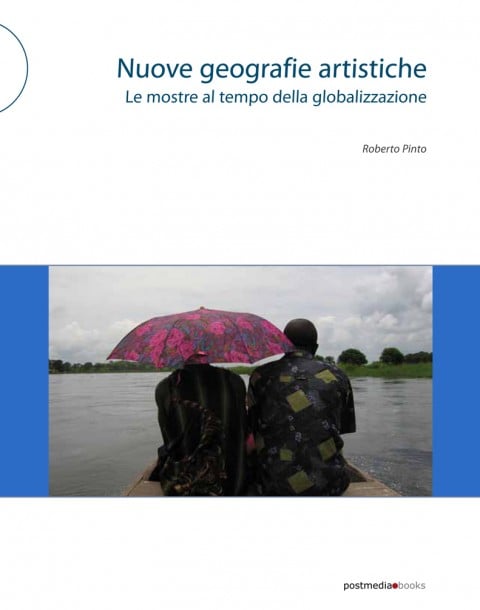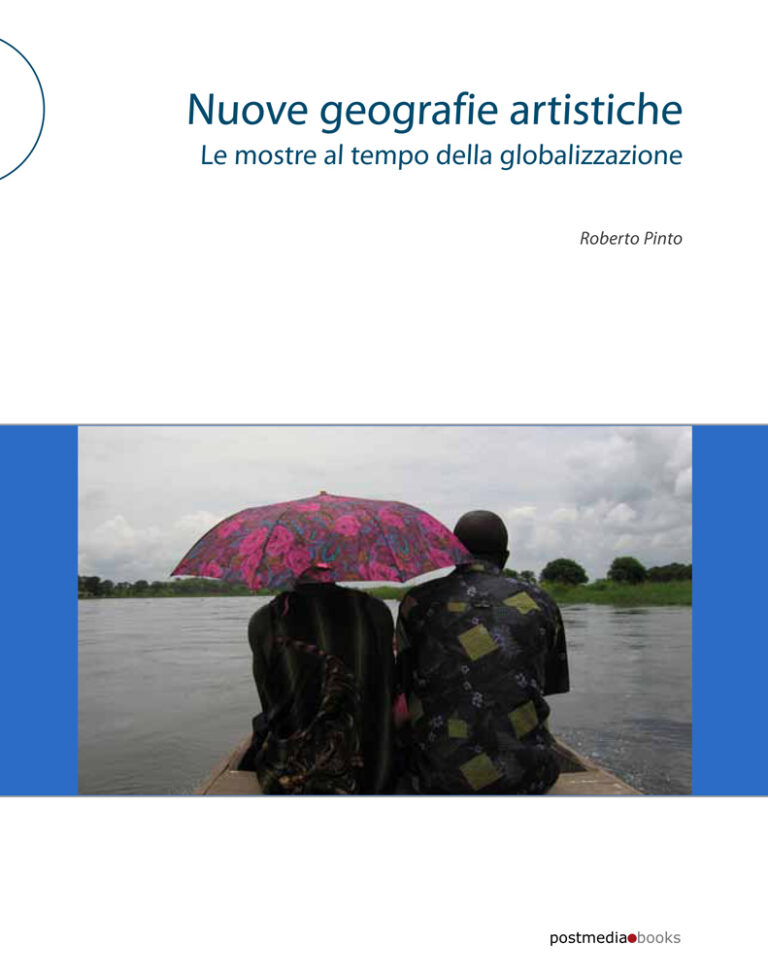Città critiche: Milano. Il racconto di Roberto Pinto
Ieri c’era Tommaso Trini che, in dialogo con Alberto Zanchetta, ha raccontato la grande Milano degli Anni Sessanta. Oggi la parola passa a Roberto Pinto, e i decenni sono gli Ottanta e i Novanta. E se siete curiosi di quali altri contenuti potete trovare su Artribune Magazine numero 30, passate a prenderne una copia al nostro stand di Miart.

La Milano degli ultimi decenni è stata un luogo di grandi slanci ma anche di delusioni, di avanguardia ma anche di restaurazione. Di contraddizioni, insomma. Per uno sguardo privilegiato sulla città a partire dagli Anni Ottanta e Novanta fino ad oggi, abbiamo interpellato Roberto Pinto. Curatore di molte mostre pubbliche a Milano (alcune con il capoluogo lombardo come argomento), caporedattore di Flash Art in anni cruciali, ha da poco lanciato il progetto di arte pubblica ArtLine.
Qual è stato il grado di efficacia dei vari tentativi di “arte pubblica” a Milano? C’è ancora spazio per esperienze del genere? Raccontaci del recente progetto ArtLine, che sembra tornare in quella direzione.
A Milano ho seguito solo un altro progetto di arte pubblica prima di ArtLine, sempre con il Comune: Subway. Nell’estate del 1998, in metropolitana e nelle stazioni ferroviarie, i viaggiatori potevano vedere le opere di giovani artisti e disegnatori di fumetti, trovare piccoli libri di una quindicina di scrittori (questa iniziativa ha avuto poi una sua vita autonoma) e assistere agli spettacoli di gruppi teatrali. Una mostra temporanea forse troppo utopica per il budget a disposizione. Ma è stato un modo per ribadire che l’arte deve rivolgere la sua attenzione anche al di fuori di gallerie e musei.
E per quanto riguarda ArtLine?
Pensato in collaborazione con Sara Dolfi Agostini, ha caratteristiche diverse: l’obiettivo è costruire un percorso artistico permanente, costituito da una ventina di opere di artisti internazionali all’interno di un parco pubblico. Tale proposito pone dei problemi e ha finalità diverse rispetto a un’esposizione temporanea. Tentare di dare forma a questo progetto è un’implicita replica alla tua domanda circa l’esistenza di uno spazio per esperienze del genere; la mia speranza è che si possa dare una risposta affermativa. Milano sta cambiando obiettivi e fisionomia. Le trasformazioni urbanistiche e architettoniche sono soltanto alcune delle più evidenti forme del cambiamento. ArtLine – voluto e pensato in primis dall’assessore alla cultura Filippo Del Corno – si confronta con una delle più ampie trasformazioni urbanistiche della città, quella di CityLife.
Qual è stato il ruolo delle gallerie a Milano negli Anni Ottanta e Novanta? C’è stato un vero momento di svolta, legato al passaggio di testimone rispetto alla vecchia generazione?
In Italia, e a Milano in particolare, le gallerie hanno avuto un ruolo centrale nello sviluppo e nel sostegno dell’arte contemporanea. Tanto che non è pensabile l’arte contemporanea in Italia senza le gallerie private, dato che il ruolo delle istituzioni è stato marginale e, a volte, inesistente. Accanto alle gallerie private vorrei però ricordare l’attività di spazi indipendenti milanesi come Careof e Viafarini, che hanno davvero contribuito alla promozione dell’arte più giovane e che sono diventati un esempio anche per l’apertura di tanti nuovi spazi che hanno arricchito il panorama più recente. Il passaggio di testimone c’è stato quando hanno aperto nel giro di pochissimi anni, alla metà degli Anni Ottanta, un po’ tutte le gallerie che sono ormai considerate storiche, come quella di Massimo de Carlo. Hanno aperto presentando gli artisti giovani, quelli della loro generazione, italiana e straniera. Promuovendoli con tutta l’energia e la convinzione che le animava.
Nelle tue mostre ad Assab One e alla Fabbrica del Vapore sembrava esserci un tentativo di rinnovare la forma tendendo verso un’arte impegnata in modo peculiare, quasi relazionale. Cosa è rimasto di quello slancio? Quali artisti ritieni che abbiano superato il passare del tempo e siano ancora attuali?
Hai ragione: pensa che già nel 1993 avevo curato, a Orzinuovi, una mostra che si intitolava Forme di Relazione. Quella trasformazione di alcuni dei presupposti artistici che Bourriaud ha in modo così efficace delineato nei suoi libri si poteva vedere chiaramente anche in Italia, era nell’aria. E in tante mostre, io come anche altri colleghi curatori o anche galleristi, ho cercato di raccontarla dando spazio agli artisti che mi sembravano più interessanti al riguardo. Allo stesso tempo si cercava anche di lavorare all’interno di nuovi luoghi che non avessero le caratteristiche del white cube tradizionale, anche perché spesso le opere di quegli artisti non nascevano per essere esposte in spazi tradizionali. Credo che molti di loro presentino ancora un lavoro attuale, ma raramente è stata data loro la possibilità di confrontarsi con delle mostre ampie o progetti complessi. Ma si ritorna al problema iniziale del ruolo delle istituzioni.
Si può parlare di una generazione di artisti usciti dalla Milano degli Anni Ottanta e Novanta? O c’è stata dispersione?
Credo che ci sia stata sicuramente una generazione di artisti che ha visto nella città di Milano il luogo più adatto per vivere e lavorare. Anch’io sono arrivato a Milano, venendo da Roma, verso la fine degli Anni Ottanta, attratto dall’attenzione al contemporaneo che questa città dimostrava. In quella generazione, però, i singoli artisti sono rimasti singoli individui e spesso non hanno cercato né voluto presentarsi come gruppi, al contrario di ciò che è avvenuto con l’Arte Povera o con la Transavanguardia. Ci sono stati episodi di comunanza di intenti, basti pensare alla Brown Boveri oppure a Lazzaro Palazzi – per rimanere a Milano – ma erano momenti in cui gli artisti lavoravano uno accanto all’altro all’interno di luoghi che potevano permettere il dialogo e il confronto. Forse sono arrivate troppo presto le gallerie, forse è mancato l’apporto teorico e manageriale di figure come Celant o Bonito Oliva, ma tutte queste condizioni sono state al contempo la forza e la debolezza di quella generazione. Non accettare e cercare di non rimanere ancorati a etichette è stata una loro caratteristica che, tuttavia, se da una parte è stata percepita come limitante, dall’altra, soprattutto come sostegno al mercato, costituisce un’ottima piattaforma contrattuale per la propria carriera. Se pensiamo anche all’attività dei principali musei italiani, possiamo constatare che lo spazio dedicato agli artisti dell’Arte Povera è molto più ampio di quello lasciato a figure più isolate anche se non meno interessanti.
Quale fu il ruolo di Flash Art all’epoca in cui eri caporedattore? C’era un vero dibattito critico a Milano?
Credo che negli Anni Ottanta e Novanta Flash Art, con tutti i limiti di una rivista commerciale, sia stata la più importante fonte di informazione e, almeno in parte, di dibattito per il pubblico italiano (e spesso non soltanto per quello). Il dibattito passava attraverso le pagine delle riviste ma anche attraverso incontri, conferenze, dibattiti pubblici. Leggendo quella situazione a posteriori, in quegli anni è forse mancato il contatto con una ricerca e con un dibattito critico più accademico e più strutturato. L’università ha spesso preso le distanze dalla contemporaneità e questo distacco ha sicuramente impoverito il dibattito critico.
Rapporto con le istituzioni: braccio di ferro e difficoltà o collaborazione proficua?
Chiunque abbia lavorato con le istituzioni, soprattutto i Comuni o le Regioni, sa che si deve passare per un lungo e paziente lavoro. È necessario ricordare che nella maggior parte dei casi gli stessi dirigenti e funzionari si trovano a fare i conti con un sistema burocratico che ostacola qualsiasi iniziativa che esca dalle normali procedure. Le regole di un’istituzione sono costruite per consentire l’attività quotidiana, rifare il manto stradale o permettere l’acquisto di un computer, ma certamente si adattano con fatica, per esempio, per realizzare un progetto di arte pubblica. Indubbiamente questo sistema provoca una serie di danni collaterali, il primo (e forse il minore) dei quali è la lentezza con cui poi si passa dai progetti alla loro realizzazione.
Qual era lo sguardo che intendevi dare sulla città con una mostra come Con altri occhi? Cos’è rimasto di quella esperienza?
Anche quella esposizione, curata nel 2005 assieme a Katia Angelova (che assieme a Angela Maderna sta collaborando ad ArtLine), come le mostre che ricordavi di Assab One o quelle tenutesi alla Fabbrica del Vapore, cercava di presentare le specificità di una nuova generazione, le diversità di approccio e di sguardi presenti in essa, senza tuttavia avere la pretesa di definire una volta per sempre i contorni della generazione stessa. Ognuno di quegli artisti presentava specificità nel modo di vedere e raccontare la sua realtà e nel modo di intendere l’arte. Credo che la diversità, soprattutto in una mostra di artisti giovani, sia un arricchimento per lo spettatore e per gli artisti partecipanti. Sono altrettanto convinto, come già ricordavo, soprattutto per la scarsa importanza che assumono in Italia gli spazi istituzionali, che per il futuro degli artisti coinvolti abbia funzionato maggiormente l’appartenenza a contesti più facilmente riconoscibili e strutturati.
Stefano Castelli
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #30
Abbonati ad Artribune Magazine
Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati