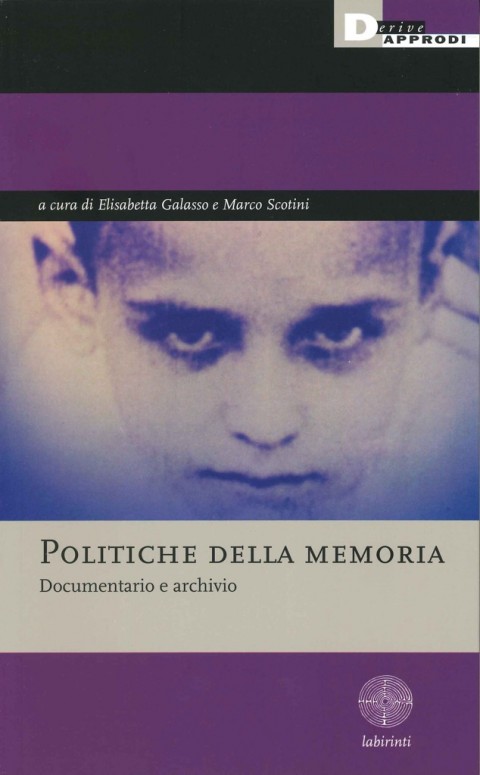Dialoghi di Estetica. Parola a Marco Scotini
Marco Scotini è critico d’arte e curatore indipendente, direttore del Dipartimento di Arti Visive della NABA – Nuova Accademia di Belle Arti e direttore artistico di FM Centro per l’Arte Contemporanea di Milano. Dirige la rivista “No Order. Art in a Post-Fordist Society”, è curatore degli archivi di Gianni Colombo e Piero Gilardi e ideatore della mostra Disobedience Archive, itinerante in diverse sedi internazionali tra le quali Berlino, Eindhoven, Nottingham, Boston e Rivoli.

Curatore della mostra L’Inarchiviabile/The Unarchivable, Italia Anni ‘70, che ha inaugurato FM Centro per l’Arte Contemporanea di Milano, in questo dialogo Marco Scotini ha affrontato temi cruciali per l’epoca attuale: l’eredità delle ricerche artistiche degli Anni Sessanta e Settanta, la configurazione di un nuovo discorso critico sull’arte e il rinnovamento delle pratiche curatoriali in rapporto alla centralità dell’archivio come metodo di indagine di riflessione critica.
Lasciando per un momento ai margini le letture incentrate sulle neoavanguardie e le specificità dei singoli movimenti, credo che sugli ultimi cinquant’anni di produzione artistica sia importante provare a formulare nuove riflessioni, a partire dai modi di fare arte fioriti tra gli Anni Sessanta e Settanta. Qual è la tua posizione in proposito?
Se si dovesse sintetizzare, anche a costo di forzarla, l’intera portata trasformativa di quel periodo, direi che il punto nevralgico (e insuperato) è la critica istituzionale. Che non va però ridotta alle sfide al sistema dei musei e delle gallerie messo in atto dalla prima generazione eroica: con le prese di posizione di Buren, gli svelamenti di Haacke, gli interventi di Asher, le dislocazioni di Smithson o la nostalgia di Broodthaers.
Al centro di questa critica radicale la vera istituzione in oggetto è l’Arte stessa, con la A maiuscola. Dunque non solo i suoi dispositivi di presentazione ma anche le sue assegnazioni di ruoli e funzioni specifiche (l’artista, l’opera, il pubblico ecc). Risulta vero quello che Foucault afferma nel suo corso del 7 gennaio 1976: “Direi che da dieci anni quel che emerge è la proliferante criticabilità delle cose, delle istituzioni, delle pratiche, dei discorsi; una specie di friabilità generale dei suoli”.
Come si riflette nell’arte questa consapevolezza?
Nella dirompenza delle riletture del rifiuto del lavoro di Duchamp, negli slogan di Beuys per cui “ogni uomo è un artista”, negli Oggetti in meno di Pistoletto, nell’Art-Strike di Gustav Metzger, nella delega ai pubblici nelle Esposizioni in tempo reale di Vaccari, nel passaggio al sociale compiuto da tanti artisti, tra cui Gilardi come uno dei maggiori esponenti. Che significa tutto questo “assalto” all’arte? Quali sono i suoi effetti in termini paradigmatici? Da un lato si scopre l’estetizzazione di tutto il reale, per cui ogni cosa appare sempre meno “naturale” e sempre più il risultato di una sedimentazione di segni (una produzione semiotica). Dall’altro lato (e in rapporto a quest’ultimo aspetto) il riconoscimento di una creatività collettiva (o intellettualità di massa) porta a un vero e proprio spostamento di paradigma.
Più che di arte e artisti sarebbe opportuno parlare di funzioni creative trasversali ai differenti modi di fare e ai differenti gruppi sociali. Questo riconoscimento definitivo porta con sé nuovi modi di produzione e nuove forme di espressione che continuano a operare tutt’oggi, grazie anche alla proliferazione dei nuovi dispositivi elettronici. Ma è chiaro che in tutto ciò non avrebbe cessato di far presa la continua ricostituzione di vecchie separazioni disciplinari e assegnazioni funzionali, che ci ha condotto alla schizofrenia odierna, tra neoarcaismi e contemporaneità, come direbbe Maurizio Lazzarato.
Proviamo allora a immaginarci lo scheletro di una simile riflessione. Anzitutto, penso sia cruciale riconoscere quanto segue: attraverso le sperimentazioni di quegli anni, l’arte rinasce. Da una parte, gli artisti ampliano le sue potenzialità virtuali consolidando il suo profondo legame con la finzione. Dall’altra, i nuovi modi di fare arte offrono molteplici prospettive sul nostro mondo e la realtà nelle sue sfaccettature sociali, culturali, relazionali e politiche. Quali altri elementi aggiungeresti ai fini di un nuovo discorso critico sull’arte?
D’accordo con te: è allora che l’arte rinasce! Dalla fine degli Anni Sessanta in poi non è possibile leggere l’arte con gli stessi parametri che sono stati egemoni per tutta la modernità. Questo è tanto più vero adesso che ci troviamo a riscriverne le sue storie, dopo l’apertura dell’ex blocco sovietico e l’emersione sempre più massiccia delle ex colonie (con le loro rispettive archeologie). Anche in questo caso vorrei, se possibile, indicare solo un aspetto rispetto a tutti gli altri che potrebbero aggiungersi.
Questo aspetto, che è tale da aver cambiato la “natura” delle cose nel loro rapporto con le immagini, è la centralità del tempo. Se con quella che ho definito “critica istituzionale in senso allargato” non è più possibile riconoscere identità forti, essenzialistiche, istituite per natura e spazialmente (come dei dati), ciò è perché si finisce sempre per smascherare il carattere fittizio, temporale, convenzionale delle stesse. C’è ora tutta una matrice performativa, temporale, dietro ogni cosa per cui l’immagine non si aggiunge più alla realtà ma ne diventa parte integrante, modulando in maniera diversa il rapporto tra essere e apparenza. In un mondo senza essere e senza identità potrà esserci solo divenire, molteplicità e temporalità quale esclusiva forma di unità del tutto.
In un tuo saggio nel volume Politiche della memoria (Derive Approdi, 2014), hai individuato tre elementi chiave per il rinnovamento creativo contemporaneo: il continuo rimodellarsi delle soggettività in rapporto a una dinamica temporale dettata dalle logiche del sistema capitalista; il tentativo di fissare il presente attraverso la produzione di immagini e, in parallelo, la volontà di svolgere pratiche orientate dal contatto con le “cose” del mondo. Pensi che questi fattori siano altrettanto cruciali per il rinnovamento del ruolo dell’artista (che muta da produttore di forme a operatore estetico ad attivista)?
Certo, pensa all’enorme importanza assunta oggi dal Situazionismo o da Fluxus o anche dalla ripresa del cinema d’archivio degli Anni Settanta di Ken Jacobs o di Gianikian e Ricci Lucchi. Si scopre tutta una plasticità del tempo in cui l’artista può direttamente intervenire e, pure, sotto diversi ruoli. Ma questo tempo non è quello cronologico e lineare della modernità o delle avanguardie storiche, è un tempo qualitativo, soggettivo: un tempo mnemonico. Un tempo, cioè, rimasto orfano anch’esso della Storia con la S maiuscola (altra istituzione modernista per eccellenza) per cui a emergere in forme contingenti è proprio la struttura del tempo storico.
Come ho detto in più occasioni, questo tempo è quello che si articola fra attuale e virtuale e che fa del tempo potenza la nostra posta in gioco più importante. Perciò viene rimessa in discussione anche la nostra idea di contemporaneità e oggi riusciamo a esperire una pluralità di tempi e non più solo uno.
Nelle stesse pagine, scrivi anche che “il reale, di fatto, non è impossibile ma sempre più temporale”. Nel 1973, Gillo Dorfles nel suo Dal significato alle scelte ha rilevato che gli artisti attivi in quel periodo – in particolare gli esponenti delle poetiche concettualiste – introducono come variante nelle pratiche creative la possibilità di simbolizzare il tempo non solo mediante l’uso di immagini ma, soprattutto, attraverso azioni programmate e procedure scandite da ritmi prestabiliti. Quale potrebbe essere il ruolo delle diverse simbologie temporali in rapporto al rinnovamento delle “politiche della rappresentazione” su cui ti sei più volte soffermato con la tua attività curatoriale?
Dopo il libro Politiche della memoria (ora anche nella versione inglese per Archive Books) uscirà in autunno un altro mio volume in francese dal titolo Politiques de la Végétation per Eteropia France. Il motivo del ricorso continuo a questa sorta di prefisso è che non esistono categorie irriducibili o universalistiche, ma che queste sono sempre culturalmente e socialmente costruite all’interno del discorso, come prodotto di particolari luoghi storici e istituzionali oppure come l’esito di forme di esclusione o di modalità di potere.
Ecco che il tempo fa la sua comparsa e denaturalizza ogni marca o segnatura data per certa. Arresta ogni pretesa trascendentale del discorso. Perciò il problema si sposta dalla rappresentazione alla sua accessibilità, ai luoghi d’enunciazione, alla relazione stessa tra rappresentazioni. Senza l’introduzione di una possibile plasticità, o performance, del tempo, nessuna politica della rappresentazione ha senso.
Insieme ai mutamenti delle arti e al rinnovarsi della critica ormai possiamo riconoscere anche il divenire della curatela. Che ruolo ha la possibilità di lavorare metodologicamente su e con l’archivio in rapporto all’evoluzione delle pratiche curatoriali?
L’archivio è uno dei format espositivi che oggi gode di maggior salute e che vede impegnati tanto artisti che curatori, anche perché supera – per sua natura – i confini disciplinari. Per certo, si tratta di un’eredità dell’arte concettuale. Ho cominciato a praticare il modello dell’archivio nel 2004 (prima delle mostre Interrupted Histories e Archive Fever) come un deposito non tanto rivolto al passato e dunque retroattivo ma dotato di un carattere generativo, proprio in rapporto alla trasformazione dei nostri parametri temporali. Di fatto il passato non è mai concluso (mai consegnato a un documento) ma è sempre un qualcosa di potenziale in attesa di farsi attuale. Ma, da un lato, accumulo e proliferazione non fanno, in quanto tali, “archivio”. Neppure lo fa, dall’altro lato, una pretesa sistematizzatrice di taglio enciclopedico.
Ciò che mi affascina nella figura dell’archivio è il suo carattere immanente e la sua esistenza sempre temporanea. Non si tratta cioè solo di contare, ma di raccontare ogni volta in modo differente e discontinuo: de-archiviando e re-archiviando gli stessi materiali. Il “che cosa” delle opere e dei documenti esposti non è mai indipendente dal “come” della loro messa in scena. Ciò dichiara un’instabilità costitutiva del processo di rappresentazione e un’assenza di fondamenti. In fondo, non è la curatela stessa questo tentativo di dare forma provvisoria a un insieme di cose, per cui l’ordine che gli attribuiamo è sempre effimero?
Le due mostre che hai curato al PAV di Torino, Earthrise e la recente EcologEAST, rivelano che oltre alla produzione di forme è anche l’offerta di prospettive concernenti le relazioni sociali, ecologiche e culturali a contraddistinguere parte della produzione artistica contemporanea. Per quanto riguarda invece la dimensione politica, altro tratto che accomuna entrambe le esposizioni, potresti dirci qualcosa di più?
Entrambi i progetti espositivi ricercano all’origine degli Anni Settanta il rapporto tra pratiche artistiche e crisi ecologica, che nella realtà contemporanea ha assunto una dimensione del tutto nuova. Ma lo fanno cercando a Est e a Ovest, al di qua e al di là dell’allora Cortina di ferro. Risulta chiaro in entrambi i casi come tanto il modello capitalista che quello socialista siano insufficienti a misurarsi con le problematiche delle risorse ambientali e del loro sfruttamento, perché tanto l’uno che l’altro si fondano su paradigmi modernisti. Rimane il fatto che un problema come quello ambientale ha caratteri e ripercussioni globali che non possono essere fermati da confini politici ma che politicamente (e non solo scientificamente) vanno trattati. Dunque: a quali immaginari possiamo ancora appellarci?
La mostra L’Inarchiviabile, allestita negli spazi di FM Centro per l’Arte Contemporanea a Milano, permette di cogliere molto bene il profondo legame tra il rinnovamento delle forme di vita e l’ampliamento delle possibilità all’origine della creazione artistica. Quali sono però i tratti specifici delle opere che si pongono al confine tra archiviabile e inarchiviabile?
La mostra appena inaugurata mi sembra un po’ una chiave di volta di tutto quello che ci siamo detti finora. È una sorta di grimaldello per entrare visivamente e plasticamente all’interno dell’eredità che la modernità ci ha lasciato. Che poi sia l’Italia degli Anni Settanta al centro dell’indagine non mi pare un semplice caso. Il laboratorio artistico e sociale italiano è quello che porta alle estreme conseguenze le premesse culturali degli eventi del ’68. Guattari, Deleuze, Godard o Foucault guardano all’Italia di questi anni proprio per questa ricchezza, per questa eccedenza.
Ma allora, cosa significa rileggere questa decade che tanto aspira al “tutto” attraverso la chiave dell’archivio? Archivio non solo come deposito documentale ma piuttosto come qualcosa che fa dell’inventario, dell’atlante e del catalogo la propria matrice operativa? Pensa al libro in mostra di Boetti sulla classificazione dei mille fiumi più lunghi del mondo. Boetti e Annemarie Sauzeau creano un ordine affidandosi alle fonti più attendibili ma che, comunque, difficilmente riescono a concordare sulla esatta lunghezza di ciascun percorso fluviale. Pensa agli “assiomi” di Agnetti, agli alfabeti di Dadamaino, alle strips di Vaccari, ai ruoli del femminile nella tassonomia di Campagnano. Ecco che in Italia più che altrove si interrogano le procedure di liberazione che condurranno alla nascita della moltitudine contemporanea e a praticare la storicità dell’esperienza di ogni cosa.
Se lo strumento d’indagine è qui l’archivio lo è proprio perché esso va liberato dalla sua detenzione, dal suo potere sul documento, dalla sua pretesa imperativa. L’arte italiana degli Anni Settanta si pone dunque nel luogo stesso di ciò che si vuole rovesciare, in quel luogo di autorità che ha la pretesa d’essere l’Archivio, come diretta emanazione dell’archè, del comando patriarcale come tale. La battaglia sarà dura. Ma a una stagione troppo presto archiviata non cesserà di corrispondere una condizione, altrettanto radicale, di costitutiva inarchiviabilità.
Davide Dal Sasso
http://www.naba.it/
http://fmcca.it/
http://www.archivebooks.org/
 1 / 9
1 / 9
 2 / 9
2 / 9
 3 / 9
3 / 9
 4 / 9
4 / 9
 5 / 9
5 / 9
 6 / 9
6 / 9
 7 / 9
7 / 9
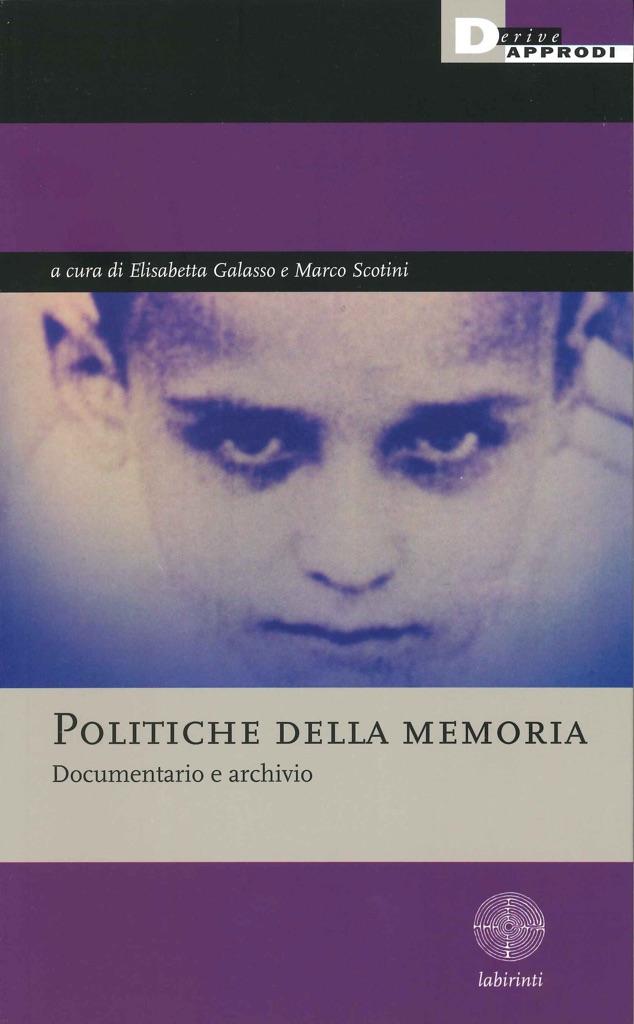 8 / 9
8 / 9
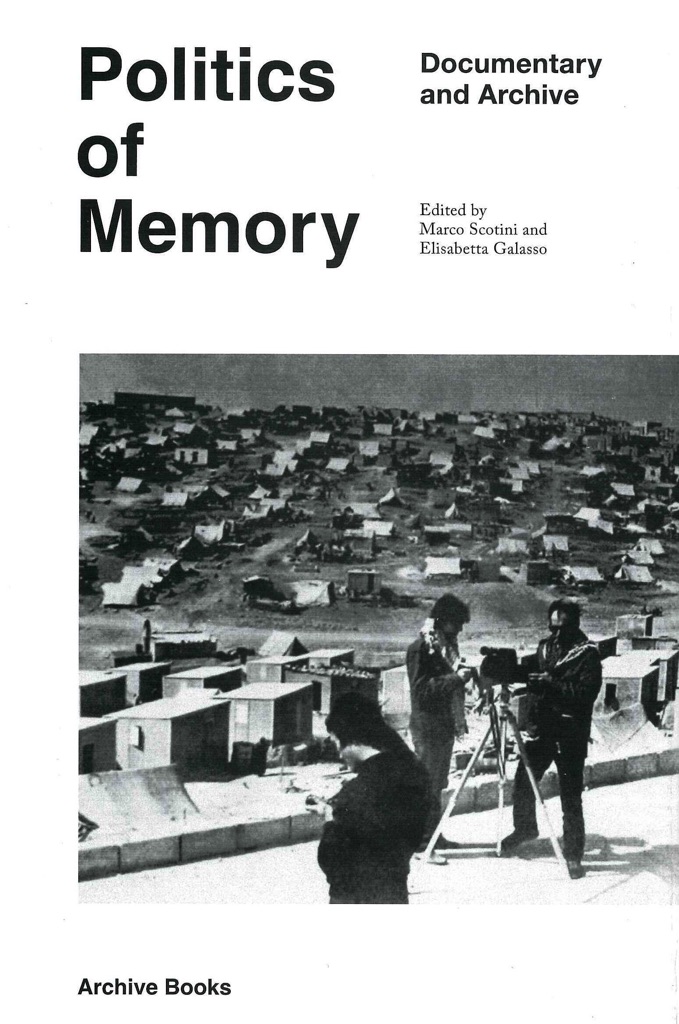 9 / 9
9 / 9
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati