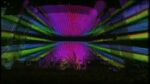“I wanna feel sunlight on my face.
I see the dust-cloud
Disappear without a trace.
I wanna take shelter
From the poison rain
Where the streets have no name
Where the streets have no name
Where the streets have no name.”
U2, Where the Streets Have No Name (1987)
Quelli di Alessandro Bulgini e di Gian Maria Tosatti sono due modi speculari di interpretare l’arte e l’azione artistica. Pur riferendosi, in definitiva, al medesimo contesto (la Jungle di Calais, luogo terribile e splendido, coacervo di culture e di destini, punto di incontro e di collasso in cui precipitano gli accadimenti dell’Europa e dell’Occidente, le loro prospettive, e in cui matura il futuro prossimo con le caratteristiche pratiche, i tratti estetici, le funzioni e gli usi), con esso finiscono per interagire secondo modalità cha sembrano analoghe ma che sono complementari. E che danno conto di un percorso autonomo di ricerca.
***
Where the Streets Have No Name è il modello di tutti i successivi “inizi” degli U2. The Joshua Tree (1987) è l’album della maturità e del successo planetario, il primo capolavoro. Ogni esordio, ogni prima canzone degli album successivi tenterà di riprodurre quell’inizio magico e fortunato – con la lenta introduzione, l’incedere monumentale – così Zoo Station nel 1991, così Zooropa nel 1993. La magnificenza è la cifra di questi brani, insieme con una definita attitudine a stabilire l’impianto tematico che caratterizzerà l’intera opera che segue.
***
La scrittura proviene (necessariamente?) dal di fuori della vita – da una zona esterna, estranea allo scorrere e al flusso dell’esistenza – quando scrivi stai pensando e parlando in realtà da un territorio che non fa parte dell’esperienza quotidiana (infatti, il problema principale di molta letteratura odierna è che la maggior parte degli scrittori – a differenza forse di altre epoche – pretendono di scrivere tutti dentro, dal di dentro, dall’interno, di parlare una lingua comune “diffusa”, quella della “maggioranza”, e pretendono che questo sia non solo un vantaggio pratico – che può essere – ma un vanto culturale, una sorta di “abbattimento-delle-barriere” – quando invece si tratta al massimo di un restringimento, di un rinchiudersi ulteriormente all’interno di confini angusti e anzi di un costruire nuove inutili barriere; invece di sfondare, ma sul serio, quelle che ci sono). La scrittura-dal-di-fuori diventa quindi sempre più impervia, e per questo sempre più interessante e decisiva: “Dentro di noi abbiamo un’Ombra: un tipo molto cattivo, molto povero, che dobbiamo accettare” (Carl Gustav Jung).
***
L’unica verità in fondo è che a luglio, dall’8 al 18, non sono e non siamo mai stati così presenti, così vivi – qui, lì, ora, allora – tutto trascorre, tutto si trasforma, si sgretola e si ricompone – compresi noi e ciò che facciamo o che crediamo di fare – e quello che conta è solo l’attimo, l’apparizione momentanea, living (Parise) – adesso e mai più.
La preparazione può essere lunga, paziente, laboriosa, articolata – l’esecuzione deve essere breve e condensata.
Si crea così una zona che tende a estendersi, ad allargarsi, allontanandosi dal centro – ma partendo necessariamente da esso, e ad esso ritornando periodicamente.
***

U2, The Joshua Tree (1987) – photo Anton Corbijn
A partire da The Unforgettable Fire (1984) inizia per gli U2 un percorso di sperimentazione insieme a Brian Eno e a Daniel Lanois che tocca i suoi apici con l’esplorazione “americana” di The Joshua Tree (1987) e del meno riuscito Rattle and Hum (1988), alla ricerca delle radici musicali e culturali, e successivamente con il trasferimento di questa nuova frontiera in Europa e con l’emersione nell’overground cyberpunk e oscuramente etereo di Achtung Baby (1991) – clamorosa ridefinizione identitaria – e soprattutto di Zooropa (1993).
***
Mentre tutto sta crollando, ci sono due strategie possibili: fronteggiare il crollo, cercando di puntellare e di riparare qua e là, aggiustando, mettendoci una pezza; oppure vivere il crollo, abitare il crollo, essere il crollo – fare cioè del crollo la propria casa. Uno può dire: facile da dire, è magari una cosa bella da scrivere ma molto meno bella da praticare. È vero. Eppure: che cosa stiamo facendo un po’ tutti, se non proprio e precisamente abitare il crollo? Che cos’è in definitiva la “precarietà” se non un crollo organizzato, a cui è stato conferito un minimo di struttura, di articolazione, di tempo, di storia?
La nostra vita forse ha bisogno di familiarizzarsi maggiormente con questo, di scardinare – o quantomeno stemperare – la paura (dell’instabilità), di adottare appieno e consapevolmente un sistema che già esiste nei fatti, in forma rudimentale.
Christian Caliandro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati