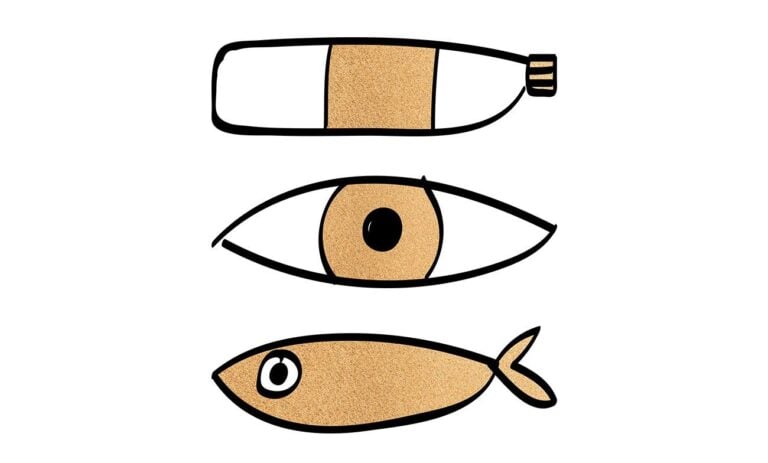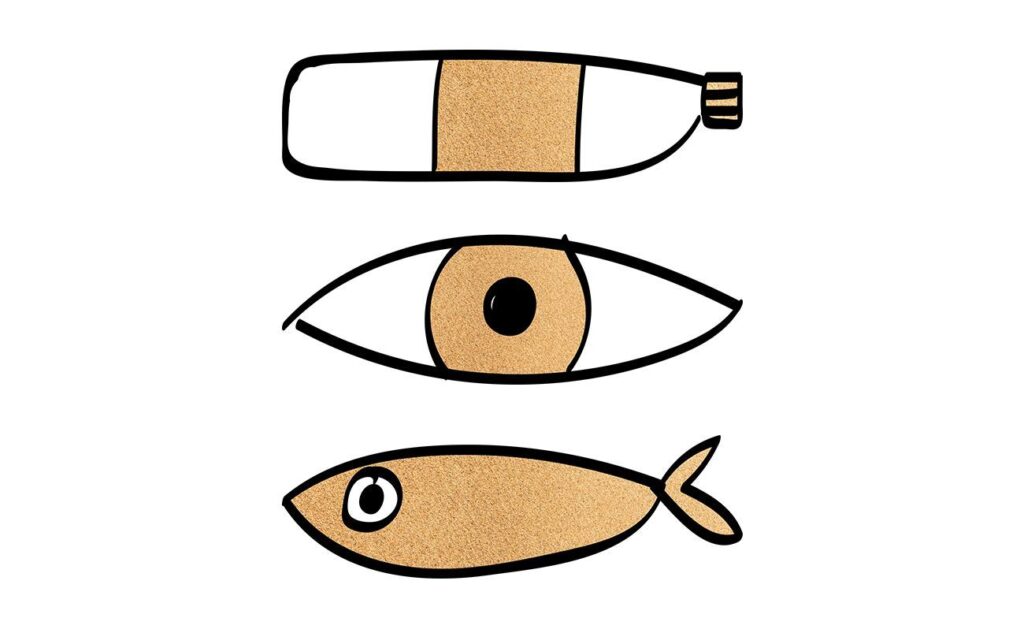
I testi di Kate Fletcher raccolti in questo volume rappresentano uno spunto importante per realizzare quanto, intorno al fenomeno moda, la letteratura accademica, ma ancora di più quella giornalistica, nel nostro Paese da tempo stiano segnando il passo. I saggi scritti tra il 2004 e il 2018 e ora raccolti in Moda, design e sostenibilità impostano questa riflessione allineando tre ambiti ‒ quello tecnico, quello politico, quello estetico – in modo intrecciato, senza possibilità di considerazioni unilaterali.
L’AMBITO TECNICO
Affrontare in modo corretto qualsiasi fenomeno legato al fashion, secondo Fletcher, non può più avvenire ignorando le sfide alla sostenibilità che la produzione di abbigliamento porta con sé. Occorre dunque tenere in considerazione “la tracciabilità della catena produttiva: l’uso efficiente di sorgenti energetiche; acqua e componenti chimici; la sicurezza dell’ambiente di lavoro; l’innovazione nella scelta e nella produzione di materiali, l’implementazione delle pratiche di riciclo; un equo sistema salariale legato all’impatto futuro che la quarta rivoluzione industriale avrà nei processi automatizzati di produzione” (cfr. pag. 7).
Impossibile non concordare con lei. Perché una t-shirt di Hedi Slimane, un paio di sneaker Nike o una cintura di Gucci, replicati in migliaia o centinaia di migliaia di esemplari, proposti in collezioni progettate ogni sei mesi (ma con il fast-fashion ora anche dodici volte l’anno), certamente hanno un impatto non trascurabile sull’ecosistema terrestre.
L’AMBITO POLITICO
Che non è da intendersi come esclusivo appannaggio delle istituzioni nazionali o internazionali, ma riguarda anche le singole scelte aziendali. “La moda è implicata è imlpicta nei sistemi più vasti di controllo e potere dell’epoca moderna… il tipo di moda che viviamo oggi non è scelta liberamente dai cittadini, ma rappresenta spesso l’unica opzione. …
L’AMBITO ESTETICO
La scissione tra funzione (abbigliamento) e desiderio (moda) è per Fletcher una frattura da superare. Scrive la studiosa inglese: “Probabilmente quella della moda è l’industria che più di ogni altra ha perfezionato il ciclo di invenzione, accettazione e scarto di una serie costantemente mutevole di modalità temporanee di immagine. E più di ogni altro è riuscita a sganciare un ciclo di cambiamento dalla necessità fisica o dalla funzione” (cfr pag. 96).
UN CONCETTO SOVVERSIVO
Ci sono due concetti particolarmente originali che emergono da questi scritti. Il “localismo”, intorno a cui la studiosa inglese ha praticato ricerche forse più interessanti per i metodi applicati che per i risultati ottenuti. E un secondo, che ci pare davvero affascinante: la “pratica d’uso”. Per sostenerlo Fletcher ha strutturato un vasto numero di interviste tese a dimostrare che la gente “agisce” i suoi capi di abbigliamento in “modi che sono ingegnosi e motivati da una conoscenza e soddisfazione profonda nei confronti di ciò che possiede” (cfr pag. 103). E questo avviene al di fuori e al di là del compito che chi li ha prodotti aveva loro assegnato, legato esclusivamente all’ideologia della crescita continua del mercato. In un paragrafo intitolato Le storie dei dress code alternativi, Fletcher invita a rivolgere lo sguardo verso i margini del sistema imperante, ricordando che le scelte di ciò che indossiamo risentono delle nostre esperienze passate, dei nostri desideri attuali e delle nostre idee in merito a ciò che saremo in futuro: proprio noi, personalmente, singolarmente, individui con un nome e un cognome e non lo stereotipo stagionale di uomo o donna o transgender che le griffe proiettano sulla superficie dei nostri schermi portatili o fissi. “Le espressioni dei valori, aspirazioni, retaggio, comprensione e della forma fisica del nostro corpo costituiscono una logica dell’abbigliamento che trascende le ristrette visioni commerciali della moda. Tutti questi elementi offrono prospettive più ampie che rispettano la nostra realtà oltre che le nostre aspirazioni, e che mettono in contatto la nostra psiche con le nostre scelte in fatto di fibre e di moda”. (cfr pag. 99). Si tratta di un concetto che, portato alle estreme conseguenze, potrebbe infastidire davvero. E non solo l’industria dell’abbigliamento, ma certamente quella della cosmesi, forse del design e così via.

Kate Fletcher ‒ Moda, design e sostenibilità (Postmedia Books, Milano 2018)
LA PREVEDIBILE REAZIONE
Sono concetti astratti quelli messi in campo in questo volumetto? Si tratta di pura accademia, magari più avanzata rispetto a quella a cui siamo abituati, ma pur sempre accademia? Per niente, perché, grandi e piccoli, conglomerati e singoli marchi stanno reagendo. In modo sparso, ognuno, a modo suo, reagisce. Qualche esempio.
Sul sito del colosso svedese H&M c’è un apposito spazio, Ricicla la Moda!, dedicato a pratiche sostenibili. Con tanto di video emozionale condotto da una voce che pare piuttosto “incazzata” a proposito del consumo e della produzione di rifiuti. E inoltre si legge “Consegna il tuo sacchetto di prodotti tessili usati alla cassa. Accettiamo qualsiasi tipo di prodotto tessile, di qualsiasi marca e in qualsiasi stato di usura, persino calzini spaiati, t-shirt rovinate e lenzuola scolorite. I prodotti tessili andranno all’impianto di trasformazione più vicino per essere smistati manualmente. Per ogni sacchetto che porti alla cassa riceverai un buono sconto da utilizzare sul tuo prossimo acquisto”.
Il massimo dell’ipocrisia? Un marchio leader mondiale del fast fashion che si spaccia per ecologista? Di certo in Svezia il tema è sentito molto più che da noi e H&M si vanta di essere il maggiore utilizzatore mondiale di cotone prodotto in maniera sostenibile. Le sue incursioni nel campo del sociale sono inoltre frequentissime. Nessuno dei grandi gruppi italiani, francesi o spagnoli (Zara), può assolutamente competere.
Scelta strutturale immediatamente trasformata in marketing aziendale appare quella dell’americana Everlane. In una recente intervista rilasciata a Vogue America, il suo fondatore Michael Preysman illustra le caratteristiche del suo progetto di utilizzo della plastica vergine, mentre il sito dell’azienda riporta un terrificante contatore su cui scorre implacabile il numero delle bottiglie di plastica prodotte nel mondo secondo per secondo.
Impossibile non ricordare poi la convinta battaglia personale, oltre che sociale, portata innanzi da anni da Stella McCartney, la prima sulle passerelle più tradizionali ad aver introdotto il tema e a non avere mai mollato la presa. E da ultimo è arrivato il New Global Plastics Economy Commitment, una manciata di marchi tra cui Burberry, H&M, L’Oreal, Selfridges, Stella McCartney, Target e Unilever (lo hanno firmato proprio in questi giorni per reagire a quello che sta succedendo nei mari).
REALTÀ DINAMICA
C’è un’ultima considerazione che questo libro stimola. Kate Fletcher è nata nel 1971 a Liverpool. Attualmente fa parte di un gruppo di ricercatori interpartitico parlamentare sull’etica e la sostenibilità della moda. Insegna al London College of Fashion, ha firmato una cinquantina di pubblicazioni specializzate. È, insomma, un’autorità riconosciuta e si batte per una causa assolutamente condivisibile; non siamo certi, però, che sia perfettamente in contatto con le ultime generazioni di utilizzatori di abbigliamento. Abbiamo trovato importanti le sue riflessioni ‒ soprattutto se paragonate a quanto accade di leggere in Italia. Eppure restiamo convinti che almeno una parte dei più giovani le senta già molto più vicine al proprio vissuto quotidiano di quanto lei stessa parrebbe credere. O forse siamo troppo ottimisti.
‒ Aldo Premoli
Kate Fletcher ‒ Moda, design e sostenibilità
Postmedia Books, Milano 2018
Pagg. 172, € 16,90
ISBN 9788874902077
www.postmediabooks.it
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati