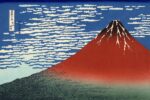Gaetano Cipriani – Inventare il paesaggio
.jpg)
La pittura di Cipriani è tutta dentro la tradizione e usa i suoi stessi modi, magari per colpirla dal di dentro con più sottile crudeltà, ma senza clamore, senza proclami, senza sotterfugi. Egli affronta la superficie come volesse colmare un vuoto.
Comunicato stampa
“Non era più un paesaggio / era un rosso, era un bianco, / era un nero nell’aria”. Così scrive in una breve poesia (una specie di haiku) lo stesso artista Gaetano Cipriani: una autentica dichiarazione di poetica fatta con parole fulminee ed essenziali. Egli infatti nel suo lavoro (non importa se su carta, legno o tela) non si rifà ai tradizionali generi pittorici (come possono essere la natura morta, il ritratto, il paesaggio), perchè non ha nessuna intenzione di compiere un atto mimetico (di imitare la natura, di rappresentare il visibile). Eppure tutti i suoi quadri portano invariabilmente il titolo di “Paesaggio”. E se si ha occasione di passare nella sua sobria casa-studio di Ponton e di vedere una specie di “ziggurat” e una croce di legno appese al muro, ci si sente ribadire che “sono figure create per suscitare un’idea di spessore, un distacco tra la superficie e il fondo”: il che, detto in altre parole, indica la volontà di mettere in campo il senso della profondità, della prospettiva, e, dunque, della veduta (del paesaggio).
Apparentemente può sembrare un trucco intellettuale, un tentativo di mostrare al nostro sguardo una verità nascosta: appunto un paesaggio-non-paesaggio. In realtà la pittura di Cipriani è tutta dentro la tradizione e usa i suoi stessi modi, magari per colpirla dal di dentro con più sottile crudeltà, ma senza clamore, senza proclami, senza sotterfugi. Egli affronta la superficie come volesse colmare un vuoto e muove pennarelli e chine ad una velocità incredibile, anche se sempre con estrema attenzione. Non ha un obiettivo da raggiungere o una forma da definire. Per cui i suoi gesti diventano autentiche correnti di energia che si sovrappongono, si accumulano, si divincolano, fino a creare un microcosmo imprecisato, ma pulsante, irrisolto, ma carico di urgenze.
Potrebbe venire in mente (fatte le debite proporzioni), quel vorticare di linee con cui Giacometti tormentava le sue figure, fino a dissolverle o a ridurle a semplici e inquietanti parvenze nello spazio. Per Cipriani le linee che “girano in giro” non segnano l’inizio di una negazione, il passaggio dall’essere al non essere. Esse alludono piuttosto ad un essere in potenza, ad una forma che cresce, a un corpo che si dilata. In una nota Luigi Meneghelli si è fermato proprio ad analizzare questo stadio del “divenire”: “Le immagini qui non finiscono mai, egli scrive, soprattutto non sono mai una sola: esse creano una dimensione che sembra contenere gli inesauribili racconti della mano, come solo un tappeto orientale può fare”. E in questo ossessivo accumulo di segni, Cipriani arriva indifferentemente a dar vita a luoghi ipotetici, a schizzi cromatici che cerca poi di recintare, o addirittura a rinchiudere l’intera immagine sotto un velo di colore nero. E allora il fascino dell’opera non risiede più solo in quello che sta davanti, ma anche in quello che sta dietro (o attorno): attira più per ciò che nasconde che per ciò che mostra. In fondo, Cipriani ha lo sguardo dei bambini. Come per loro, anche per lui disegnare (o dipingere) è un gioco. Costruisce le cose per il piacere di costruirle. A lui importa “mettere al mondo” un mondo in cui sognare e farci sognare.