Pratiche generative: una reciproca dipendenza fra arte e contesto
Le istituzioni assolvono realmente alla funzione pubblica a loro deputata? È la domanda più urgente, dalla politica internazionale a quella locale. Anche l'ormai variegato mondo delle istituzioni culturali, dunque, con la sempre più spinta convergenza di interessi pubblici e privati, non può fare a meno di riflettere su tale interrogativo nel proprio dibattito interno. Questo almeno è quanto si auspicano gli operatori più disincantati e quanto sta diventando sempre più urgente definire da parte degli spazi indipendenti, che progressivamente si caricano della responsabilità di avviare un dialogo autentico col territorio.

A Bari dal 18 al 21 novembre si sono incrociate due prospettive convergenti sull’attualissima questione nel percorso ideato da vessel, collettivo curatoriale attivo da tre anni nel capoluogo pugliese con l’obiettivo di portare il dibattito internazionale in una delle regioni di frontiera dell’Europa, nel cuore del Mediterraneo.
Il workshop Generative Practices – a cura di Viviana Checchia in collaborazione con Haizea Barcenilla – ha ospitato Galit Eilat e Nina Möntmann come visiting professor per un gruppo di curatori, artisti e architetti (Khedidja Benniche, Alessandra Coretti, Federico Del Vecchio, Chiara Frustaglia, Andrea Hill, Stephanie Noach e la sottoscritta) che ha avviato un lavoro critico di rilettura del ruolo istituzionale nei confronti del contesto di riferimento. Il lavoro collettivo si è proficuamente incrociato, poi, con i laboratori Socially Engaged Art Practices: Nuovi modelli di sostenibilità dell’arte, presentati da Anna Santomauro (sempre per vessel), in partnership con Amarelarte, Ammirato Culture House, Artcore, Damage Good e Manifatture Knos e con la collaborazione di autorevoli esponenti del mondo non profit, nel corso di due intense settimane di talk e streaming. Un progetto tanto più significativo se inquadrato all’interno dell’iniziativa regionale Laboratori dal Basso e supportato da Arti – agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione.

Generative Practices – Bari 2013
La Puglia, infatti, è il perfetto esempio di come ormai le politiche culturali debbano tener conto di due scenari paralleli e sempre più complementari per la produzione artistica contemporanea: quello dei circuiti tradizionali come quello dei modelli innovativi. Se da un lato, infatti, il programma Bollenti Spiriti ha incoraggiato la nascita di diverse associazioni di promozione sociale e culturale, dall’altro resta sempre in sospeso l’annosa questione della Fondazione BAC – Bari Arte Contemporanea, che promuove la costituzione di un nuovo polo museale diviso tra Teatro Margherita, Sala Murat e Mercato del pesce. Un intervento che nei principi possiede un glossario magistralmente aggiornato – da sinergia a rapporto col territorio, laboratorio diffuso, produzione, ospitalità, accesso da parte delle associazioni locali e recupero delle architetture – salvo incagliarsi su un complicato e costosissimo recupero del teatro affidato a David Chipperfield e una modalità di acquisizione della collezione che ha già tristemente dimostrato i suoi limiti in tanti esempi a noi vicini. Se già l’idea di ospitare opere in comodato provenienti da un collezionismo e da una scena artistica completamente slegati dalla Regione può far storcere il naso ad alcuni, l’idea che si faccia attraverso un’open call getta seri dubbi sull’effettiva prontezza di risposta alle necessità della scena artistica locale.
A partire, dunque, dagli iconici esempi europei, come quello del Guggenheim di Bilbao illustrato nella lecture di Haizea Barcenilla, il workshop ha indagato possibili usi strumentali della cultura a favore di un’immediata promozione turistica e massmediatica che poco ha a che vedere con la storia e l’identità dei luoghi. È purtroppo dimostrato dai fatti che simili operazioni siano ben lontane dal rigenerare il tessuto sociale nel lungo termine, ma al contrario si prestano spesso a diventare veicoli di una stereotipizzazione dello standard internazionale e di un’omogeneizzazione diffusa a livello locale.
In apertura di una nuova fase della programmazione europea, in cui gli operatori sono chiamati a riflettere sulla ridefinizione dei propri ruoli nonché sul carattere d’innovazione ed inclusione che i modelli culturali dovrebbero assumere, non ha più senso contrapporre le pratiche sociali alle più consuete occasioni espositive, ma piuttosto porterebbe vantaggio reciproco tentare la via dell’integrazione.

Generative Practices – Bari 2013
Nell’arte, come nella politica, il nodo cruciale da sciogliere sta nella questione della rappresentazione, come l’intervento di Nina Möntmann ha ribadito, gettando una prospettiva illuminante attraverso la teoria del regionalismo radicale. Riassumendo un’idea tanto diffusa quanto articolata, infatti, nel mondo globalizzato i nazionalismi avrebbero perso forza a vantaggio di una narrazione dell’identità che passa prevalentemente attraverso la più fluida cornice di “regione”, sia essa delimitata da fattori geografici, sociali o culturali. Laddove i movimenti Occupy di tutto il mondo hanno dimostrato la scarsa incidenza del modello rivoluzionario su un sistema politico-sociale neoliberalista sempre più ampio e interconnesso, la via della concertazione e di una comune agenda politica sembrerebbe essere l’unica praticabile per un reale cambiamento.
All’eterno crocevia tra critica tout court e attivazione di un dialogo, Galit Eilat ha posto l’accento sull’importanza di curare la consapevolezza sia delle comunità di riferimento che di quella artistica internazionale attraverso una carrellata di progetti che da Liminal Spaces al confine tra Israele e Palestina a Mobile Archive, che incoraggia la creazione di un network tra tutte le istituzioni che lo ospitano, hanno esposto possibili modelli innovativi di circolazione delle opere e di condivisione di esperienza e conoscenza.
Come creare, quindi, un contatto autentico con il proprio contesto? Un interrogativo aperto a più risposte elaborate dall’intero gruppo di partecipanti insieme ai relatori, enucleando alcuni grandi temi come l’approccio interdisciplinare e la necessità di non sostituirsi alla comunità nell’elaborazione di un punto di vista, ma di mantenere il proprio modello quanto più possibile flessibile e aperto al cambiamento in corso d’opera. Una pratica che ovviamente si scontra frequentemente con il problema dell’autorialità, ma che tutto sommato si arricchisce di questa contraddizione per rinnovarsi e orientarsi su un empowering del tessuto sociale nel prendere decisioni condivise.

Generative Practices – Bari 2013
Di qui s’impone una distinzione fondamentale nella terminologia associata al dibattito per consuetudine: Haizea Barcenilla ha sottolineato, infatti, l’opportunità di distinguere tra cosa pubblica e bene comune, nella misura in cui la prima è messa in relazione con una definizione prevalentemente normativa, mentre il secondo si riferisce più che altro al modello gestionale. Da studiosi come Garrett Hardin ed Elinor Ostrom, a collettivi come De Meent e Common Matters, si continua a indicare quello dei Commons come una possibile via d’uscita al problema della rappresentatività, sebbene consapevoli delle difficoltà di gestione ancora da risolvere e della necessità di definizione di criteri adeguati per dimostrarne l’efficacia.
Dal momento che la loro premessa sta in un capitale sociale più che in quello economico, quindi, il network riveste un ruolo cruciale nella sostenibilità dei progetti indipendenti. Daniele Lupo e Lisa Mazza di Lungomare Bolzano ne hanno proposto, infatti, una singolare teorizzazione rispetto alla loro ultima iniziativa Gasthaus. Con la definizione di “ospitalità radicale” hanno così sottolineato un’ultima dimensione rilevante rispetto alla creazione di senso comune: quella della convivialità e della presenza continuativa sul territorio. Tuttavia, non si può ignorare l’influenza che su quest’ultimo aspetto continuano ad avere le risorse reperite ad intermittenza, la gestione virtuosa del budget e la conseguente possibilità di assicurare una produzione costante ed eticamente coerente anche con la tutela dei diritti dei lavoratori dell’arte.
Calza benissimo, quindi, la conclusione con cui Maria Mur Dean, fondatrice del collettivo Consonni, chiosa il suo intervento invitando a non ignorare il fatto che le relazioni sociali siano fortemente determinate anche dalle condizioni di produzione. Una sfida possibile per i curatori e le nuove pratiche artistiche? Forse l’arte non è mai stata così inesorabilmente interna alla società e allo stesso tempo così visionaria, così in apnea e contemporaneamente convinta del suo potenziale.
Nicoletta Daldanise
 1 / 12
1 / 12
 2 / 12
2 / 12
 3 / 12
3 / 12
 4 / 12
4 / 12
 5 / 12
5 / 12
 6 / 12
6 / 12
 7 / 12
7 / 12
 8 / 12
8 / 12
 9 / 12
9 / 12
 10 / 12
10 / 12
 11 / 12
11 / 12
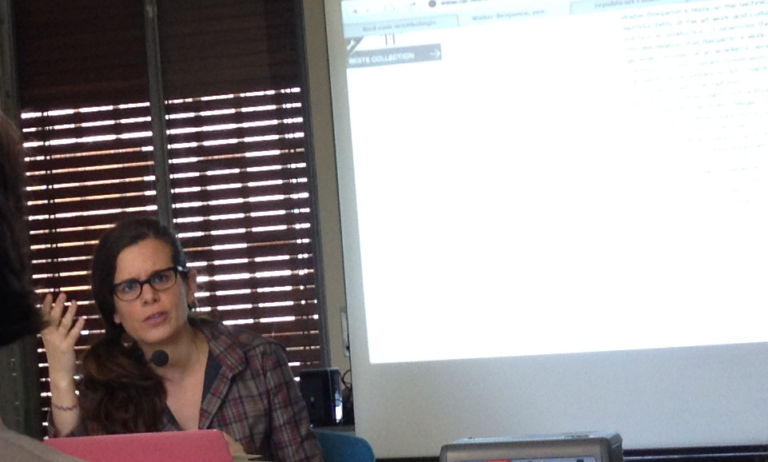 12 / 12
12 / 12
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

















